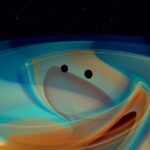BIO – Medicina Costruzione Sociale nella Post-Modernità – Educational Papers • Anno XIV • Numero 55 • Settembre 2025
Sull’importanza o sull’irrilevanza umana guardandoci nello specchio cosmico
Guarda di nuovo quel puntino. È qui. È casa. Siamo noi: un Pale Blue Dot. Queste esclamazioni di meraviglia e sorpresa appartengono alla leggenda narrativa che accompagnò una fotografia del pianeta Terra, scattata nel 1990 dalla sonda Voyager 1, quando si trovava a sei miliardi di chilometri di distanza, ben oltre l’orbita di Nettuno. Si tratta della prima foto del pianeta Terra scattata oltre le orbite di tutti gli altri pianeti del Sistema Solare. L’idea di girare la fotocamera della sonda e scattare una foto della Terra dai confini del sistema solare è stata dell’astronomo Wiliam Anders che l’ha chiamato Earthrise. In seguito della pubblicazione della fotografia, da parte della NASA, essa è stata usata anche da Carl Sagan per il suo libro del 1994 Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space.1

In effetti, questa celebre foto rappresenta il nostro pianeta come un puntino appena percettibile, fortuitamente evidenziato da un raggio di sole che attraversa il nero inchiostro dello spazio, un granello di polvere sospeso in un raggio di sole, come disse Carl Sagan. Ma per trovare quel granello di polvere, bisognava sapere dove guardare. Individuarne la posizione si rivela assai difficile per gli esperti in materia, molte riproduzioni dell’immagine forniscono agli osservatori soltanto un suggerimento utile, in particolare, la Terra sarebbe il puntino bianco-bluastro quasi a metà della fascia di luce più a destra della fotografia. Nonostante gli indizi, c’è grande difficoltà nel localizzare la Terra da tali distanze, sostengono gli studiosi.
Questi pochi dettagli di identificazione e descrizione della foto non costituiscono, senz’altro, il punto di questo breve articolo. In qualità di suo curatore sono intenzionato piuttosto, ad interrogarmi, assieme a voi, lettori, sugli aspetti filosofici che ne derivano, utilizzando gli spunti di Tim Bayne, professore di filosofia alla Monash University di Melbourne, in Australia, e co-direttore del programma the Brain, Mind, and Consciousness [Cervello, Mente e Coscienza] del Canadian Institute for Advanced Research (CIFAR), specialmente appresi dal suo saggio Just a pale blue dot.2
Ciò a cui sono, veramente, interessato è al risvolto filosofico dell’immagine a partire da un interrogativo che ritengo apparentemente inquietante ma pieno di umanità. Tale domanda è: – quando vediamo la Terra come un granello di polvere sospeso in un raggio di sole, cosa possiamo imparare sull’importanza umana?
La cosa sorprendente, ovviamente, è che il Pale Blue Dot [Tenue Puntino Azzurro] è, astronomicamente parlando, un primo piano. Se un’immagine simile fosse stata scattata da uno qualsiasi degli altri sistemi planetari della Via Lattea, a sua volta una delle galassie che contano tra i 200 miliardi e i 2 trilioni nel cosmo, allora non saremmo apparsi nemmeno come un granello di polvere: non saremmo stati affatto catturati dall’immagine.
Se si pensa a questo semplice caso, Pale Blue Dot ispira, in effetti, una serie di sentimenti: stupore, vulnerabilità, ansia. Ma forse la risposta dominante che suscita, in una mente piuttosto sana, potrebbe essere quella della nostra insignificanza cosmica. L’immagine sembra catturare, in forma concreta, il fatto che non contiamo davvero nulla, salvo se collochiamo l’immagine all’interno di una narrativa teologico-metafisica. Se osservassimo Pale Blue Dot per 30 secondi e riflettessimo sulle massime opere dell’umanità come il Taj Mahal, le imprese navali dei primi polinesiani, i dipinti di De Chirico, le invenzioni di Leonardo da Vinci, A Love Supreme di John Coltrane, il teorema di Cantor, la scoperta del DNA e così via, nulla di ciò che abbiamo fatto e facciamo, nulla di ciò che potremmo mai fare, sembrerebbe avere importanza. Pale Blue Dot è per l’impegno umano ciò che il laser della Morte Nera fu per Alderaan.3 Ciò che ci sembra di imparare, quando ci guardiamo allo specchio cosmico, sarebbe che, in definitiva, non siamo più importanti di un granello di polvere.
Confrontate le emozioni suscitate da Pale Blue Dot con quelle suscitate da Earthrise, la prima immagine della Terra scattata dallo spazio4 dallo stesso astronauta William Anders durante la missione Apollo 8 nel 1968, Earthrise raffigura il pianeta come un vortice di blu, bianco e marrone, un’oasi fertile in contrasto con il paesaggio lunare arido che domina il primo piano dell’immagine. Ispirando stupore, riverenza e preoccupazione per la salute del pianeta, il fotografo Galen Rowell l’ha descritta come forse “la fotografia ambientale più influente mai scattata”. Pale Blue Dot è un’immagine molto più ambivalente. Non parla della fecondità della Terra e delle sue capacità di sostenere la vita, ma della sua, e, per estensione, della nostra, insignificanza nella vastità dello spazio.

La sensazione dell’insignificanza cosmica
Ma cosa dovremmo pensare esattamente di Pale Blue Dot? Ci insegna davvero qualcosa di profondo su noi stessi e sul nostro posto nell’ordine cosmico? Oppure la sensazione di insignificanza che genera è una sorta di illusione cognitiva, non più affidabile del breve brivido di paura che si può provare alla vista di un serpente di plastica? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo chiederci perché Pale Blue Dot generi sensazioni di insignificanza cosmica.
Un resoconto delle sensazioni suscitate da Pale Blue Dot inizia nel XVII secolo, con lo scienziato e filosofo Blaise Pascal. Pascal nacque nel 1623, appena 14 anni dopo che Galileo aveva puntato il primo telescopio verso il cielo. Le osservazioni di Galileo non solo confermarono la concezione eliocentrica del sistema solare di Copernico e rivelarono “imperfezioni” nei corpi celesti (come i crateri e le montagne della Luna), ma rivelarono, addirittura, innumerevoli stelle invisibili a occhio nudo. Fu un momento di profondo sconvolgimento per l’auto-comprensione dell’umanità, e molte delle riflessioni riportate nei Pensieri di Pascal, una serie di appunti pubblicati solo dopo la sua morte, sembrano essere state stimolate dalla nuova astronomia:
Quando considero il breve arco della mia vita assorbito nell’eternità precedente e successiva… il piccolo spazio che occupo e che persino posso vedere, inghiottito dall’infinita immensità di spazi di cui non so nulla e che non sanno nulla di me, sono terrorizzato e sorpreso di trovarmi qui piuttosto che là, perché non c’è ragione per cui debba essere qui piuttosto che là, perché ora piuttosto che allora. Chi mi ha messo qui? Per ordine di chi e per decisione di chi mi sono stati assegnati questo luogo e questo tempo?5
Ma è questo verso dei Pensées, “L’eterno silenzio di questi spazi infiniti mi atterrisce”, che forse cattura al meglio la sensazione di insignificanza cosmica. In effetti, il verso potrebbe benissimo fungere da didascalia per il Pale Blue Dot. Per Pascal, il cielo notturno non era semplicemente maestoso: era terrificante. Ed era terrificante non (solo) perché era infinito, ma perché era “silenzioso”.
Pascal non ci dice cosa intendesse con il silenzio dello spazio, ma c’è motivo di sospettare che almeno parte della risposta sia teologica. L’universo accogliente e ben ordinato della visione del mondo del Medioevo era stato sostituito da un universo che non solo era immensamente più grande, ma sembrava anche governato dal caso e dalla contingenza.“Chi mi ha messo qui?”, chiede Pascal. “Forse nessuno”, si può quasi sentirlo rispondere. Il silenzio dello spazio è il silenzio dell’Universo in risposta alla domanda su Dio. È il terrore dello spazio di Pascal che ha riverberato nel corso dei secoli.
Naturalmente, Pascal stesso non era ateo, e ci sono passaggi nei Pensées [Pensieri] che suggeriscono un atteggiamento molto diverso nei confronti della vastità dello spazio:
Contempliamo dunque l’intera natura nella sua piena e possente maestà, ignoriamo gli umili oggetti che ci circondano, guardiamo questa luce scintillante, posta come una lampada eterna a illuminare l’universo. Lasciamo che la Terra ci appaia come un puntino in confronto al vasto arco descritto da questa stella, e restiamo sbalorditi dal fatto che questo vasto arco non sia altro che un delicato puntino in confronto all’arco circondato dalle stelle che tracciano cerchi nel firmamento.6
Pascal prosegue suggerendo che il fatto stesso che la nostra immaginazione “si perda” di fronte a tali pensieri sia di per sé “il segno più percepibile della travolgente potenza di Dio”.7
Ma è il terrore dello spazio di Pascal ad aver riecheggiato nel corso dei secoli. Se ne può udire l’eco nel romanzo di Joseph Conrad Il caso(1913),8 in cui il narratore descrive “una di quelle notti rugiadose, limpide e stellate, che opprimono il nostro spirito, schiacciano il nostro orgoglio, con la brillante evidenza della terribile solitudine, dell’oscura e disperata insignificanza del nostro globo, perso nella splendida rivelazione di un universo scintillante e senz’anima”.
Ecco, quindi, perché Pale Blue Dot suscita le sensazioni che suscita. Indica (oppure ci ricorda?) che siamo soli. L’Universo non è il prodotto di un piano divino; o almeno, se lo fosse, non sarebbe un piano che prenda sul serio i nostri interessi.
Supponiamo, anche solo per amore di discussione, che questa spiegazione contribuisca almeno in parte a spiegare perché Pale Blue Dot susciti le sensazioni che suscita. Cosa dovremmo allora pensare di queste sensazioni?
Questo, ovviamente, si basa sulla questione di come l’inesistenza di Dio influisca sul significato umano. Alcuni presumono che Dio sia necessario per il significato cosmico. Nulla potrebbe davvero avere importanza in un mondo senza Dio, e se nulla ha davvero importanza, allora noi non contiamo. Se così fosse, le sensazioni suscitate da Pale Blue Dot non sarebbero illusorie. Al contrario, rivelerebbero una verità profonda, e forse profondamente inquietante: da un punto di vista cosmico, siamo davvero insignificanti.

Ma l’idea che il significato richieda Dio è profondamente sconcertante. Se la bellezza, la conoscenza e la creatività che vediamo intorno a noi non contano di per sé, come potrebbe aiutarci l’aggiunta di Dio? In effetti, è sicuramente più plausibile supporre che sia la presenza di Dio, piuttosto che la sua assenza, a rappresentare la minaccia più seria al significato umano. Dopotutto, la bellezza, la conoscenza e la creatività che abbiamo prodotto impallidiscono sicuramente in confronto a quelle tradizionalmente attribuite a Dio. Come direbbe un salmista del XXI secolo, qual è lasomma totale della conoscenza umana se confrontata con la saggezza di Dio? Qual è la bellezza del Taj Mahal, di “A Love Supreme” o dei dipinti diO’Keeffe se confrontati con la grandiosità della Nebulosa Testa di Cavallo nella costellazione di Orione?
La teologia come fucina fornitrice di senso e significato ma le modalità ordinarie di sperimentare lo spazio e il tempo sono strutturate a misura del corpo umano
La salienza è importante perché è un segnale che proviene dai nostri sensi: “Questo è significativo, prestagli attenzione”. Fin dalla nascita, i nostri sensi ci avvertono della presenza di caratteristiche che sono importanti per noi: i volti umani, la voce di nostra madre, il linguaggio di chi ci circonda.I meccanismi che tracciano la salienza percettiva si evolvono con il nostro sviluppo, ma continuano a funzionare come sentinelle, allertandoci su ciò che conta. L’odore di fumo, le sirene rumorose, i movimenti improvvisi: questi fenomeni attirano tutti l’attenzione. Non importa quanto sia coinvolgente la tua conversazione attuale, se qualcuno dall’altra parte della stanza pronuncia il tuo nome, avrai difficoltà a non sintonizzarti e a origliare la sua conversazione. Il corollario, ovviamente, è che ciò che non cattura l’attenzione non ci appare significativo. E la Terra, così come appare in Pale Blue Dot, è praticamente il meno appariscente, il meno accattivante, il più trascurabile possibile. (In effetti, persino l’accenno di salienza percettiva, cioè il raggio di sole in cui è sospesa la Terra, non è una caratteristica reale della posizione della Terra nel cosmo, ma un artefatto dell’immagine stessa.) Pale Blue Dot sembra catturare il fatto che, da un punto di vista veramente oggettivo, la vista dal “nulla”, come potremmo dire, non cattura l’attenzione. E se non catturiamo l’attenzione (è naturale supporre), allora non siamo veramente significativi.
Ma se questa decifrazione spiega perché Pale Blue Dot susciti sensazioni di insignificanza cosmica, mostra anche perché queste sensazioni non siano del tutto affidabili. Pale Blue Dot può anche essere stato scattato da una distanza di 6 miliardi di km, ma non offre una visione del cosmo con l’”occhio di Dio”. È, ovviamente, un’immagine, e ogni immagine nasconde tanto quanto rivela.
Torniamo al contrasto tra Pale Blue Dot e Earthrise. Pale Blue Dot rivela qualcosa (anche se solo un po’) della vastità del cosmo in cui si trova la Terra; Earthrise nasconde questo fatto. Ma Earthrise rivela caratteristiche che sono nascoste da Pale Blue Dot: le capacità della Terra di supportare la vita. Nessuna delle due fornisce l’”immagine completa” della Terra dallo spazio: non esiste un’immagine del genere. Una volta compreso questo fatto, possiamo iniziare a considerare nuove prospettive sulla questione del significato cosmico.
Altre congetture sul significato cosmico dell’insignificanza astronomica della Terra
Eccone una. Supponiamo che la Voyager 1 fosse stata equipaggiata con un dispositivo progettato per rilevare pianeti che supportano la coscienza. E supponiamo che le immagini prodotte da questo dispositivo ne abbiano segnalato la presenza con pixel rosso vivo. Se la Voyager avesse puntato la sua “telecamera della coscienza” verso la Terra, avremmo attirato l’attenzione come lo stridio di una sedia in un’esecuzione di 4’33” di John Cage. Le emozioni suscitate da Punto Rosso Brillante (come potremmo chiamare questa immagine) sarebbero sicuramente molto diverse da quelle suscitate da Punto Blu Pallido. “Piccolo”, potrebbe sembrare dire l’immagine, “ma enormemente significativo”.
Significa forse che siamo significativi? Forse no. Supponiamo di usare la nostra “camera della coscienza” per mappare non solo il nostro angolo del sistema solare, ma l’intero Universo. Che tipo di immagine potrebbe produrre?
Una possibilità è che la Terra emergerebbe come l’unico puntino rosso in una vasta distesa di oscurità. (“Niente come noi da nessuna parte”, potremmo dirci con giustificato orgoglio). Ma le probabilità che ciò accada sono sicuramente basse, forse addirittura nulle. Gli astronomi suggeriscono che potrebbero esserci fino a 50 quintilioni. (50.000.000.000.000.000.000.000) di pianeti abitabili nel cosmo. Quale percentuale di questi pianeti effettivamente ospita la vita quale la conosciamo noi? E, di quelli che ospitano la vita, quale percentuale ospita la vita cosciente? Non lo sappiamo. Ma supponiamo che la coscienza si trovi solo in uno su ogni miliardo circa di pianeti che supportano la vita, anche con questa ipotesi relativamente conservativa, potrebbero esserci fino a 50 miliardi di pianeti che supportano la coscienza. La Terra, vista attraverso la nostra fotocamera della coscienza, sarebbe solo un puntino rosso in più in una vasta nuvola di tali puntini. La creatività umana potrebbe essere ineguagliata su questo pianeta; potrebbe persino essere senza pari nel braccio di Orione della Via Lattea. Ma, dati i numeri e fuori della nostra presunzione è molto improbabile che possiamo in qualche modo considerarci attraenti da un punto di vista cosmico. Detto in un modo più velato e aperto all’interpretazione del lettore: Quando vediamo il pianeta Terra come granello di polvere sospeso in un raggio di sole, cosa impariamo sull’importanza umana?
È chiaro che la superbia a cui potrebbe portare la negazione o non accettazione della nostra insignificanza cosmica, reca tante conseguenze negative. Perciò i greci fecero di questa tracotanza il tema centrale della tragedia. Perciò ipotizziamo che la nostra “naturalizzazione” nell’esistenza intensa nei limiti della specie nella precarietà del pianeta Terra non possa che giovare la nostra esistenza depauperata da tante allucinazioni teologiche metafisiche.
- Ballantine Books, 1997.
- Ibidem
- Il laser della Morte Nera, la stazione spaziale dell’Impero Galattico, fu usato per distruggere il pianeta Alderaan. Questo evento, avvenuto all’inizio della trilogia originale di Guerre Stellari, fu un atto di pura brutalità e fu utilizzato dal Grand Moff Tarkin per dimostrare la potenza della Morte Nera a Leila. Alderaan fu sbriciolato in pochi istanti, causando la morte di miliardi di esseri viventi e generando un immenso disturbo nella Forza, come avvertito da Obi-Wan Kenobi. In poche parole, il laser della Morte Nera era l’arma che distrusse Alderaan.
- Come una foto non pianificata dell’Apollo 8 ha cambiato la prospettiva dell’umanità sulla Terra. Lanciato nel dicembre 1968, l’Apollo 8 fu il primo volo con equipaggio a raggiungere la Luna, orbitare attorno ad essa e tornare sulla Terra. L’obiettivo principale della missione era preparare un eventuale allunaggio; tuttavia, il volo è oggi ricordato soprattutto per gli scorci ineguagliabili della Terra che offrì e, in particolare, per l’iconica fotografia scattata dall’orbita lunare, diventata nota come “Earthrise”. In concomitanza con il 50° anniversario dell’Apollo 8, questo documentario del regista Emmanuel Vaughan-Lee presenta interviste ai membri dell’equipaggio Frank Borman, James Lovell e William Anders, che scattarono la famosa foto. Riflettendo sull’esperienza che cambiò la loro vita, quella di essere stati i primi a vedere la Terra da fuori la sua orbita, nel vuoto nero inchiostro dello spazio, raccontano come quella foto non pianificata divenne l’eredità più duratura della loro missione e diede loro una nuova consapevolezza del loro pianeta natale. “L’Alba della Terra” è la fotografia realizzata da William Anders, uno degliastronauti dell’Apollo 8, il 24 dicembre 1968. Fu la prima fotografia a mostrare il nostro pianeta dall’orizzonte di un altro mondo. La missione Apollo 8 fu la prima con equipaggio a bordo a raggiungere l’orbita lunare. Mentre l’astronave usciva dal lato nascosto della Luna, davanti agli occhi dell’equipaggio si aprì un nuovo orizzonte; una linea curva di lande secche, grigie, ammaccate dai crateri, sulla quale sorgeva un’alba che nessun occhio aveva mai ammirato. Gli astronauti a bordo afferrarono le macchine fotografiche e scattarono.Sulla pellicola di William Anders rimase così impressa la prima foto icona della conquista spaziale americana: “Earthrise”, l’Alba della Terra. La foto divenne un simbolo anche per i neonati movimenti ambientalisti. Lo stesso WILLIAM ANDERS ebbe a dire, di quella missione: “Siamo andati fino alla Luna per scoprire la Terra”.
- Blaise Pascal. Pensées and Other Writings. Translated by Honor Levi. Edited with introduction and notes by Anthony Levi. Oxford University Press, 08 May 2008.
- Ibidem
- Ibidem
- Joseph Conrad. Il caso. Un racconto in due parti. Traduzione di Richard Ambrosini. Adelphi eBook, 2013.