BIO – Medicina Costruzione Sociale nella Post-Modernità – Educational Papers • Anno XIV • Numero 54 • Giugno 2025
Casualità e caos: come una vacanza di una coppia ha causato la morte di 100.000 persone!
Se potessi tornare indietro, all’inizio della mia vita e, poi, premere play, tutto andrebbe allo stesso modo? Oppure, se facessi una telefonata accidentale o smarrissi un’uscita dall’autostrada, potrebbe cambiare non solo la mia vita, ma la storia stessa?
Con questo tipo di domande di rappresentazione fantascientifica, che godono di simpatia popolare, Brian Klaas, professore associato di politica globale presso l’University College of London e ricercatore affiliato presso Oxford University, cerca di attrarre il lettore, con un’attenzione, alquanto soggettiva, al suo ultimo libro Fluke: Chance, Chaos, and Why Everything We Do Matters [Colpo di fortuna: caso, caos, e perché tutto ciò che facciamo sarebbe importante].1
Brian Klaas è uno dei tanti studiosi che, trimestralmente, vengono fatti conoscere ai lettori di BIO Educational Papers, attraverso la rubrica Filosofia e storia della scienza. In Fluke o Colpo di fortuna, lo studioso sociale, che adora decostruire miti, si tuffa nel fenomeno della casualità e del caos che può minare la versione ordinata e pulita della realtà che la maggior parte delle culture costruiscono e condividono come ordine sociale. L’argomentazione del suo saggio consiste in farci capire che noi umani ignoreremmo, volontariamente, una verità sconcertante: se non fosse per qualche piccolo cambiamento, le nostre vite (e le nostre società) potrebbero essere, radicalmente, diverse.
Con tanta informazione in circolazione a disposizione e offrendo una prospettiva completamente nuova, Fluke o Colpo di Fortuna esplora il modo in cui funziona, per davvero, il nostro mondo, guidato da strane interazioni ed eventi, a prima vista casuali, marginali. In quest’ordine di idee, si pone la questione su come possa accadere che la vacanza di una coppia, indirettamente, causi la morte di 100.000 persone. Rebus che verrà spiegato più avanti. Oppure, ci si chiede se la nostra decisione di premere il pulsante snooze al mattino possa alterare, radicalmente, la traiettoria delle nostre vite. O anche, se l’evoluzione di noi, umani, sia stata inevitabile o forse siamo, semplicemente, il prodotto di una serie di strani incidenti. Tutte domande sfolgoranti ma che molto probabilmente verranno dimenticate. Basandosi su scienze sociali, teoria del caos, storia, biologia evolutiva e filosofia, l’ottimista Klaas offre una visione argutamente innovativa del perché le cose accadono, offrendo al contempo le sue soggettive lezioni sconvolgenti su come forse si possa vivere in modo più ingegnoso, oppure essere più felici e condurre vite più appaganti.
Comunque, Klaas voglia rendere colorita la situazione per sdrammatizzare le nostre incertezze, il suo ritratto dei cosiddetti scienziati sociali, sarebbe un quadro in cui questi personaggi si aggrappano a semplici modelli di realtà, con risultati disastrosi. Invece, dovrebbero, nel pensiero di Klaas, abbracciare le possibilità che schiude la teoria del caos.
Il mondo sociale non funziona come pretendono giornalisti, politici ed altri stipendiati
A ben guardare, in effetti, il mondo sociale non funziona come pretendono i giornalisti, i politici e i gli studiosi asserviti alle loro piattaforme. E nemmeno come pretendiamo noi. Troppo spesso siamo portati a credere che ci sia un sistema strutturato e ordinato, definito da regole e modelli chiari. L’economia, a quanto pare, in tal mondo di modelli certi, funziona su curve di domanda e offerta. La politica è una scienza. Perfino le convinzioni umane possono essere tramate, ordite, rappresentate graficamente. E usando la giusta regressione potremmo, secondo Klaas, addestrare, addirittura, gli elementi più sconcertanti della condizione umana. All’interno di questo paradigma dominante e altezzoso delle scienze sociali, il nostro mondo viene trattato come se potesse essere compreso, controllato e piegato ai nostri capricci.
In effetti, come propone Klaas,2 la nostra storia è stata una lotta infinita, ma inutile, per imporre ordine, certezza e razionalità a un Universo definito da disordine, caso e caos. E, nel XXI secolo, questa tendenza sembra, paradossalmente, solo aumentare, man mano che le calamità nel mondo sociale diventano più imprevedibili.3 Dall’11 settembre 2001 alla crisi finanziaria del 2008, dalla primavera araba all’ascesa del populismo, e da una pandemia globale a guerre rovinanti, il nostro mondo moderno sembra incline a “shock” più disastrosi che mai. Sebbene abbiamo montagne di dati e modelli sofisticati, sottolineando ciò che Klaas ci comunica, evidentemente, non siamo diventati molto più bravi a capire cosa incombe dietro l’angolo. Le scienze sociali, a parer suo, hanno fallito, completamente, nell’anticipare questi fulmini a ciel sereno. Infatti, la maggior parte dei tentativi rigorosi di comprendere il mondo sociale ignora, semplicemente, la sua qualità caotica, liquidandola come rumore, così possiamo stipare le nostre realtà complesse in modelli più ordinati e puliti. Ma quando si osserva più da vicino la natura sottostante della causalità, diventa impossibile ignorare il ruolo dei colpi di fortuna e degli eventi casuali. A questo proposito, Klaas si chiede, coerentemente, se i nostri modelli sociali non dovrebbero prendere il caos più seriamente.
Il problema quasi certo al riguardo è che gli scienziati sociali non sembrano sapere come incorporare la non linearità del caos. Perché come possono discipline come psicologia, sociologia, economia e scienze politiche anticipare gli effetti di cambiamenti nel mondo da qualcosa di piccolo come un giorno di visite turistiche o una effimera nuvola di uccelli in volo?
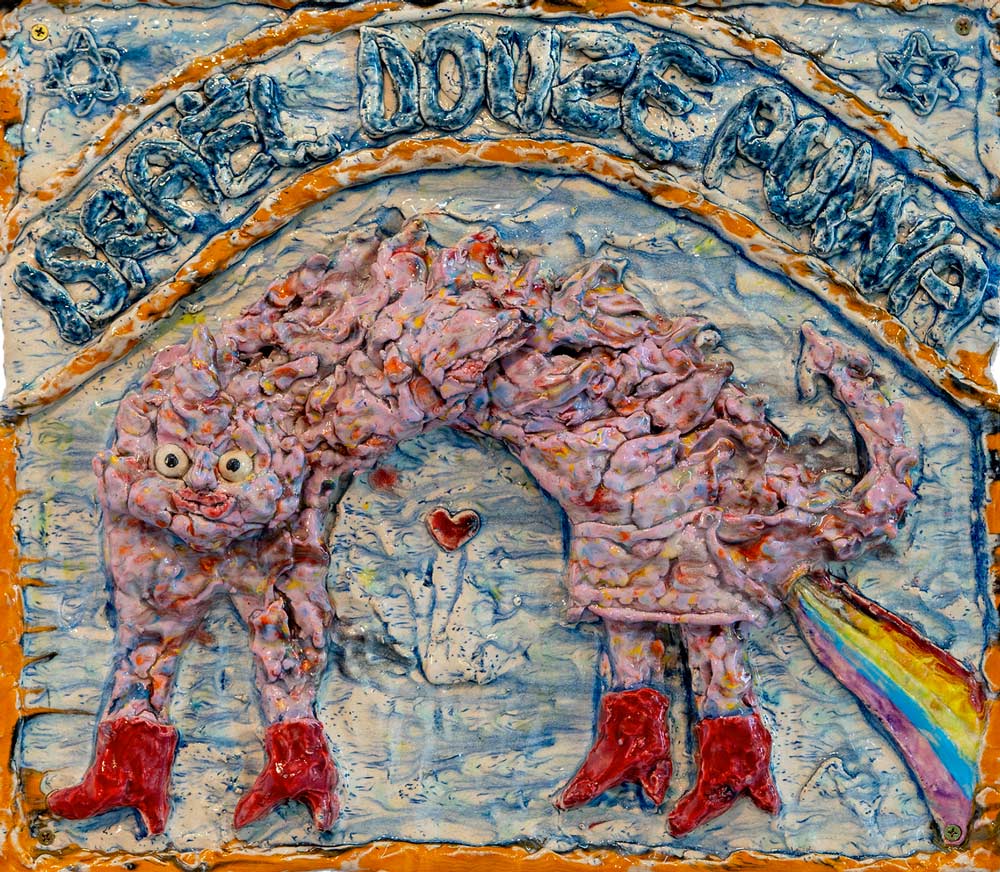
Henry e Mabel Stimson, coppia americana in vacanza, ha causato 140.000 morti ad Hiroshima!
Una vera sfida insensata, al nostro modo di ragionare comune, inizia il 30 ottobre 1926, giorno in cui Henry e Mabel Stimson scesero da un treno a vapore a Kyoto, in Giappone, e misero in moto una catena ininterrotta di eventi che, due decenni dopo, avrebbero portato alla morte di circa 140.000 persone in una città a più di 300 km di distanza. La coppia americana avrebbe iniziato la sua breve vacanza nell’ex capitale imperiale del Giappone camminando dallo scalo ferroviario alla loro stanza nel vicino Miyako Hotel. Era autunno. Gli aceri erano diventati cremisi e gli alberi di ginkgo erano esplosi in una tonalità di giallo dorato. Henry Stimson descrisse una “bellissima giornata dedicata alle visite turistiche” nel suo diario, stando a quanto riporta Klaas.
Diciannove anni dopo, al suo quarto anno come segretario di stato americano, Stimson era diventato Segretario alla Guerra degli Stati Uniti, il capo civile che supervisionava le operazioni militari nella Seconda Guerra Mondiale, e presto si sarebbe unito a un comitato clandestino di soldati e scienziati incaricato di decidere come usare la prima bomba atomica. Una città giapponese soddisfaceva diversi requisiti: l’ex capitale imperiale. Il Target Committee avrebbe concordato che Kyoto doveva essere distrutta. Avrebbero elaborato una mappa tattica del bombardamento e avrebbero deciso di puntare proprio allo scalo ferroviario della città, proprio dietro l’angolo del Miyako Hotel dove gli Stimson avevano soggiornato nel 1926.
Stimson avrebbe implorato il presidente Harry Truman di non bombardare Kyoto. Avrebbe inviato dei cablogrammi di protesta e i generali avrebbero iniziato a riferirsi a Kyoto come alla “città preferita” di Stimson e consorte, stando alla narrativa di Klaas. Alla fine, Truman acconsentì, rimuovendo Kyoto dalla lista degli obiettivi. Il 6 agosto 1945, Hiroshima fu, invece, bombardata. Con un’argomentazione tale, potremmo chiederci con Klaas, se eventi così casuali o occasionali ebbero l’effetto di realtà di aver causato così tante morti. Come possiamo allora predire il destino della società umana?
Nel racconto di Klaas, la successiva bomba atomica era destinata a Kokura, una città sulla punta dell’isola meridionale giapponese di Kyushu. La mattina del 9 agosto, tre giorni dopo la distruzione di Hiroshima, furono lanciati sei bombardieri B-29 statunitensi, tra cui l’aereo d’attacco Bockscar. Verso le 10:45, Bockscar si preparò a sganciare il suo carico utile. Ma, secondo il registro di volo, l’obiettivo “era oscurato da una fitta foschia e fumo al suolo”. L’equipaggio, avrebbe deciso, di non rischiare di sganciare accidentalmente una bomba atomica in un punto sbagliato. Bockscar si diresse, quindi, verso l’obiettivo secondario, Nagasaki. Ma anche questo era oscurato. A corto di carburante, l’aereo si preparò a tornare alla base, ma una momentanea pausa tra le nuvole diede al bombardiere una chiara visuale della città. All’insaputa di chiunque si trovasse sotto, Nagasaki fu bombardata a causa delle nuvole di passaggio su Kokura. Ancora oggi, i giapponesi chiamano “fortuna di Kokura” quando qualcuno sfugge a un disastro senza saperlo.
Circa 200.000 persone sono morte negli attacchi di Hiroshima e Nagasaki, e non di Kyoto e Kokura, in buona parte a causa, della vacanza di una coppia, due decenni prima, e di alcune nuvole passeggere. Ma se tali eventi incidentali, giudicandoli senza un’etica metodologica, sono stati capaci di causare così tante morti e cambiare la direzione di una guerra distruttiva a livello mondiale, come potrebbero studiosi dei sistemi social o eccezionali cittadini, comprendere o prevedere il destino della società umana? Se lo chiede Klaas sconcertato. Dove, per cortesia, nei modelli di cambiamento sociale, dovremmo tracciare le variabili per gli itinerari di viaggio dei potenti e delle nuvole? Negli anni ‘70, il matematico George Box4 ironizzò dicendo che tutti i modelli sono sbagliati, ma alcuni sono utili. Ma oggi, molti dei modelli che si utilizzano per descrivere il nostro mondo sociale non sono né giusti né utili. Esiste, secondo Klaas,5 un modo migliore per descrivere il nostro mondo che non comporta una vana ricerca di schemi regolari nella complessità esasperante della vita. Tale metodo, piuttosto, puntualizza Klaas, senza speranza, comporta imparare a navigare nel caos dei nostri mondi sociali.
Newton riteneva plausibile che la nostra ignoranza fosse provvisoria: ricerca di modelli, regole e leggi
Si può, pacificamente, ipotizzare che prima della rivoluzione scientifica, noi umani, in generale eccettuando le élite culturali e militari, avevamo pochi modi per comprendere con rigore perché le cose ci accadessero. – “Perché quella tempesta ha affondato proprio la nostra flotta?” Ora, possiamo congetturare, una domanda alla quale, coerentemente, si poteva dare una risposta facendo unicamente riferimento agli dei o, in seguito, a Dio, con il dominio dell’Europa. Poi, nel XVIII secolo, Isaac Newton introdusse un quadro in cui tali eventi potevano essere spiegati attraverso leggi naturali, come indica Klaas. Con l’individuazione della nozione della gravità, la scienza trasformò i meccanismi precedentemente indecifrabili dell’Universo fisico (il cambiamento delle maree, i movimenti celesti, la caduta di oggetti) in problemi che potevano essere indagati. La fisica newtoniana contribuì a spingere le idee umane sulla causalità dall’inconoscibile al semplicemente sconosciuto. Un mondo governato dagli dei, è necessariamente, fondamentalmente inconoscibile per i semplici mortali, ma, con le equazioni di Newton, divenne possibile immaginare che la nostra ignoranza fosse temporanea. L’incertezza, abbiamo ingenuamente creduto, poteva essere uccisa con l’ingegno intellettuale. Nel 1814, ad esempio, lo studioso Pierre-Simon Laplace7
Quest’idee, a parere di Klaas, avrebbero cambiato il modo in cui si ideava la natura, fondamentale del nostro mondo occidentale. Se siamo giocattoli degli dei, allora il mondo è, primariamente e inevitabilmente indisciplinato, influenzato da macchinazioni invisibili, dai capricci di divinità imbroglione e dai loro turbamenti, in apparenza casuali, scatenati come fulmini dall’alto. Ma se le equazioni sono i nostri veri signori, allora il mondo è definito da un ordine elegante, seppur sfuggente, puntualizza, con gusto, Klaas.

La congettura, viene naturale: svelare i segreti di quelle equazioni, è la chiave per domare ciò che sembra indisciplinato solo a causa della nostra ignoranza umana. Senz’altro, si deve supporre che in quel mondo di equazioni, la realtà converge, inevitabilmente, verso una serie di leggi generali. Con l’avanzare del progresso scientifico nel XIX e XX secolo, la nozione del demone di Laplace divenne sempre più plausibile nelle fantasie metafisiche popolari. Equazioni migliori, si considerava, potevano portare a una lungimiranza divina, per accennare a solo un paio delle allucinazioni dell’epoca riferite da Klaas.
La ricerca di modelli, regole e leggi non si limitava solo al regno della fisica, puntualizza Klaas In biologia, i principi darwiniani fornivano, similmente, un nuovo paradigma dell’ascesa e della caduta delle specie: l’evoluzione per selezione naturale, agiva come un ordinato guardrail per tutta la vita. Sotto quest’aspetto, Klaas sostiene che con la diffusione dei successi delle scienze naturali, gli studiosi che cercavano di conoscere le dinamiche della cultura avrebbero iniziato ad immaginare che le regole della biologia e della fisica potevano essere utilizzate perfino per descrivere i modelli del comportamento umano. In effetti, senza giudicare lo slancio giornalistico di Klaas e dimenticando ogni rigore epistemico o presa di posizione conoscitiva, diventava plausibile congetturare che se esisteva una legge teorica per qualcosa di imperscrutabile come la gravità, forse esistevano regole simili che potevano essere applicate pure agli eventi inspiegabili del comportamento umano collettivo.
Un altro studioso che mise in moto un’idea simile all’ordine evoluzionistico darwiniano in biologia, fu il teorico sociale Henri de Saint-Simon.8 Confidando che le leggi scientifiche sostenessero il comportamento sociale, Saint-Simon propose un approccio più sistematico e scientifico all’organizzazione e alla governance sociale. Credeva che la riforma sociale sarebbe derivata inesorabilmente dalla ricerca scientifica. Il filosofo Auguste Comte,9 contemporaneo di Saint-Simon e fondatore della disciplina della sociologia, si riferiva persino allo studio delle società umane come fisica sociale. Sembrava solo questione di tempo, prima che la Rivoluzione francese venisse intesa, in modo altrettanto chiaro, quanto le rivoluzioni dei pianeti.10
Ma c’erano delle pieghe in questo mondo di misurazioni e previsioni ipotetiche, che il matematico Henri Poincaré anticipò nel 1908: “può accadere che piccole differenze nelle condizioni iniziali ne producano di molto grandi nei fenomeni finali. Un piccolo errore nelle prime produce un errore enorme nelle seconde”. La prima di queste pieghe di misurazioni e previsioni ipotetiche fu evidenziata dal matematico e meteorologo Edward Norton Lorenz. Nato nel 1917, Lorenz, sarebbe stato affascinato dal meteo sin da bambino, ma avrebbe abbandonato quell’interesse a metà degli anni ‘30 quando iniziò a studiare matematica all’Università di Harvard. Durante questi studi, scoppiò la Seconda guerra mondiale e Lorenz notò un aviatore che reclutava per un’unità di previsioni meteorologiche. Avrebbe preso al volo l’occasione di tornare alla sua passione giovanile. Mentre la guerra si avvicinava alla fine nel 1945, Lorenz iniziò a prevedere la copertura nuvolosa per i bombardamenti sul Giappone. Attraverso questo lavoro, comprese i gravi limiti delle previsioni meteorologiche: le previsioni non erano una scienza esatta. Così, dopo la guerra, tornò ai suoi studi matematici, lavorando su modelli meteorologici predittivi, nella speranza di dare all’umanità un mezzo per prevedere il futuro in modo più accurato.
Un giorno del 1961, mentre modellava il meteo usando un piccolo set di variabili su un semplice computer premoderno, Lorenz decise di risparmiare tempo riavviando una simulazione che si interruppe a metà. La stessa simulazione era eseguita in precedenza e Lorenz la stava eseguendo di nuovo come parte della sua ricerca. Stampò le variabili, quindi, riprogrammò i numeri nella macchina e aspettò che la simulazione si svolgesse come prima.
All’inizio, tutto sembrava identico, ma col tempo i modelli meteorologici di Lorenz iniziaronoo a divergere drasticamente. Suppose che ci dovesse essere stato un errore nel computer. Dopo molti grattacapi e sguardi accigliati sui dati, come icasticamente descrive Klaas11, Lorenz fece una scoperta che sconvolse per sempre la nostra comprensione del cambiamento sistemico. Si rese conto che le stampe del computer che aveva utilizzato per eseguire la simulazione troncavano i valori dopo tre cifre decimali: un valore di 0,506127 era stampato come 0,506. La sua sorprendente rivelazione fu che le più piccole differenze di misurazione, errori di arrotondamento, apparentemente infinitesimali e insignificanti, potevano cambiare, radicalmente, il modo in cui un sistema meteorologico si evolveva nel tempo. Le tempeste potevano emergere dalla sesta cifra decimale. Se il demone di Laplace esistesse, le sue misurazioni non avrebbero dovuto essere solo “quasi perfette”; dovevano essere impeccabili. Ogni errore, anche di un trilionesimo di punto percentuale in qualsiasi parte del sistema, alla fine rende futile qualsiasi previsione sul futuro. Lorenz aveva iniziato la teoria del caos.
L’emergere della teoria del caos
Il principio fondamentale della teoria12 è, popolarmente, questo: i sistemi caotici sono altamente sensibili alle condizioni iniziali. Ciò significa che questi sistemi sono completamente deterministici ma anche del tutto imprevedibili. Come Poincaré, aveva previsto nel 1908, piccoli cambiamenti nelle condizioni possono produrre enormi errori. Dimostrando questa sensibilità, Lorenz diede ragione a Poincaré, in effetti.
Come propone Klaas,13 la teoria del caos, fino ad oggi, spiega perché le nostre previsioni del tempo rimangono inutili per più di una o due settimane. Per prevedere i cambiamenti meteorologici in modo accurato, noi, come il demone di Laplace, dovremmo essere perfetti nella nostra comprensione dei sistemi meteorologici e, non importa quanto avanzati possano sembrare i nostri supercomputer, non lo saremo mai. La fiducia in un futuro prevedibile, quindi, propone Klaas, sarebbe prerogativa di ciarlatani e sciocchi. Sotto questo aspetto, Klaas ci offre un esempio emblematico e disturbante circa le modifiche genomiche che guidano l’evoluzione, in quanto anche esse sono, fondamentalmente, arbitrarie, persino accidentali.
La seconda piega nella nostra concezione di un mondo ordinato e certo deriva dalle osservazioni della meccanica quantistica che ebbero inizio alla partenza del XX secolo. Una casualità, in apparenza irriducibile, è stata individuata in sconcertanti equazioni quantistiche, spostando la concezione scientifica dominante del nostro mondo, dal determinismo all’indeterminismo, sebbene alcune interpretazioni della fisica quantistica rimangano presumibilmente compatibili con un universo deterministico, come l’interpretazione dei molti mondi e la meccanica bohmiana.14 Le indagini scientifiche nella fisica quantistica avrebbero evidenziato che la natura indisciplinata dell’Universo non poteva essere completamente spiegata né dagli dei né dalla fisica newtoniana. Il mondo potrebbe essere definito, almeno in parte, da equazioni che producono una casualità inspiegabile. E non sarebbe solo un mondo parzialmente casuale. È, sorprendentemente, arbitrario, ci ricorda Klaas.15
Si consideri, ad esempio, la progressione, apparentemente ordinata, dell’evoluzione darwiniana. Alfred Russel Wallace, che congetturò l’evoluzione più o meno nello stesso periodo di Charles Darwin, credeva che i principi della vita avessero uno scopo strutturato, Cioè sarebbero stati principi teleologici. Darwin era più scettico. Ma nessuno dei due pensatori poteva immaginare quanto arbitrario sarebbe stato, effettivamente, gran parte del cambiamento evolutivo.

Sotto quest’aspetto, negli anni ‘60, il biologo evoluzionista Motoo Kimura16 non sarebbero né utili né dannose. Sarebbero, fondamentalmente, arbitrarie, persino accidentali. Questo modello interpretativo Kimura lo chiamò la teoria neutrale dell’evoluzione molecolare.17 Anche altri scienziati se ne accorsero, sia che stessero studiando virus, moscerini della frutta, che ratti talpa ciechi o topi. Le osservazioni avrebbero iniziato ad accumularsi sul fatto che molti cambiamenti evolutivi nelle specie non erano guidati da pressioni di selezione strutturate o ordinate. Erano guidati dalle forze del caso.18
L’elegante esperimento evolutivo, a lungo termine, del biologo Richard Lenski,19 in corso dal 1988, avrebbe messo in evidenza che importanti adattamenti che aiutano una specie (come l’Escherichia coli) a prosperare possono emergere dopo una serie di mutazioni ampiamente insignificanti. Se uno qualsiasi di quegli aggiustamenti casuali e, apparentemente, inutili non si fosse verificato, il successivo adattamento benefico non sarebbe stato possibile. A volte, non c’è una ragione chiara, nessun modello chiaro. A volte, le cose accadono e basta.
La vita di Kimura è stata un’illustrazione delle forze arbitrarie che agiscono nel nostro mondo. Nel 1944, si iscrisse all’Università di Kyoto, sperando di continuare le sue attività intellettuali evitando la coscrizione nell’esercito giapponese. Se Henry Stimson avesse scelto una destinazione diversa per la sua vacanza turistica nel 1926, Kimura e i suoi compagni di studio sarebbero stati probabilmente inceneriti da un accecante lampo di luce atomica.20
A questo punto dell’argomentazione, dobbiamo tornare alla domanda essenziale che le riguarda. Come possiamo dare un senso al cambiamento sociale quando i cambiamenti consequenziali spesso nascono dal caos? Questa è la piaga inguaribile delle scienze sociali, un campo che cerca di rilevare schemi e affermare il controllo sul sistema più indisciplinato e caotico che esista nell’Universo conosciuto: 8 miliardi di cervelli umani interagenti, immersi in un mondo in continuo cambiamento. Mentre cerchiamo ordine e schemi, passiamo meno tempo concentrati su una realtà, oppure un’euristica, se mi permettete, ovvia ma consequenziale: i colpi di fortuna contano.
Sebbene alcuni studiosi del XIX secolo, come il filosofo John Stuart Mill e i suoi discendenti intellettuali, credessero che ci fossero delle leggi che governassero il comportamento umano, le scienze sociali, stando a Klaas, si sono rapidamente disillusi dell’idea che fosse possibile una fisica sociale semplice.
Invece, la maggior parte degli scienziati sociali ha puntato a quella che il sociologo Robert K Merton chiamava teoria di medio raggio21, in cui i ricercatori, sperano di identificare regolarità e modelli in alcuni ambiti più piccoli, che potevano, forse, essere cuciti insieme per ricavare i più ampi fondamenti teorici della società umana. Sebbene alcuni scienziati sociali siano scettici sull’esistenza di tali più ampi fondamenti teorici, l’approccio più comune alle scienze sociali, ribadisce Klaas, sarebbe quello di utilizzare dati empirici del passato per estrapolare modelli ordinati che indichino relazioni stabili tra cause ed effetti, come ad esempio:
- quali variabili sono meglio correlate con l’inizio delle guerre civili?;
- quali indicatori economici offrono i segnali di allerta precoce più accurati delle recessioni?;
- cosa causa la democrazia?
Effettivamente, le scienze sociali sono diventate dominate da uno strumento computazionale sopra tutti gli altri: le regressioni lineari.
A metà del XX secolo, si può asserire, basandosi sulla ricerca disponibile, che i ricercatori non cercavano più l’equivalente sociale di una legge fisica (come la gravità), ma cercavano ancora modi per derivare modelli netti all’interno del mondo sociale, come sostiene Klaas.
Ciò che limitava questa capacità era la tecnologia. Proprio come Lorenz era vincolato dalla tecnologia disponibile quando prevedeva il meteo nel teatro del Pacifico della Seconda guerra mondiale,così anche gli scienziati sociali erano vincolati dalla mancanza di potenza di calcolo. Ciò sarebbe cambiato negli anni ‘80 e ‘90, quando computer economici e sofisticati divennero nuovi strumenti per comprendere i mondi sociali. Improvvisamente, i cosiddetti scienziati sociali (sociologi, economisti, psicologi o politologi) potevano prendere un gran numero di variabili e inserirle in pacchetti software statistici come SPSS e Stata, o linguaggi di programmazione come R.22 Equazioni complesse avrebbero, quindi, elaborato questi punti dati, trovando la linea di miglior adattamento utilizzando una regressione lineare, per aiutare a spiegare come i gruppi di esseri umani cambiano nel tempo. Era nata forse una rivoluzione quantitativa.
Entro gli anni 2000, gli specialisti di studi di area che avevano precedentemente svolto le loro ricerche viaggiando per il mondo e inserendosi in culture specifiche sono stati ampiamente soppiantati da drogati di dati legati all’ufficio che potevano manipolare i numeri e offrire prove di relazioni nascoste che erano state oscurate prima dell’ascesa dell’analisi numerica sofisticata, come descrive Klass la svolta. Ciò permette a Klaas di asserire che nel processo, le scienze sociali sono state dominate da uno strumento computazionale sopra tutti gli altri: le regressioni lineari.
Critiche al modello delle regressioni lineari
Seguendo il ragionamento di Klaas, per aiutare a spiegare il cambiamento sociale, questo strumento utilizza dati del passato per cercare di comprendere le relazioni tra le variabili. Una regressione lineare produce un’equazione semplificata che cerca di adattarsi al cluster dei punti dati del mondo reale [real-world datapoints], mentre controlla i potenziali fattori confondenti, nella speranza di identificare quali variabili guidano, effettivamente, il cambiamento. Utilizzando questo strumento, i ricercatori possono alimentare un modello con una serie, apparentemente infinita, di dati mentre tentano di rispondere a domande di interessi socioeconomici e politici, come ad esempio: – il petrolio ostacola la democrazia? oppure – quanto la povertà influenza la violenza politica? In questa prospettiva, cercando di rispondere alla domanda di quali siano i determinanti sociali della criminalità, ci ricorda ironicamente Klass, che con i dati giusti e una regressione lineare, i ricercatori possono, plausibilmente, identificare modelli con equazioni difendibili basate sui dati. Ecco come una buona parte della nostra conoscenza sui sistemi sociali viene attualmente prodotta. C’è, però, stando a Klaas, solo un problema lampante: il nostro mondo sociale non è lineare. È caotico.
Le regressioni lineari si basano su diverse ipotesi sulla società umana che possono essere, ovviamente, errate. In un’equazione lineare, la dimensione di una causa è proporzionale alla dimensione del suo effetto. Ma, seguendo l’argomentazione di Klaas, non è così che funziona il cambiamento sociale. Klaas, ci invita a considerare a mo’ di esempio l’assassinio di un uomo, l’arciduca Francesco Ferdinando. Questo semplice evento avrebbe innescato la prima guerra mondiale, causando circa 40 milioni di vittime. Oppure si pensi al singolo venditore di verdure che si è dato fuoco nella Tunisia centrale alla fine del 2010, innescando eventi che hanno portato alla guerra civile siriana, con centinaia di migliaia di morti e la caduta di diversi regimi nel Nord Africa. Più di recente, un proiettile ha mancato di pocol’uccisione di Donald Trump in Pennsylvania: se la più piccola folata di vento o un singolo sussulto corporeo ne avessero alterato la traiettoria, il XXI secolo avrebbe preso una strada diversa. Ciò esemplifica la teoria del caos nel mondo sociale, dove piccoli cambiamenti nelle condizioni iniziali possono trasformare innumerevoli destini umani.

Un altro problema evidenziato da Klaas, è che la maggior parte delle regressioni lineari presuppone che una relazione causa-effetto sia stabile nel tempo. Ma il nostro mondo sociale è in continuo cambiamento. Mentre bicarbonato di sodio e aceto produrranno sempre una bollicina, non importa dove o quando li mescoli insieme, un venditore di verdura che si dà fuoco raramente produrrà sconvolgimenti regionali. Allo stesso modo, molti arciduchi sono morti. Solo l’assassinio di uno ha scatenato una guerra mondiale. Anche la tempistica, nell’elaborazione di questi modelli, risulta importante. Anche se la stessa identica mutazione, nello stesso identico coronavirus, fosse scoppiata, esattamente, nello stesso posto, gli effetti economici e le implicazioni sociali della conseguente pandemia sarebbero stati drasticamente diversi se avesse colpito nel 1990 invece che nel 2020. Come avrebbero fatto milioni di persone a lavorare da casa senza Internet? Le pandemie, come molti fenomeni sociali complessi, non sono governate, uniformemente, da modelli stabili e ordinati. Questo è un principio della realtà sociale noto agli economisti come non stazionarietà, vale a dire che le dinamiche causali possono cambiare mentre vengono misurate. I modelli sociali spesso non affrontano questo problema, semplicemente lo ignorano.
Un’altra criticità dell’ipotesi delle regressioni lineari è secondo Klaas,che la maggior parte delle regressioni lineari sono addirittura inefficaci nel modellare due aspetti fondamentali del nostro mondo: la sequenza, l’ordine critico in cui si verificano gli eventi, e lo spazio, la geografia fisica specifica in cui si verificano quegli eventi. Le spiegazioni generali offerte dalla regressione lineare, ignorano l’ordine in cui accadono le cose e, sebbene questo approccio possa, a volte, funzionare, in altre occasioni l’ordine degli eventi è cruciale. Le regressioni lineari non possono facilmente incorporare caratteristiche complesse della nostra geografia fisica o catturare i modi in cui noi umani navighiamo nello spazio. I modelli sociali tendono a concettualizzare i cambiamenti a livello macro, attraverso cifre di output economico o punteggi di democrazia, piuttosto che vedere individui diversi e adattabili che interagiscono costantemente su un terreno specifico. La vita è molto diversa per le persone che vivono in Antartide rispetto alle persone che vivono nel centro di Mumbai o sulle Ande o nell’outback australiano. Produciamo troppi modelli che sono spesso sbagliati e raramente utili, sostiene Klaas
Smussando una complessità quasi infinita, le regressioni lineari fanno sembrare il nostro mondo non lineare come se seguisse la confortante progressione di una singola linea ordinata. Questo è, ovviamente, un trucco da gioco di prestigio. E per completarlo con successo, gli scienziati devono eliminare tutto ciò che non si adatta. Devono rilevare il segnale ed eliminare il rumore. Ma nei sistemi caotici, il rumore è importante. Ci importa per davvero che il 99,8 % del viaggio del Titanic sia andato liscio come l’olio, o che Abraham Lincoln si sia goduto la maggior parte della commedia prima di essere colpito?
Le ipotesi profondamente imperfette della modellazione sociale non persistono perché economisti e scienziati politici siano idioti ma, piuttosto, perché lo strumento dominante per rispondere alle domande sociali non è stato aggiornato in modo significativo per decenni. Anche se sono stati apportati alcuni miglioramenti significativi negli anni ‘90. Ora si dispone di un’analisi dei dati più attenta, una migliore contabilizzazione del bias sistematico e metodi più sofisticati per dedurre la causalità, nonché nuovi approcci, come esperimenti che utilizzano prove di controllo randomizzate. Tuttavia, questi approcci non possono risolvere molti dei problemi persistenti nell’affrontare complessità e caos. Ad esempio, come si può condurre, eticamente, un esperimento per determinare quali fattori provocano definitivamente guerre civili? E come si fa a sapere che un esperimento in un luogo e in un momento produrrebbe un risultato simile un anno dopo in una parte diversa del pianeta?
Questi svantaggi, consentono a Klass di dire che, nonostante le enormi innovazioni nella tecnologia, le regressioni lineari rimanevano il re obsoleto della ricerca sociale. Come afferma l’economista J Doyne Farmer nel suo libro Making Sense of Chaos (2024)23: “I presupposti fondamentali dell’economia mainstream non corrispondono alla realtà e i metodi basati su di essi non si adattano bene né a piccoli problemi né a grandi problemi”. Per Farmer, questi metodi sono limitati principalmente dalla tecnologia. Paradossalmente, scrive, sono “incapaci di sfruttare appieno gli enormi progressi nei dati e nella tecnologia”.

Gli svantaggi comportano, nel pensiero di Doyen Farmer, anche che la ricerca sociale abbia avuto spesso scarso potere predittivo. E, di conseguenza, le scienze sociali non provano nemmeno a fare previsioni. Nel 2022, Mark Verhagen,] ricercatore presso l’Università di Oxford, ha esaminato un decennio di articoli nelle principali riviste accademiche in una varietà di discipline. Solo 12 articoli su 2.414 avevano provato a fare previsioni nell’American Economic Review. Per la principale rivista di scienze politiche, American Political Science Review, la cifra era 4 su 743.24 E nell’American Journal of Sociology, non un singolo articolo aveva fatto una previsione concreta. Ciò produsse la bizzarra dinamica per cui molti modelli di scienze sociali non possano mai essere definitivamente falsificati, quindi alcune teorie profondamente imperfette persistono, indefinitamente, come idee zombie che si rifiutano di morire.
Uno scopo fondamentale della ricerca in scienze sociali è prevenire problemi evitabili e migliorare la prosperità umana. Sicuramente ciò richiede che più ricercatori facciano previsioni sul mondo a un certo punto, anche se la teoria del caos dimostra che tali affermazioni sono probabilmente inaccurate. Produciamo troppi modelli che spesso sono sbagliati e raramente utili. Ma esiste un modo migliore. E deriva dalla sintesi di lezioni da campi che gli scienziati sociali hanno per lo più ignorato.
La consolidazione della teoria del caos
La teoria del caos inizia a svilupparsi in modo consistente negli anni ‘60 e, nei decenni successivi, fisici e matematici come David Ruelle, in Chanceand Chaos25 e Philip Anderson ed altri, in The Economy as an Evolving Complex System,26 hanno riconosciuto l’importanza delle intuizioni di Lorenz per la nostra comprensione dei sistemi dinamici del mondo reale. Mentre queste idee si diffondevano, pensatori disadattati di una serie di discipline hanno iniziato a unirsi attorno ad un nuovo modo di pensare in contrasto con le convenzioni tradizionali nei loro stessi campi. Lo chiamavano ricerca sulla complessità o sui sistemi complessi. Per questi primi pensatori, la Mecca era il Santa Fe Institute nel New Mexico, non lontano dalle colline punteggiate di artemisia dove nacque la bomba atomica. Ma a differenza della Mecca, il Santa Fe Institute non è diventato il fulcro di un movimento globale.
L’interesse pubblico per il caos e la complessità aumentò negli anni ‘80 e ‘90 con la pubblicazione del libro di divulgazione scientifica di James Gleick, Chaos (1987).27 La scorciatoia per screditarla è l’effetto farfalla. Ma a parte alcuni pensatori marginali che si liberarono dai silos disciplinari, le scienze sociali risposero alla mania della complessità per lo più con una scrollata di spalle. Questo è stato un errore profondo, che ha contribuito alla nostra comprensione imperfetta di alcune delle domande maggiormante basilari sulla società. Prendere sul serio il caos e la complessità richiede un nuovo approccio.28
Un’alternativa alle regressioni lineari sarebbe la modellazione basata su agenti, un tipo di esperimento virtuale in cui i computer simulano il comportamento di singole persone all’interno di una società. Questo strumento consente ai ricercatori di vedere come le azioni individuali, con le proprie motivazioni, si uniscono per creare modelli sociali più ampi. La modellazione basata su agenti potrebbe essere efficace nel risolvere problemi che implicano un processo decisionale relativamente semplice, come i flussi di traffico automobilistico o la diffusione di malattie durante una pandemia. Man mano che questi modelli migliorano, con i progressi nella potenza di calcolo, continuano, inevitabilmente, a fornire approfondimenti di informazioni fruibili per domini sociali più complessi. Fondamentalmente, in linea di principio, si possono catturare dinamiche non lineari e fenomeni emergenti e rivelare colli di bottiglia inaspettati o punti di svolta che altrimenti si presenterebbero inosservati.Tali modelli basati su agenti, possono consentire agli esperti di immaginare mondi possibili migliori, non solo di misurare modelli del passato. Si considerava che potevano offrire uno strumento potente, ma sottoutilizzato, nella ricerca sociale orientata al futuro e che coinvolgeva sistemi complessi. In particolare, lo studio della resilienza nei sistemi non lineari poteva migliorare la nostra capacità di evitare catastrofi evitabili.
Inoltre, ancora, continua a segnalare Klaas gli arditi difensori della teoria del caos potevano incorporare dinamiche caotiche riconoscendo i limiti della ricerca di regolarità e modelli. Invece, diedero priorità, secondo Klaas,29 a provare ad anticipare e identificare sistemi sull’orlo del baratro, vicini a un punto di svolta, sistemi che potevano essere innescati da un venditore di verdure scontento o innescati da un arciduca assassinato. Lo studio della criticità auto-organizzata nella fisica e nella scienza della complessità avrebbe, sostiene Klaas, potuto aiutare gli scienziati sociali a dare un senso a questo tipo di fragilità. Proposto dai fisici Per Bak, Chao Tang e Kurt Wiesenfeld, il concetto offre un’utile analogia per i sistemi sociali che possono crollare in modo disastroso. Quando un sistema si organizza verso uno stato critico, un singolo colpo di fortuna può causare un brusco cambiamento del sistema.
Per analogia, le moderne reti commerciali corrono verso uno stato ottimizzato ma fragile: una singola folata di vento può far girare una barca di lato e causare miliardi di dollari di danni economici, come è successo nel 2021 quando una nave bloccò il Canale di Suez. La teoria della criticità auto-organizzata, sostiene Klaas, sul modello del mucchio di sabbia, che poteva essere utilizzato per valutare come e perché cascate o valanghe si verifichino all’interno dei sistemi. Se si aggiungono granelli di sabbia, uno alla volta, a un mucchio di sabbia, alla fine, un singolo granello di sabbia può causare una valanga. Ma quel crollo diventa più probabile man mano che il mucchio di sabbia raggiunge il suo limite. Un modello sociale del mucchio di sabbia può fornire un utile quadro intellettuale per analizzare la resilienza di sistemi sociali complessi, puntualizza Klaas,30 nella sua argomentazione.
È improbabile che qualcuno che si dà fuoco in Norvegia inneschi una guerra civile o il crollo del regime. Questo perché il mucchio di sabbia norvegese è più basso, meno teso al limite e, quindi, meno incline a cascate inaspettate e punti di svolta rispetto all’imponente mucchio di sabbia che ha portato alla primavera araba. Ci sono altre lezioni che la ricerca sociale ha la possibilità di imparare dalle valutazioni non lineari del crollo ecologico. In biologia, in particolare, la teoria del rallentamento critico prevede che i sistemi prossimi a un punto di svolta, come una barriera corallina in difficoltà invasa dalle alghe, impiegheranno più tempo a riprendersi da piccoli disturbi. Questa risposta sembra agire come un sistema di allerta precoce per gli ecosistemi sull’orlo del collasso.
Gli scienziati sociali dovrebbero attingere a queste innovazioni dai sistemi complessi e dai campi di ricerca correlati, anziché ignorarli. Sforzi migliori per studiare la resilienza e la fragilità nei sistemi non lineari migliorerebbero drasticamente la nostra capacità di evitare catastrofi evitabili. Eppure, così tanta ricerca sociale insegue ancora il sogno obsoleto di distillare la complessità caotica del nostro mondo in un’equazione elementare, una rappresentazione semplice e ordinata di un mondo fondamentalmente disordinato.
Quando cerchiamo di spiegare il nostro mondo sociale, ignoriamo, scioccamente, come ci ricorda Klaas, i colpi di fortuna. Immaginiamo che le leve del cambiamento sociale e gli ingranaggi della storia siano vincolati, non caotici. Citando Klaas perché lui lo formula in modo magistrale, ci aggrappiamo a una versione ridotta della favola della realtà, sperando di scoprire modelli stabili. Quando ci viene data la possibilità di scegliere tra un’incertezza complessa e una certezza confortante, ma sbagliata, troppo spesso scegliamo la comodità.
In verità, viviamo in un mondo indisciplinato, spesso governato dal caos. E in quel mondo, le traiettorie delle nostre vite, delle nostre società e delle nostre storie possono essere deviate per sempre da qualcosa di piccolo come scendere da un treno a vapore per una bella giornata di visite turistiche, o di effimero come il passaggio delle nuvole.
- Brian Klaas. Fluke: Chance, Chaos, and Why Everything We Do Matters, Simons & Shuster, 2024
- Ibidem
- Ibidem
- George Edward Pelham Box e Gwilym Meirion Jenkins. Time Series Analysis: Forecasting and Control, Holden-Day, 1979 / George Edward Pelham Box, William Gordon Huntere J Stuart Hunter. Statistics for experimenters, New York, Wiley, 1978.
- Brian Klaas, op. cit., 2024
- Fondamentale il suo trattato sulla meccanica celeste, ipotizzò l’origine del sistema solare in seguito a una nube primordiale[/efn:_note] pubblicò un saggio che immaginava le possibili implicazioni delle idee di Newton sui limiti della conoscenza. Laplace avrebbe utilizzato il concetto di un demone onnisciente, un’entità ipotetica che, specificamente, conosceva sempre le posizioni e le velocità di ogni particella nell’universo deterministico di Newton. Utilizzando questo scaltro potere, il demone di Laplace poteva elaborare l’intera enormità della realtà e vedere il futuro, chiaramente come il passato, come, con cura e dedizione sospetta, racconta Klaas.6Brian Klaas, op. cit., 2024
- Pensatore politico francese (Parigi 1760 – 1825). S.-S. può essere considerato, a buon diritto, il fondatore del positivismo sociale, ossia di quella corrente filosofica che mira allariorganizzazione della società su basi scientifico-tecnocratiche.
- Filosofo e sociologo francese (Montpellier 1798 – Parigi 1857). Fondatore del positivismo, Comte vide nella fase successiva alla Rivoluzione francese – come già aveva visto Hegel –un’epoca di crisi, incapace di dare vita a un nuovo ordine morale, sociale e politico. E anche come Hegel pur se in modo diverso, volgendosi cioè non alla ragione speculativa, ma alparadigma della scienza moderna) cercò di elaborare una nuova sintesi filosofica, che preparasse l’avvento di un’«epoca organica». Spinto da questa tensione verso una sintesi unitaria, Comte finì per trasformare il suo iniziale positivismo sociale in una vera e propria religione, di cui fissò le credenze (l’Umanità come ‘Grande Essere’ al posto di Dio), le massime morali ispirate all’altruismo, i sacramenti e persino il calendario.
- Brian Klaas, op. cit., 2024
- Brian Klaas, op. cit., 2024
- In matematica la teoria del caos è lo studio, attraverso modelli propri della fisica matematica, dei sistemi dinamici che esibiscono una sen- sibilità esponenziale rispetto allecondizioni iniziali. I sistemi di questo tipo, pur governati da leggi deterministiche, sono in grado di esibire un’empirica casualità nell’evoluzione delle variabili dinamiche. Questo comportamento casuale è solo apparente, dato che si manifesta nel momento in cui si confronta l’andamento temporale asintotico di due sistemi con configurazioni inizialiarbitrariamente simili tra loro. Ott Edward, Chaos in Dynamical Systems, Cambridge University Press, pp. 15-19, 2002
- Brian Klaas, op. cit., 2024
- L’interpretazione di Bohm (detta anche interpretazione causale, interpretazione ontologica o meccanica bohmiana), è un’interpretazione della meccanica quantistica formulata da David Bohm nel 1952. È un esempio di teoria a variabili nascoste, con la quale s’intendeva ottenere una descrizione realistica, causale e deterministica dei sistemi Non presenta alcuni problemi, che restano invece aperti nella interpretazione di Copenaghen, quali l’istantaneo collasso della funzione d’onda e la sovrapposizione di stati nel mondo macroscopico (che genera il Paradosso del gatto di Schrödinger). Il dilemma del dualismo onda particella viene qui risolto, come già nella teoria dell’onda pilota di de Broglie, assumendo che vi sia un’onda fisica (onda pilota) che guida ciascuna particella. La particella e l’onda pilota sono entrambe entità fisiche reali e tra loro distinte, benché correlate. Nell’interpretazione di Bohm si assume, a differenza della interpretazione del Centro di sperimentazione di Copenaghen, l’incompletezza della funzione d’onda che descrive un sistema quantistico. Secondo Bohm, per fornire una descrizione deterministica e causale di un sistema, oltre alla funzione d’onda si dovrebbero conoscere le coordinate delle particelle del sistema all’istante iniziale (variabili nascoste). L’ontologia primitiva di Bohm è classica: postula una realtà fisica costituita da onde e particelle. L’ente centrale dell’interpretazione di Bohm è il potenziale quantico Q. Ad esso vanno ascritte le differenze tra meccanica classica, in cui agisce la forza newtoniana.
- Brian Klaas, op. cit., 2024
- Motoo Kimura (13 novembre 1924 – 13 novembre 1994) è stato un biologo giapponese, famoso soprattutto per la teoria neutrale dell’evoluzione, da lui resa nota nel 1968. Come uno dei teorici della genetica delle popolazioni egli introdusse negli studi di genetica un uso nuovo delle equazioni di diffusione per calcolare la probabilità di fissazione di alleli benefici, dannosi o neutrali. Nel 1992 Kimura ha ricevuto la Medaglia Darwin per i suoi contributi all’arricchimento del concetto di evoluzione. Il 1968 segna una svolta nella carriera di Kimura, essendo l’anno in cui rende pubblica la teoria neutrale dell’evoluzione molecolare, basata sul principio acquisito che, a livello molecolare, la maggioranza delle mutazioni genetiche sarebbe neutrale rispetto alla selezione naturale, rendendo secondo Kimura la deriva genetica casuale un fattore primario nell’evoluzione nel campo della biologia molecolare. propose che la maggior parte delle modifiche genomiche che guidano l’evoluzione a livello molecolare
- Mootoo Kimura. The Neutral Theory of Molecular Evolution. Cambridge University Press, 1983
- Ibidem
- Una delle critiche più comuni che viene solitamente mossa alla teoria dell’evoluzione è che si occupa di studiare e descrivere un fenomeno, l’evoluzione appunto, che non è riproducibile in laboratorio. Da circa 35 anni però gli evoluzionisti possono rispondere che non è vero, perché un ricercatore visionario decise nel 1988 di iniziare un esperimento che oggi è ancora in corso: è il Long Term Evolutionary Experiment (LTEE, esperimento evoluzionistico a lungo termine) e raccoglie dati sui meccanismi di adattamento e sui ritmi del cambiamento evolutivo man mano che questi avvengono, in laboratorio. Affascinato dalle grandi domande aperte, Richard Lenski, professore di biologia evoluzionistica alla Michigan State University di East Lansing, avrebbe deciso di mettere in piedi un esperimento relativamente semplice che consente di osservare in diretta i processi evolutivi e i loro effetti su chi ne è protagonista. Nella fattispecie sono stati scelti come organismi modello dei batteri molto ben conosciuti e studiati, gli Escherichia coli, per cui sono disponibili protocolli sperimentali molto rodati e affidabili. Un’altra delle aspettative scientifiche di questo esperimento era che il genoma dei batteri diventasse più piccolo nel tempo. Molti batteri che si trovano in un ambiente semplice e costante nel tempo finiscono per vedere rimpicciolito il proprio genoma. E una delle cose più sorprendenti che vengono osservate è che il genoma degli E. coli dell’esperimento nonostante siano in un ambiente semplice e control- lato, non si sia ridotto di tanto. Ma 34 anni e 75.000 generazioni, del resto, non sono che una goccia nel secchio profondo dell’evoluzione, fa notare Lenski: “se potessimo vederli diciamo tra un milione di anni i nostri batteri probabilmente avrebbero un genoma estremamente ridotto. Il che è un’ottima ragione per andare avanti”.
- Brian Klaas, op. cit., 2024
- In opposizione all’idea dei funzionalisti come Talcott Parsons di costruire una teoria onnicomprensiva e all’empirismo puro, Merton propone “teorie di medio raggio”, così chiamate perché circoscritte a problemi e fenomeni specifici. Esempi di teorie di questo tipo sono per Merton, la ricerca sul suicidio di Émile Durkheim e quella sull’etica protestante e lo spirito del capitalismo di Max Weber
- R è un linguaggio di programmazione specifico per la statistica e la grafica computazionali, ampiamente utilizzato per l’analisi di dati, la visualizzazione e il calcolo statistico. È un software open source gratuito e flessibile, utilizzato in settori come bio-informatica, finanza, ingegneria e analisi di mercato.
- J. Doyne Farmer. Making Sense of Chaos. A Better Economics for a Better World. Yale University Press, 2024
- Brian Klaas, op. cit., 2024
- David Ruelle, Chance and chaos, vol. 110, Princeton University Press, 1992 / trad. it. Caso e caos.Bollati e Boringhieri 1992
- Anderson Philip W.; Arrow Kenneth; Pines David. The Economy as An Evolving Complex System. CRC Press, 1988.
- James Gleick. Chaos: Making a New Science. Viking, 29 October 1987 / trad. it. Caos. La nascita di una nuova scienza, 20 Sett 2018.
- Brian Klaas, op. cit., 2024
- Ibidem
- Brian Klaas, op. cit., 2024








