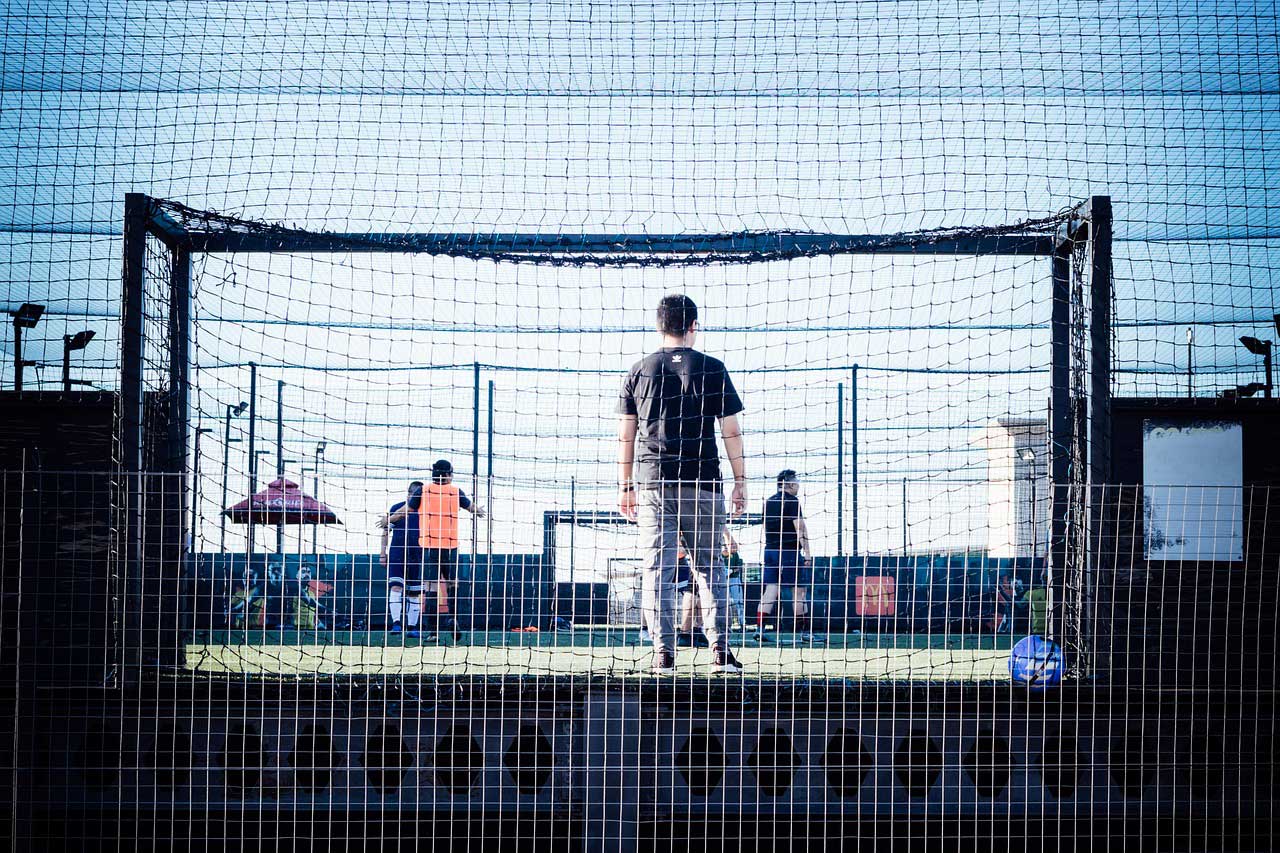BIO – Medicina Costruzione Sociale nella Post-Modernità – Educational Papers • Anno VII • Numero 26 • Giugno 2018
Scritto in collaborazione con Eugenia D’Alterio – biologa
Una nuova prospettiva sull’interazione tra natura, uomo ed economia
L’ancor vigente visione moderna del mondo sembra impedirci, letteralmente, di comprendere le cause più profonde delle nostre molteplici crisi. Al riguardo il biologo ambientalista e studioso, Andreas Weber, ci dà un’idea di un diverso paradigma emergente che egli denomina “Enlivenment”.1 Una possibile traduzione in italiano del concetto potrebbe essere “Vivacizzazione”. La ragione di questo richiamo a rendere vivace qualcosa o qualcuno risiede nel fatto che, in questo paradigma, gli organismi, piuttosto che semplici organizzazioni fisiologiche, sono strutture senzienti che hanno esperienze soggettive ed elaborano senso. Weber vede l’Enlivenment come un aggiornamento delle categorie carenti del pensiero illuminista, cioè un modo per andare oltre la moderna metafisica della materia e riconoscere i processi profondamente creativi che si compiono in tutti gli organismi viventi. Il paradigma dell’ ‘Enlivenment’, proposto da Weber, è un inizio promettente per tutti coloro che sono alla ricerca di soluzioni alle sfide del nostro futuro che tengano conto della dimensione senziente e soggettiva della vita.
Questo paradigma propone una nuova prospettiva sull’interazione tra natura, uomo ed economia. Esso cerca di sviluppare una serie di alternative attorno ad alcuni presupposti fondamentali su cui si basa la attuale visione ufficiale del mondo. La sua tesi centrale è che dobbiamo riconsiderare “vita” e “vitalità” come categorie fondamentali del pensiero e perciò questo approccio viene denominato “Enlivenment”. Questo allargamento di veduta cerca di integrare – non di sostituire – il pensiero razionale e l’osservazione empirica – che sono le pratiche fondamentali della posizione dell’Illuminismo – con la “soggettività empirica” degli esseri viventi e con la “oggettività poetica” delle esperienze generatrici di senso.
Per Weber,2 la scienza, la società e la politica hanno perso negli ultimi 200 anni il loro interesse nel comprendere l’esistenza come viene vissuta e sentita dagli umani e dagli altri organismi viventi. L’interpretazione di un progresso scientifico – e tutte le spiegazioni dei processi biologici, mentali e sociali – si basano sui più piccoli elementi costitutivi della materia e dei sistemi. Il ragionamento insito in que- sta visione moderna avanza attraverso analisi che presumono che l’evoluzione nella natura sia guidata da principi di scarsità, competizione e selezione del più adatto. Per dirla in termini provocatori, seguendo Weber, si potrebbe dire che il pensiero razionale è un’ideologia che si concentra sulla materia meccanico-fisica. Le sue premesse non hanno modo di comprendere la realtà dell’esperienza vissuta. In una tale interpretazione della realtà non è affatto sorprendente che la sopravvivenza o sostenibilità della vita sul nostro pianeta sia diventata un problema urgente.
Sulla base di nuove conoscenze, prevalentemente in biologia ed economia, l’Enlivenment propone una visione diversa. Esso sostiene che l’esperienza vissuta, il significato che si esprime, lo scambio materiale e la soggettività sono fattori chiave che non possono essere esclusi da un quadro scientifico della biosfera e dei suoi attori. Una visione del mondo che può spiegarlo solo in “terza persona”, come se tutto fosse un qualcosa non vivente, nega l’esistenza degli stessi attori che espongono la visione stessa. Visione del mondo che ignora, deliberatamente, il fatto che noi umani, siamo soggettivi e senzienti, membri di una specie animale, i cui metabolismi sono in costante scambio materiale con il mondo vivente.
Nella visione del mondo dell’Enlivenment, noi, umani, siamo sempre parte integrante della natura. Ma questa natura è molto più simile a noi di quanto possiamo immaginare: è creativa e pulsante di vita in ogni sua cellula. Crea autonomia e libertà individuali dal suo stesso impegno con i vincoli. A livello esperienziale, come esseri viventi su questa terra animata, possiamo capire – o “sentire” – le forze della natura, se non altro perché siamo fatti da queste.
L’Enlivenment costituisce un nuovo approccio per comprendere il nostro “dilemma della sostenibilità”, sollecitando ad abbracciare un nuovo orientamento culturale verso i processi di vita aperti, generatori di significato, paradossali e inclusivi. Per alcuni, questo può sembrare la proposta di un nuovo naturalismo, la visione che tutto sia composto da entità naturali. Ma se così fosse, sarebbe un naturalismo di secondo ordine che tenga conto del fatto che la natura non è un regno privo di significato o neutrale ma è, piuttosto, una fonte di significato esistenziale, prodotto, continuamente, dalle relazioni tra gli individui, e che dispiega una storia di intenzionalità.

La proposta di Weber cerca di sostituire i “principi bio-economici” che stanno guidando, oggi, molte delle nostre decisioni economiche, politiche, educative e private, con nuovi “principi di vivacizzazione” [enli- venment]. Questi principi di vivificazione sono basati sull’osservazione che nella biosfera viviamo un processo di dispiegamento di un ‘estro naturale’ e che, come esseri umani, non solo siamo in grado di sperimentare questa vitalità, ma che dobbiamo sperimentarla direttamente. L’esperienza di essere vivi è un requisito umano fondamentale che ci collega a tutti gli organismi viventi e alla “natura” – spesso fraintesa come qualcosa di separato da noi. Riconoscere questo bisogno esistenziale non è solo importante per lo sviluppo delle scienze biologiche, ma è imperativo, anche, per il nostro futuro come specie in processo di cambiamenti ecologici poco conosciuti. La nostra incapacità di onorare la nostra predisposizione di “esseri vitali”, come una ricca e robusta categoria del pensiero in economia e politica, significa che non capiamo appieno come costruire e mantenere una società sostenibile.
La “vivacizzazione’ non è una questione storica o filosofica arcana, ma una serie di principi, di ordine profondo, riguardo acome percepiamo, pensiamo e agiamo. Se possiamo cogliere l’enlivenment [la vivacizzazione] come una visione, possiamo iniziare ad allenarci a vedere in modo diverso e ad affrontare le lotte politiche e la politica stessa con una nuova prospettiva. Le conseguenze politiche dell’adozione di un tale approccio, che Weber chiama “politiche di vivacizzazione” [enlivenment], sono di vasta portata. Infatti, abbracciare un punto di vista non dualistico consente una maggiore inclusione e cooperazione perché non c’è disgiunzione tra “teoria razionale” e pratica sociale, questioni intrecciate.
Allo stesso tempo, questa prospettiva consente un riconoscimento più profondo dell’inevitabili confusioni riguardo le nostre idee utopiche sulla vita quando si presentano conflitti, tempi duri, carenze di ogni tipo, ecc., per i quali devono essere coltivate regole di negoziazione e di inclusione. La libertà che l’Illuminismo ha cercato di avanzare è l’autonomia personale dell’individuo per esserne il proprio padrone. La libertà che l’Enlivenment cerca di far progredire è la nostra libertà, in quanto individui e gruppi, di esseri “viventi e in connessione”, la libertà che si ottiene solo allineando i bisogni e gli interessi individuali con quelli della comunità più ampia. Solo questa libertà integrata può fornire il potere diriconciliare l’umanità con il mondo naturale.

Guardando oltre l’attuale fascino inconscio per la morte
Questo passaggio della nostra esposizione sull’Enlivenment di Andreas Weber3 cerca di descrivere la “situazione contemporanea” sul nostro pianeta da una nuova prospettiva. Quando usiamo il termine “situazione contemporanea”, ci riferiamo ai molti aspetti familiari delle attuali crisi multiple: degradamento ambientale, perdita di biodiversità, cambiamento climatico, conflitto Nord-Sud, disuguaglianze economiche. Ma non ci riferiamo solo agli aspetti materiali di queste sfide, bensì alle loro dimensioni soggettive più o meno nascoste, che possono essere riassunte sotto il termine “crisi di senso”. Per sottolineare l’importanza di prestare attenzione alla ‘crisi di senso’, prendiamo nota, ad esempio, del fatto che la cosiddetta ‘depressione bipolare’ era classificata come la terza causa principale del carico globale di malattia nel 2004 e si prevede che passerà al primo posto entro il 2030, superando le malattie infettive, cardiache e tumorali.4
Weber proporre che le crisi multidimensionali dell’attuale situazione globale siano meglio comprese come “crisi globali nella creazione di senso” che ha diverse dimensioni, addirittura contraddittorie. I suoi aspetti spaziano dalla minaccia ai sistemi naturali di supporto alla vita, al sovra-sfruttamento della pesca, alla deforestazione, al degrado del suolo, alla perdita di specie, ad improvvisi cambiamenti climatici e al degrado dei sistemi di supporto umano per la vita sociale e psicologica delle persone, per citarne alcune.
Tutti questi singoli fattori, secondo l’approccio di Andreas Weber, non possono essere visti separatamente l’uno dall’altro e trattati indipendentemente. Sono aspetti dello stesso problema. L’approccio tradizionale ai nostri molteplici dilemmi, tuttavia, è quello di risolverli in “silos” separati e, quindi, cercare specifiche “soluzioni” singole. Ciò equivale alla sola metodologia ufficialmente accettabile nelle istituzioni stabilite, siano esse istituzioni accademiche che sistemi di sanità pubblica, organizzazioni ambientali o organismi di politica internazionale. Ma un approccio analitico che separa ed esternalizza i problemi per renderli tecnicamente gestibili è proprio il motivo per cui questi problemi sono sorti in primo luogo. Infatti, ci troviamo in una situazione di stallo.
Quindi, se si spera di fare progressi, dovremmo prima chiederci cosa ci sta bloccando. Esiste una situazione generale da cui nascono i dilemmi più contemporanei? Metodologicamente, secondo Weber, si dovrebbero cercare denominatori comuni nel nostro modo di pensare o nelle politiche che potrebbero essere ritenuti responsabili di tale situazione, in modo che possiamo iniziare a nominare i problemi correlati e iniziare a cercare una nuova prospettiva per affrontare la realtà. Allora, forse, secondo Weber, si potrebbe sviluppare una nuova narrativa che descriva più accuratamente il mondo in cui viviamo e desideriamo vivere.
Oltre l’attuale metafisica della materia morta
Alla ricerca di una situazione comune, generatrice dei dilemmi contemporanei, Weber considera che un difetto profondo della nostra civiltà, con le sue molteplici crisi, risiede nel fatto che neghiamo l’esistenza di processi profondamente creativi, poetici ed espressivi del mondo, tutti costantemente dispiegati nel portare avanti una moltitudine di relazioni dinamiche e interagenti. Al riguardo, egli suggerisce che, forse, abbiamo dimenticato il significato di esseri viventi. Infatti, tutte le scienze, siano esse naturali che sociali o economiche, cercano di cogliere il mondo come se fosse un processo meccanico morto che può essere compreso attraverso analisi statistiche o cibernetiche. Dal momento che la innovativa rivoluzione di Descartes separa la realtà in una res cogitans nascosta, soggettiva, rigorosamente non generalizzabile, da una parte (cioè le nostre menti), e dall’altra, una dimensione visibile malleabile, calcolabile ma morta, la res extensa (cioè il mondo materiale), i più nobili sforzi della specie umana si sono concentrati sulla separazione della realtà e di tutte le sue parti in blocchi elementari – atomi e algoritmi. Questo è stato visto dalla modernità come il modo più fruttuoso per far migliorare il progresso umano.
Le regole scientifiche che sono ritenute valide ancora oggi, come quando furono stabilite nel XVII secolo, ci impongono di trattare tutto come materia “morta”. L’applicazione automatica del rasoio di Occam5 è diventata un’arma letale che trasforma ogni oggetto di interesse in un insieme di blocchi di costruzione non animati. Questa tendenza, per Weber, ha maledetto la nostra civiltà con una sorta di tocco di Re Mida al contrario. Questo mitico re trasformava ogni oggetto in oro con il semplice tocco delle sue mani, causandogli infine la morte per fame. Tutte le cose che la nostra civiltà tocca con la visione a raggi X del metodo scientifico, in effetti, perde la sua vitalità. La scienza ha eretto una metafisica di non viventi per analizzare l’aspetto più notevole del nostro essere nel mondo, cioè il nostro essere vitali.6

Illuminismo 2.0: enlivenment
L’Enlivenment o Vivacizzazione, in primo approccio, significa far sì che le cose e le persone stesse possano rivitalizzarsi – essere maggiormente piene di vita, diventare più vive. L’idea riguarda, immediatamente, la “vita reale” di specie ed ecosistemi minacciati, la “vita interiore” di noi stessi, rappresentanti della specie sociale Homo economicus, svolgendo, incessantemente, compiti più o meno necessari a soddisfare esigenze più o meno reali per mantenere l’enorme macchina che chiamiamo “l’economia”.
Con il termine Enlivenment o Vivacizzazione Andreas Weber trova un punto di partenza dal quale identificare le varie aree trascurate della realtà che sono nascoste nel punto cieco del pensiero scientifico modernista. Non è casuale che il termine abbia tanta somiglianza con il nome del suo predecessore, l’Illuminismo. Con l’avvento dell’Illuminismo (che in realtà richiese molti secoli), gli assunti fondanti che stavano alla base dei tempi moderni arrivarono al loro pieno dinamismo cioè, che il mondo è comprensibile su basi razionali, che noi umani possiamo cambiarlo (perché possiamo capirlo) e che non solo ne abbiamo la possibilità ma, anche, il diritto e l’obbligo per migliorare la condizione umana. Con l’Illuminismo è nato l’umanesimo moderno, un modo di pensare e di essere che ha migliorato, innegabilmente, la vita umana e le condizioni di vita. Ma le abitudini di pensiero dell’Illuminismo, specialmente la comprensione razionale e tecnocratica dell’azione umana, hanno, anche, un lato oscuro, come notoriamente osservato dai critici della “dialettica dell’Illuminismo”.7
Horkheimer e Adorno, e sulla loro scia molti altri, sostengono, che l’ideologia illuminista ha determinato non solo l’idea della libertà ma, anche, alcune delle grandi catastrofi totalitarie e tecnocratiche del XX secolo. Infatti, a questa tradizione di pensiero è, in certa misura, imputabile la responsabilità dei disastri tecnocratici dell’attuale insostenibilità del nostro ecosistema planetario. I principali difetti dell’approccio illuministico – oltre alla presunzione che la realtà sia essenzialmente trasparente sul suo volto e aperta a tutti – sono la sua dipendenza dai dualismi del pensiero, dal discorso razionale e dalla divisione newtoniana soggetto-oggetto. Significativamente, per il progetto dell’Illuminismo non hanno alcun senso le nozioni di vita, di essere senziente, di esperienza, di soggettività, di creazione corporea e di arbitrio. Questi concetti sono, in effetti, esclusi dalla visione illuministica del mondo.
Se si esamina la questione ci si rende conto che le norme dell’Illuminismo non sono una questione storica o filosofica arcana, ma che esse poggiano in profondi principi strutturali nella cultura moderna che hanno un potente effetto nell’ordinare come percepiamo, pensiamo e agiamo. La nostra economia, i sistemi legali, le politiche governative, la medicina convenzionale, e molto altro sono fermamente basati sui principi illuministi. Ci sono buone ragioni per cui il pensiero economico e politico convenzionale non è in grado di “risolvere” la nostra crisi di sostenibilità. Il pensiero politico economico moderno riflette profondi errori di comprensione del pensiero umano (l’epistemologia), delle relazioni (l’ontologia) e del funzionamento biologico (la medicina).
L’idea di Andreas Weber circa l’Enlivenment o Vivificazione è intesa come un correttivo. Essa cerca di espandere la nostra visione di ciò che noi umani siamo in quanto soggetti complessi. Questa nozione non esclude il ruolo della razionalità e dell’agire umano, ma li collega ad altri modi di essere, come le nostre relazioni psicologiche e metaboliche con il mondo “più che umano”, sia nei suoi aspetti animati che non-animati.8 L’Enlivenment collega la razionalità con la soggettività e la sensibilità.
È del tutto possibile, comunque, che i grandi obiettivi politici inaugurati dall’Illuminismo di 250 anni fa, che in molte aree del mondo sono ancora lontani dall’essere realizzati, possano essere raggiunti solo attraverso un passaggio all’idea di Enlivenment. Potrebbe essere possibile, ad esempio, che per raggiungere una più ampia inclusione sociale nella politica di uno stato sia necessario un profondo “riconoscimento esistenziale” di tutti i cittadini di uno stato, in particolare delle minoranze. Con questo si intende dire che l’emancipazione universale può richiedere una più profonda comprensione della “vitalità” [aliveness] di una persona al fine di riconoscere e accettare i suoi bisogni. Pertanto, l’Illuminismo potrebbe essere in attesa di “un aggiornamento” alla versione 2.0, se si vuole rimediare alle sue affermazioni dichiarate. E questa versione si chiama Enlivenment.

Cos’è la vita e quale ruolo noi umani giochiamo in questa?
Usando l’approccio dell’Enlivenment [Vivacizzazione] di Andreas Weber per riorientarci nella crisi planetaria possiamo iniziare a concentrarci su una singolare deficienza del pensiero moderno e contemporaneo: la paradossale mancanza di comprensione di cosa sia la vita. Infatti, ancora molti di noi non sono consapevoli della nostra complessa realtà come esseri viventi. Questa distrazione è un fatto sorprendente ma è, anche, un risultato logico della nostra cultura razionale. L’elaborazione di significato circa la vita e le domande sullo scopo umano, sulle soddisfazioni e sulle aspirazioni, sono state a lungo ignorate dalla biologia, dall’economia e dalle discipline umanistiche. Questo compito è rimasto prerogativa della gestione religiosa e bio-politica delle popolazioni umane.
Eppure, questa nozione del “significato della vita” immedesima alcune semplici domande quotidiane che stanno al centro dell’esperienza umana. La nozione di “significato della vita” esige che consideriamo: – per cosa viviamo? – Quali sono o sarebbero i nostri bisogni interiori come accadimenti viventi? – Quali relazioni abbiamo o dovremmo avere nell’ordine naturale e sociale? – Come produciamo cose per i nostri bisogni immediati o per il mercato? – Come dobbiamo creare, mantenere e guadagnare i nostri mezzi di sostenta- mento? La proposta del paradigma di Andreas Weber è quella di spostare l’attenzione su una nuova domanda: – Cos’è la vita e quale ruolo ci giochiamo?
Esplorare cosa significhi la vita, discutere quali relazioni creare e mantenere e chiedersi come viverle, un tempo, era considerato il più alto esercizio della cognizione e della sensibilità umana. Ma, almeno per il secolo scorso, parlare di queste antiche dimensioni cruciali della vita è stato trattato come le polverose reliquie di qualche oscuro cimitero della storia intellettuale. È possibile che escludendo tali discorsi sulla vita, i suoi significati, le sue dimensioni e le tensioni interiori tra gli agenti viventi e le loro relazioni, abbiamo perso il punto di riferimento più importante per agire in modo saggio e sostenibile. Dopo tutto, chi negherebbe che è vivo? Eppure, le realtà esistenziali della vita sono trattate, in qualche modo, come troppo prosaiche o arcane da discutere.
Quindi, se si vuole recuperare un punto di riferimento affidabile per delineare quale potrebbe essere una vita sostenibile e, dunque, per trovare la saggezza per affrontare le molteplici crisi del nostro tempo, dobbiamo, prima, cercare un nuovo resoconto dei principi circa l’esistenza degli esseri viventi. Ciò richiede che riconsideriamo, attentamente, come le relazioni nella biosfera sono organizzate e sperimentate. Ci sono delle regole operative di base su come gli organismi realizzano la loro esistenza? Che cosa fa sani i sistemi ecologici? Cosa rende possibile l’esperienza individuale di una “vita piena”? In che modo lo scambio di beni, servizi e significato, è possibile senza degradare il sistema? L’obiettivo di occuparci di tali domande è quello di proporre spunti per la formulazione di una “politica di Enlivenment” o “vivificazione”.
Questi sono campi complicati e domande piuttosto concrete allo stesso tempo. Quindi non dovremmo avere paura di diventare troppo generici. Generazioni di “esperti” di diverse specialità scientifiche hanno ceduto a tale paura e si sono rifiutate di affrontare i fatti incomprensibili dell’esistenza vissuta. L’eredità lasciata da un pensiero così ristretto è stata devastante.
Al riguardo Andreas Weber9 propone di seguire un approccio piuttosto pragmatico: in primo luogo, occorre diagnosticare perché abbiamo un’avversione a pensare o parlare della “vita’. Infine, bisogna cercare di capire ciò che recenti ricerche scientifiche rivelano sullo svolgersi dei processi della vita e come ciò possa portare a un nuovo approccio che supera il modo di pensare dualista, la nostra abitudine riflessa di separare risorse e agenti naturali, la ragione e il mondo fisico, vita umana e natura sensibile, corpi fisici e significato umano.
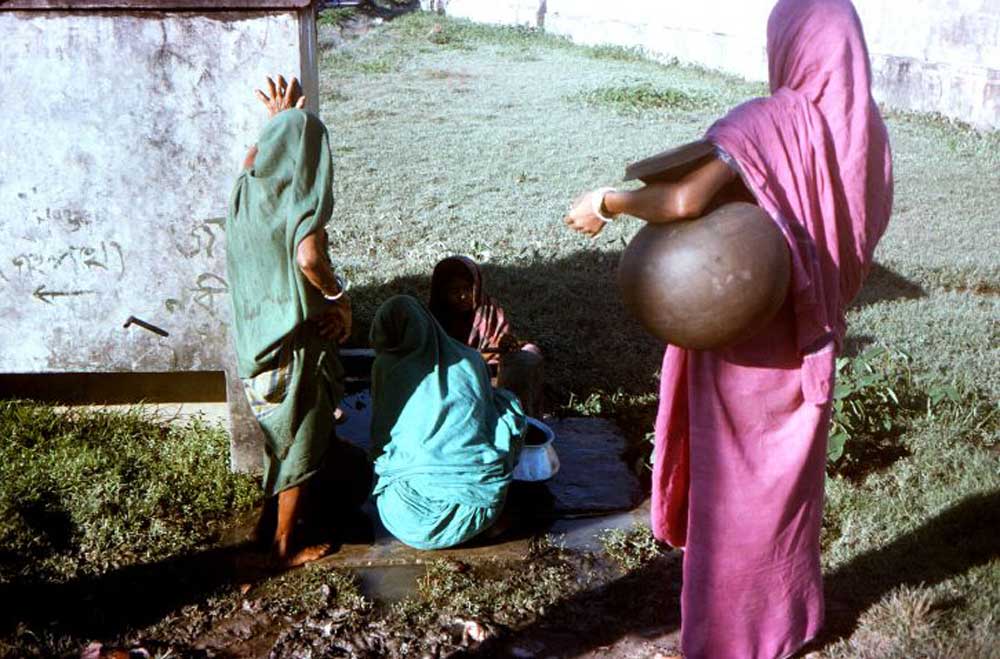
L’enlivenment è più della sostenibilità
Se si guarda indietro agli ultimi trent’anni di politica della sostenibilità, si possono osservare molti progressi: adozione di leggi per la protezione delle risorse naturali, impostazione di soglie di sicurezza per materiali tossici, divieto di fluorocarburi e così via. Ma la contraddizione di base rimane: consumiamo la biosfera di cui siamo parte e da cui dipendiamo. Da questa prospettiva,non siamo stati in grado di avvicinarci ad una soluzione della questione della sostenibilità, restiamo intrappolati nelle sue contraddizioni sottostanti fondamentali.
Al riguardo, la diversa visione della sostenibilità, che si può sviluppare seguendo il paradigma dell’Enlivenment di Andreas Weber, quindi, non pone l’accento sul miglioramento tecnico o sul “corretto” trattamento delle scarse risorse come priorità.Piuttosto, vede, nell’obiettivo di “condurre una vita più piena”, il più importante passo verso il cambiamento delle nostre relazioni con la Terra e tra di noi. Se si adotta questa prospettiva, si inizia a vedere che qualcosa è sostenibile se consente più vita – per me stesso, per gli altri individui umani coinvolti, per l’ecosistema – a un livello culturale più ampio. È fondamentale riscoprire il legame tra la nostra esperienza “interiore” e il mondo naturale “esterno”.
Per capire cosa significhi “più vita” [Enlivenment], dal punto di vista di una posizione di sostenibilità, e per aiutarci a mettere la specie umana e il resto della natura sullo stesso piano, Andreas Weber ci propone di considerare “la vita come dinamica corporea” quale denominatore comune per tutti gli organismi viventi. La vita è ciò che condividiamo tutti. E la vita è ciò che tutti possiamo provare: l’esperienza emotiva di sentire i nostri bisogni e di averli soddisfatti è un segno diretto di quanto bene realizziamo (o non realizziamo) la nostra vitalità o condizione di esseri viventi [aliveness]. Il mondo è un evento che costantemente esprime le sue capacità vitali intenzionali attraverso una continua interazione di relazioni significative. In questo scenario di “vita come dinamica corporea”, noi esseri umani, in quanto eventi naturali, sperimentiamo le forze e le strutture della natura tanto quanto gli altri organismi. Ma noi umani, in quanto specie, abbiamo il nostro modo specifico di rapportarci con l’apertura della natura e con lo svolgimento della storia naturale della libertà, vale a dire, con la cultura simbolica.10
Infatti, considerare la sostenibilità come ciò che ci rende vibranti con prospettive di crescita personale e di sviluppo, ci offre un campo di visione completamente nuovo per comprendere le sfide che dobbiamo affrontare. Oppure, come Cunningham lo ha espresso: nessuno di noi rimarrebbe molto colpito se alla nostra domanda – “Come va il tuo matrimonio?”, ci sentissimo rispondere – “Tutto bene”. Ma tutti volterebbero la testa se la risposta fosse: – “Bene, è energizzante. Mi fa sentire vivo”.11

Il new deal verde come economia antropocenica
L’idea di Enlivenment differisce dalle proposte popolari e sdolcinate per progettare una “green economy” o una campagna per un “New Deal Verde”.12 Nelle proposte della green economy, l’opposizione dualista tra cultura umana e natura come risorse non è nemmeno affrontata, per non parlare di risolta. Se non altro, queste politiche per affrontare la questione intensificano le tensioni dualistiche cercando di aumentare l’efficienza tecnologica e l’oggettivazione della natura.
Lo scopo di quest’argomentazione, però, non è fare una critica all’approccio della “economia verde” sulla base della sua incapacità di incitare al cambiamento reale. In verità, questo è difficile da giudicare. I critici, però, indicano l’effetto “rimbalzo” (o paradosso di Jevons),13 in cui l’aumento delle efficienze da “innovazioni verdi” può ridurre le risorse utilizzate in un dato mercato ma liberano, anche, quei soldi da spendere per altre cose, con il risultato di enormi aumenti netti della crescita economica e dell’uso delle risorse. Possiamo vedere questo effetto al lavoro nella maggiore produzione di anidride carbonica causata da tecnologie informatiche “efficienti” e da Internet. Si pensi solo alla quantità di energia elettrica richiesta dai sistemi di raffreddamento degli ambienti dove vive Internet.
Tutte le “rivoluzioni di efficienza” proposte indicano, invariabilmente, la natura stessa come il modello supremo di efficienza. Ma questo modello è sbagliato. LA NATURA NON È EFFICIENTE. È solo, in larga misura, commestibile o utilizzabile. Noi esseri viventi siamo un unico insieme, di cui, noi umani, costituiamo solo una frazione. Il vero difetto dell’approccio dell’efficienza alla sostenibilità è che la “natura” è ancora vista come qualcosa di “esterno” che può essere usata per mezzi umani. Ma la “natura” non è fuori di noi. È dentro di noi – e noi siamo dentro di essa.
C’è un LIMITE DI SOGLIA PER OGNI AUMENTO DI EFFICIENZA, e quel limite è L’IMPERFEZIONE NATURALE DI CIASCUN ORGANISMO – O LA NECESSARIA “IMPERFEZIONE” DI OGNI EVOLUZIONE. Noi esseri umani, come esseri naturali, soffriremo sempre di carenze: siamo mortali e pieni di contraddizioni. Una maggiore efficienza non è in grado di superare questa soglia. L’EFFICIENZA COME SOLUZIONE RAPPRESENTA, quindi, un “ERRORE DI CATEGORIA” NEL MODO DI PENSARE.
L’approccio dell’Enlivenment si differenzia dall’approccio “green economy” in un altro aspetto chiave: considerando che l’economia verde rimane impegnata nell’idea della “crescita” materiale come il modo eccellente per migliorare le condizioni di vita, l’approccio dell’Enlivenment riconosce che la natura non cresce in termini assoluti. Il “PIL della biosfera” (se uno può essere così assurdo) è rimasto costante per un tempo molto lungo. L’ecologia della natura è piuttosto un’economia stazionaria. L’unico fattore della natura che cresce è la dimensione “immateriale”, che potrebbe essere chiamata profondità dell’esperienza: la diversità delle forme naturali e la varietà di modi per sperimentare la vitalità [aliveness].
C’è un’altra prospettiva che cerca di affrontare la domanda di una sostenibilità globale ampiamente discussa oggi: “la prospettiva dell’antropocentrismo.14 L’idea è che ora stiamo vivendo nell’era “Antropocene”,15 un’epoca geologica in cui la cultura umana ha ampiamente superato le realtà bio-geo-chimiche delle famiglie e in cui gli umani possono dominare e controllare la materia, i flussi di energia, la distribuzione e l’esistenza delle specie biologiche. Nell’antropocentrismo la differenza tra uomo e natura è considerata risolta – ma non riconoscendo che tutti gli esseri viventi e i sistemi viventi sono soggetti alle stesse dinamiche naturali e ai principi creativi (come l’idea di Enlivenment tenta di proporre), ma assumendo che noi, umani, possiamo affermare la padronanza di tutta la natura inanimata e vivente sulla terra.
La posizione dell’antropocentrismo condivide con l’idea della green economy [economia verde] l’ipotesi antropocentrica che sostiene che possiamo e dobbiamo partire da un punto di vista unicamente umano per venire a patti con i problemi della sostenibilità. Entrambe considerano le distorsioni subite dalle teorie darwiniste e l’ideologia del libero mercato come le inesorabili premesse della vita economica. Una differenza radicale tra l’approccio antropocentrico e l’approccio di Enlivenment è la loro posizione verso la perfezione. Gli antropocentrici sono rigorosamente utopisti nel credere che si possano raggiungere schemi perfetti; il biocentrismo insito nella prospettiva dell’Enlivenment riconosce, come una questione teorica, il disordine inevitabile, le carenze e i vuoti di efficienza, che sono una parte inevitabile della realtà biologica e umana che nessun miglioramento culturale o tecnologico può eliminare.
La Scienza si ricollega alla Vita
A quanto pare, seguendo il pensiero di Andreas Weber, il rifiuto di studiare la vitalità [aliveness] come fenomeno scientifico si sta indebolendo. Oggi, infatti, discipline scientifiche, che hanno resistito storicamente a una visione del mondo che ci potrebbe aprire lo spazio per la comprensione della primordiale esperienza umana dei sentimenti degli organismi, hanno iniziato a cercare una via d’uscita. Indipendentemente l’una dall’altra, discipline come la biologia, la psicologia, la fisica e persino l’economia stanno riscoprendo il fenomeno della vita.
La biologia, in particolare, sta scoprendo che la sensibilità e l’espressione negli organismi non sono epifenomeni ma, piuttosto, il modo in cui gli esseri viventi esistono. Embriologi come Marc Kirschner e John Gerhart,16 biologi come Jesper Hoffmeyer17 e Kalevi Kull,18 e la teorica della scienza Elizabeth Fox Keller,19hanno iniziato a riconoscere che il significato [creazione di senso] e l’espressività sono, profondamente, radicati nel cuore della natura. Biologi dei sistemi come Lynn Margulis,20 Francisco Varela,21 Alicia Juarrero,22 Stuart Kauffman23 e Gregory Bateson24 hanno aperto un quadro in cui gli organismi non sono più visti come macchine in competizione con altre macchine ma, piuttosto, come un fenomeno naturale che si sviluppa in modo materiale mentre crea ed esprime, continuamente, esperienze. Essere vivi, questi ricercatori desiderano mostrare, non è solo un caso di causa-effetto ma, anche, una complicata interazione di interessi corporei e, quindi, di sentimenti. Neuroscienziati, come Antonio Damasio,25 hanno recentemente dimostrato che le emozioni, non la cognizione astratta, sono la sostanza della mente.
Se consideriamo tutti questi cambiamenti nella biologia contemporanea, emerge, necessariamente, un’immagine completamente diversa del mondo vivente. Stiamo iniziando a vedere che noi umani non esistiamo all’esterno o al margine della “natura”, ma siamo profondamente intrecciati nei processi di scambio materiali, mentali ed emotivi a cui partecipa tutto il mondo più che umano. Questo sta portando le scienze biologiche ad un grande cambiamento di paradigma simile a quello vissuto dalla fisica un secolo fa. Le scienze fisiche, per lungo tempo, non sono state in grado di realizzare che la separazione di un osservatore (soggetto) e un fenomeno osservato (oggetto) è un artefatto del pensiero causale-meccanico, lineare. Per la fisica quantistica, non esiste una cronologia locale o temporale. Piuttosto, ogni evento può essere collegato a qualsiasi altro.26 Il fisico David Bohm lo ha definito “l’ordine implicato” del cosmo.27 Questa visione non solo mette in discussione località e cronologia, essa offusca, anche, la separazione della realtà fisica e psicologica. Esistiamo in uno spazio-tempo che è un continuum di “interni” (significati) e “esterni” (corpi).
Anche la ricerca sul paradigma dei beni comuni28 cerca di documentare l’ipotesi che qualsiasi attività economica, alla sua base, non è solo uno scambio di oggetti e denaro ma, anche, un ricco insieme di flussi e relazioni in corso. Relazioni che comprendono sia le relazioni umane che le relazioni con gli ecosistemi naturali. Gli umani sono costantemente impegnati in scambi ecologici di doni che non solo distribuiscono beni e servizi materiali, ma generano, anche, un senso di appartenenza e di impegno, e, quindi, di sentimento e significato.29 Da questo punto di vista, lo scambio economico non può distinguere, significativamente, tra agenti e risorse come entità totalmente indipendenti; sono entrambi impigliati gli uni con li altri. Allo stesso modo, la terra e i suoi abitanti non possono essere completamente separati, sono reciprocamente dipendenti. In ogni dato habitat, lo scambio ecologico porta con sé flussi reciproci di materia, energia e relazione esistenziale.30
Infine, nella loro pratica, anche gli artisti stanno scoprendo che i processi creativi sono in grado di cambiare la percezione. L’immaginazione può portare cambiamenti produttivi in sé stessi e nel mondo. L’eco-psicologia31 cerca di documentare l’ipotesi che propone che solo sperimentando gli altri esseri di un mondo non solo umano possiamo afferrare e sviluppare le nostre qualità più profonde come esseri umani.32 La nuova immagine della realtà promessa dalle arti e dalle scienze è quella di un universo profondamente senziente e significativo. Universo poetico produttivo di nuove forme di vita e di esperienze corporee espressive di tutte le esperienze soggettive che gli individui fanno. È un universo in cui noi umani non siamo più separati dagli altri organismi ma piuttosto formiamo un intreccio di relazioni esistenziali – una vera “rete di vita”. Questa “carne del mondo”, come la definiva il filosofo francese Merleau-Ponty, è forse meglio intesa come un gioco creativo di superamento dei paradossi irrisolvibili di momento in momento, indipendentemente dal regno: ecologia, cultura, economia o arte.33
Da questa prospettiva, qualsiasi politica di promozione della sostenibilità acquisisce un nuovo ambito e nuove metriche di successo. La sostenibilità può avere successo solo se migliora la vitalità [l’aliveness, cioè, la condizione di essere vivente interconnesso] degli agenti umani, della natura e della società. Quindi, potrebbe essere un arricchimento per sviluppare più deliberate “politiche di vivificazione o enlivenment”, non come una questione di leggi naturali che dettano l’ordine della società umana ma come una strategia per onorare i molteplici bisogni incarnati degli individui o organismi senzienti in un mondo che non è solo umano.

Conclusione: enlivenment, una nuova narrativa delle relazioni viventi
Attraverso questa breve argomentazione si rende palese la necessità di esplorare una nuova narrativa circa ciò che la vita è, circa ciò che è il significato di essere viventi, circa ciò che i sistemi viventi fanno e quali sono i loro “obiettivi”.34 Dobbiamo esplorare come i valori sono generati dalla cognizione di ciò che è vivente e come noi, quali esseri viventi in una biosfera vivente, possiamo adattare la produzione necessaria per i nostri mezzi di sussistenza a quella realtà, l’unica realtà che abbiamo. Anche se questa narrativa comprenderà aree e discipline diverse, la vita è la dimensione vincolante per tutte loro. In quanto essere vivente, l’organismo umano integra e collega diversi campi dell’esperienza esistenziale, dello scambio metabolico e delle relazioni sociali.
La narrativa che si propone, seguendo il paradigma di Andreas Weber, non è affatto un resoconto oggettivista, né una meccanica o una cibernetica della realtà. Essa solo potrebbe essere considerata “oggettiva” nel senso che la poetica è “oggettiva”, in quanto trasmette sentimenti condivisi, lavorando nella dimensione aperta dell’immaginazione continua, che è il campo della vita stessa. La narrativa del mondo vivente che si desidera proporre è quella della “oggettività poetica” o “precisione poetica” in quando costituisce un modo appropriato per descrivere il mondo vivente con il suo infinito dispiegarsi di relazioni e significati esistenziali.
La natura, nella prospettiva vivificante, non è un oggetto meccanico-causale ma una rete relazionale tra “soggetti” che hanno interessi individuali per rimanere vivi, crescere e svilupparsi. L’enlivenment significa spingere il pensiero biologico oltre il paradigma oggettivistico in cui è ora imprigionato ed emulare il cambiamento che la fisica fece 100 anni fa quando si spostò al di là del pensiero newtoniano. Porre fine all’approccio newtoniano alla biosfera, ad altri organismi, a noi stessi come esseri viventi e all’insieme dei processi di scambi ecologici ed economici, significherà riconoscere che noi, in quanto osservatori umani, siamo tanto vivi ed espressivi quanto gli altri organismi ed ecosistemi che noi osserviamo. Una tale biologia è, enfaticamente, non riduzionista.Il suo obiettivo principale è capire come può nascere la libertà e, tuttavia, essere ancorati in un mondo materiale vivente.
Quest’argomentazione sull’Enlivenment di Andreas Weber è in linea con la recente svolta culturale del biologo evoluzionista Edward O. Wilson, in cui prende le distanze dalla interpretazione “egoistica” dell’evoluzione, affermando che abbiamo bisogno di un “Secondo Illuminismo”.35 Se i processi naturali, inevitabilmente, producono soggettività, significati e sentimenti, la nostra scienza, la nostra politica ed economia, basate sulla scienza, devono tenere conto di queste dimensioni vissute. Ciò di cui c’è bisogno è di un “Enlivenment” come “Secondo Illuminismo” – una nuova fase di evoluzione culturale che possa salvaguardare i nostri ideali scientifici (e democratici) di accesso comune alla conoscenza e ai poteri ad essa connessi, convalidando, allo stesso tempo, l’esperienza personale sentita e soggettiva: l’essenza che definisce l’esperienza vissuta dei corpi. L’approccio dell’Enlivenment include altri esseri animati oltre agli umani, che, dopo tutto, condividono le stesse capacità di esperire vissuti corporei e di “costruire mondi di sensi”.
L’enlivenment, quindi, non è un altro racconto naturalistico, per descrivere noi stessi e il nostro mondo, che può, quindi, dettare, automaticamente, politiche specifiche o soluzioni economiche. La riflessione che si propone è, invero,“naturalistica” ma offre un “naturalismo selvaggio” nel senso di David Abram,36 un naturalismo che si basa sull’idea della natura come un processo in continua evoluzione di libertà e creatività, paradossalmente legate a processi materiali e corporei. La biosfera è viva nel senso che non obbedisce solo alle regole delle interazioni deterministiche o stocastiche di particelle, molecole, atomi, campi e onde. La biosfera, nella sua “imperfezione”, riguarda, anche, il senso dell’agire, dell’espressione e del significato trascendente.
- Andreas Weber. Enlivenment: Towards a fundamental shift in the concepts of nature, culture and politics. In Heinrich Böll Stiftung. The Green Political Foundation, Berlin, 2013.
- Ibidem
- Andreas Weber. Enlivening the crisis: Looking beyond the current ideology of death. In “Enlivenment: Towards a fundamental shift in the concepts of nature, culture and politics. Heinrich Böll Stiftung.’ The Green Political Foundation, Berlin, 2013.
- Deborah Wan (2012): “Foreword”. In: Depression: A global Crisis. World Federation for Mental Health, World Mental Health Day October 10, 2012,p. 2.
- Rasoio di Occam (Novacula Occami) è il nome con cui viene contraddistinto un principio metodologico espresso nel XIV secolo dal filosofo e frate William of Ockham. Tale principio, ritenuto alla base del pensiero scientifico moderno, nella sua forma più immediata suggerisce l’inutilità di formulare più ipotesi di quelle che siano necessarie per spiegare un dato fenomeno quando quelle iniziali siano sufficienti.
- Andreas Weber. Enlivening the crisis: Looking beyond the current ideology of death. In “Enlivenment: Towards a fundamental shift in the concepts of nature, culture and politics. Heinrich Böll Stiftung.’ The Green Political Foundation, Berlin, 2013.
- Max Horkheimer & Theodor W. Adorno (1983): Dialektik der Aufklärung. Frankfurt a. Main: Suhrkamp.
- David Abram (1996): The Spell of the Sensuous: Perception and Language in a More Than Human World. New York: Pantheon.
- Andreas Weber. Enlivenment: Towards a fundamental shift in the concepts of nature, culture and politics. In Heinrich Böll Stiftung. The Green PoliticalFoundation, Berlin, 2013.
- Per un approccio approfondito della questione dal punto di vista della bio-poetica si veda Andreas Weber. “Cognition as Expression. On the autopoietic foundations of an aesthetic theory of nature”, 2001; Sign System Studies 29(1): 153-168; id. (2007): Alles fühlt. Mensch, Natur und die Revolution der Lebenswissenschaften. Berlin: Berlin Verlag; id. (2010): “The Book of Desire: Towards a Biological Poetics”. Biosemiotics 4(2):32-58; id. (2012): “There is no outside. A Biological Corollary for Poetic Space”. In Silver Rattasepp, Tyler Bennett, eds.: Gatherings in Biosemiotics. Tartu Semiotics Library 11. Tartu: University of Tartu Press, 225-226.
- Storm Cunningham (2008): reWealth!: Stake Your Claim in the $2 Trillion reDevelopment Trend That’s Renewing the World. Washington: McGrawHill.
- Ralf Fücks (2013): Intelligent wachsen: Die grüne Revolution. München: Hanser; Thomas L. Friedman (2010): Was zu tun ist: Eine Agenda für das 21. Jahrhundert. Frank- furt am Main: Suhrkamp; see also Andreas Weber (2008): Biokapital. Die Versöhnung von Ökonomie, Natur und Menschlichkeit. Berlin: Berlin-Verlag.
- Il cosiddetto paradosso di Jevons è una tesi che nasce da un’osservazione dell’economista William Stanley Jevons, secondo cui i miglioramenti tecnologici che aumentano l’efficienza di una risorsa possono fare aumentare il consumo di quella risorsa, anziché diminuirlo. La sua affermazione appare paradossale perché contraddice il senso comune, ma non esprime un’antinomia ed è, anzi, accolta nell’ambito della riflessione teorica. L’aumento di efficienza si traduce in una diminuzione di costi e, quindi, in un aumento dei consumi. Se l’aumento avvenga o meno dipende dall’elasticità della domanda. Se la domanda è rigida, la variazione di prezzo non induce sensibili variazioni nel consumo dell’output e quindi induce una diminuzione del consumo dell’input della risorsa. Viceversa, se la domanda è elastica (variazioni di prezzo producono aumenti nel consumo dell’output), ci sono incrementi anche nell’input. Si tratta del cosiddetto ‘effetto rebound’. Il paradosso è enunciato nel libro The Coal Question (1865), ove Jevons osservava che il consumo di carbone in Inghilterra era cresciuto dopo che James Watt aveva introdotto il motore a vapore, alimentato a carbone, che aveva un’efficienza maggiore dell’efficienza del motore di Thomas Newcomen (la macchina a vapore di Newcomen). Con le innovazioni di Watt il carbone diventò una fonte di energia più redditizia e si pervenne ad un suo maggiore consumo. Quindi, il consumo di carbone aumentò, pur essendo diminuita la quantità di carbone richiesta per produrre il medesimo lavoro.
- http://www.federica.unina.it/economia/etica-ambiente/prospettiva-antropocentrica-biocentrica-scientifica/
- Antropocene è un termine coniato negli anni ottanta dal biologo Eugene Stoermer che nel 2000 fu adottato dal Premio Nobel per la chimica Paul Crutzen nel libro Benvenuti nell’Antropocene. Il termine indica l’epoca geologica attuale, nella quale all’essere umano e alla sua attività sono attribuite le cause principali delle modifiche territoriali, strutturali e climatiche. Il termine deriva dal greco anthropos, che significa uomo, e almeno inizialmente non sostituiva il termine corrente usato per l’epoca geologica attuale, Olocene, ma serviva semplicemente ad indicare l’impatto che l’Homo sapiens ha sull’equilibrio del pianeta. Tuttavia, più recentemente le organizzazioni internazionali dei geologi stanno considerando l’adozione del termine per indicare appunto una nuova epoca geologica in base a precise considerazioni stratigrafiche.
- Marc Kirschner & John Gerhart. Cells, Embryos, and Evolution: Toward a Cellular and Developmental Understanding of Phenotypic Variation and Evolutionary Adaptabil- Blackwell’s, 1997
Marc Kirschner & John Gerhart. The Plausibility of Life: Resolving Darwin’s Dilemma. Yale University Press, 2005. - Jesper Hoffmeyer: Signs of Meaning in the Universe. Indiana University Press, USA, 1996.
Biosemiotics. An Examination into the Signs of Life and the Life of Signs, University of Scranton Press, Scranton PA, USA, 2008.
A Legacy for Living Systems. Gregory Bateson as Precursor to Biosemiotics. Dordrecht, Springer 2008.
Semiotic Freedom: an Emerging Force in Davis, Paul and Gregersen, Niels Henrik (eds.): Information and the Nature of Reality. From Physics to Metaphysics, Cambridge University Press, Cambridge, 185-204, 2010.
Baldwin and Biosemiotics: What Intelligence Is For. In: Bruce H. Weber and David J. Depew (eds.): Evolution and Learning – The Baldwin Effect Reconsidered’. The MIT Press, Cambridge, USA, 2003. (co-authored by Kalevi Kull). - Emmeche, Claus; Kull, Kalevi (eds.) Towards a Semiotic Biology: Life is the Action of Signs. London, Imperial College Press, 2011.
- Elizabeth Fox A Feeling for the Organism: The Life and Work of Barbara McClintock. Freeman, 1983.
Secrets of Life/Secrets of Death: Essays on Language, Gender and Routledge, 1992.
Refiguring Life: Metaphors of Twentieth-century The Wellek Library Lecture Series at the University of California, Irvine. ColumbiaUniversity Press, 1995.
Keywords in Evolutionary Biology (co-edited with Elisabeth Lloyd). Harvard University Press, 1998.
The Century of the Harvard University Press, 2000.
Making Sense of Life: Explaining Biological Development with Models, Metaphors, and Harvard University Press, 2002.
The Mirage of a Space between Nature and Nurture. Duke University Press, 2010 - Lynn Margulis (1999): Symbiotic Planet: A New Look at Evolution. New York: Basic Books.
- Francisco J. Varela, Evan T. Thompson, Eleanor Rosch (1993): The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. Cambridge: MITPress.
- Alicia Juarrero (1999): Dynamics in Action. Internal Behaviour as a Complex System, Cambridge: MIT Press.
- Stuart Kauffman (1996): At Home in the Universe: The Search for the Laws of Self-Organization and Complexity. Amer Chemical Society.
- Gregory Bateson (1972): Steps to an Ecology of Mind. New York: Ballantine.
- Antonio Damasio (2000):The Feeling of What Happens: Body and Emotion in the Making of Consciousness. New York: Harcourt Brace.
- Andreas Weber & Francisco J. Varela (2002): “Life after Kant. Natural purposes and the autopoietic foundations of biological individuality“. Phenomenology and the Cognitive Sciences 1: 97-125.
- Nel suo libro Universo, mente e materia, Bohm teorizza l’esistenza nell’universo di un ordine implicito (implicate order), che non siamo in grado di percepire, e di un ordine esplicito (explicate order), che percepiamo come risultato dell’interpretazione che il nostro cervello dà alle onde (o pattern) di interferenza che compongono l’universo. Bohm paragona l’ordine implicito a un ologramma, la cui struttura complessiva è identificabile in quella di ogni sua singola parte: il principio di località risulterebbe perciò falso. Poiché Bohm riteneva che l’universo fosse un sistema dinamico in continuo movimento, mentre il termine ologramma solitamente si riferisce a un’immagine statica, Bohm preferiva descrivere l’universo utilizzando il termine, da lui creato, di Olomovimento. Dopo l’esperimento del 1982, in cui il teorema di John Stewart Bell fu verificatoda Alain Aspect, rivelando una comunicazione istantanea fra fotoni a distanze infinitamente grandi, Bohm, che si era già confrontato con lo stesso problema durante la sua riformulazione del paradosso di Einstein-Podolsky-Rosen, ribadì che non esisteva alcuna propagazione di segnale a velocità superiori a quella della luce, e che si trattava di un fenomeno non riconducibile a misurazione spazio-temporale. Il legame tra fotoni generati da una medesima particella sarebbe dovuto all’ordine implicito, nel quale ogni particella non è separata o “autonoma”, ma fa parte di un ordine atemporale e aspaziale universale, l’Olomovimento, il cui modello matematico implica un insieme di variabili nascoste. Bohm scrisse che «dobbiamo imparare a osservare qualsiasi cosa come parte di un’Indivisa Interezza» (Undivided Wholeness), cioè che tutto è uno.
- Sia l’attuale economia mondiale sia l’ordine giuridico che le è proprio sono evidentemente insostenibili, si rivela quindi urgentemente necessario un nuovo ordine eco-giuridico basato sull’alfabetizzazione ecologica, l’equa condivisione dei beni comuni, l’impegno civico e la partecipazione”. È questo il rivoluzionario concetto cardine di ‘The Ecology of Law’ del fisico e teorico dei sistemi Fritjof Capra e dello studioso del diritto Ugo Mattei. Il concetto propone una profonda revisione dei fondamenti stessi del sistema giuridico occidentale partendo dalla considerazione che quello attuale è corresponsabile di un mondo caratterizzato da crisi sociali, economiche, ambientali.
- Fritjof Capra & Ugo Mattei. The Ecology of Law: Toward a Legal System in Tune with Nature and Community. Berrett-Koehler, 2015.
- Lewis Hyde (2007): The Gift. Creativity and the Artist in the Modern World. New York: Random House.
- L’ecopsicologia nasce all’inizio degli anni novanta a partire dalla constatazione di una correlazione esistente tra il crescente disagio esistenziale, individuale e sociale, e l’aumento del degrado ambientale, parallelo al rapido processo di urbanizzazione che ha cambiato radicalmente stili di vita e abitudini di una grande parte della popolazione mondiale. La perdita di connessione con l’ambiente naturale viene considerata come una rilevante causa di malessere psichico e l’impegno dell’ecopsicologia diventa quello di favorire la riconnessione con quanto dimenticato, o rimosso dalla modernizzazione, per integrare l’eredità del passato con i traguardi presenti e le sfide future.
- Abram (1996), op. cit.
- Maurice Merleau-Ponty (1964): Le visible et l’invisible. Paris: Gallimard
- Per una definizione operazionale di ‘vita’, si veda Rinaldo Octavio Vargas & Eugenia D’Alterio. Alla ricerca di una definizione operazionale divita – La molecola a tempo indeterminato. BIO Educational Papers Medicina Costruzione Sociale nella Post-Modernità Retroscena. Anno I, Numero 1, Marzo 2012.
- Edward O. Wilson (2012): The Social Conquest of the Earth. Cambridge: Harvard University Press.
- David Abram. Becoming Animal: An Earthly Cosmology (2010) & The Spell of the Sensuous: Perception and Language in a More-than-HumanWorld (1996).