BIO – Medicina Costruzione Sociale nella Post-Modernità – Educational Papers • Anno VIII • Numero 31 • Settembre 2019
Il serpente secolarizzato
Dalla tentazione di Eva all’assassinio col veleno di serpente del potente Thor, il serpente appare nel tempo e nelle culture come una figura di malizia e miseria. La presenza universale di serpenti nella religione, nel mito e nel folklore denota una nostra profonda relazione con questo rettile. Tuttavia, tale rapporto risulta alquanto paradossale perché, effettivamente, pochi di noi abbiamo avuto alcun tipo di esperienza diretta con dei serpenti. La sorprendente risposta, suggerisce Lynne Isbell1, sta nel singolare impatto degli ofidi sull’evoluzione dei primati. La pressione predatoria dei serpenti, ci segnala la ricercatrice, sarebbe, in definitiva, la responsabile della visione superiore e del grande cervello dei primati – e per un aspetto critico anche dell’evoluzione umana.
Basandosi su ricerche approfondite, la Isbell specula su come i serpenti possano aver influenzato lo sviluppo di un comportamento tipicamente umano: la nostra capacità di localizzare nello spazio attorno a noi allo scopo di dirigere la nostra attenzione. Un’attività sociale dipende da una localizzazione rapida e accurata, analogamente la capacità di localizzare riduceva il morso di serpenti mortali tra i nostri antenati ominidi. Tale capacità figurò anche nel comportamento umano successivo. Infatti, i serpenti diedero agli ominidi bipedi, già dotati di un sistema di comunicazione non umano, la spinta evolutiva per localizzare e comunicare per il bene sociale, un passo critico verso l’evoluzione del linguaggio e tutto ciò che seguì.
La visione dei primati e la teoria del rilevamento del serpente
Studiosi in materia, come Lynne A Isbell, sostengono che l’evoluzione abbia favorito la modifica e l’espansione della visione dei primati. Rispetto ad altri mammiferi, i primati hanno, per esempio, una maggiore percezione della profondità per il fatto di avere occhi rivolti in avanti con campi visivi sovrapposti estensivamente, acuità visiva più nitida, più aree del cervello coinvolte nella visione e, in alcuni di loro, visione dei colori tricromatica, che consente di distinguere il rosso dai toni verdi. Al riguardo, si sostiene che ciò che distingue maggiormente i primati dagli altri mammiferi è la loro maggiore dipendenza dalla visione come principale interfaccia sensoriale con l’ambiente.
La visione è una finestra sul mondo. Le sue qualità, dalla prospettiva evoluzionista, sono determinate dalla selezione naturale, dai vincoli dei corpi degli animali e dai vincoli degli ambienti in cui vivono. Nonostante la loro lunga storia evolutiva condivisa, i mammiferi non avvistano il mondo allo stesso modo perché abitano in una varietà di nicchie con diverse pressioni selettive. Questo fenomeno di diversità percettiva visiva ci muove a chiederci quali sarebbero state quelle pressioni selettive per i primati, nostro lignaggio, che portarono loro ad avere sistemi visivi più estesi e più complessi di quelli di altri mammiferi?
Nel 2006, è stata pubblicata una nuova interpretazione che intende rispondere a questa domanda e molto altro: la “teoria del rilevamento del serpente”2. Questa teoria considera che quando serpenti costrittori a bocca aperta apparivano circa 100 milioni di anni fa e cominciavano a predare i mammiferi, il loro comportamento predatorio favorì l’evoluzione dei cambiamenti nella visione di un tipo di preda: il lignaggio che sarebbe diventato dei primati. In altre parole, la capacità di vedere i serpenti predatori immobili prima di avvicinarsi troppo diventò un tratto molto vantaggioso da possedere e, successivamente, trasmettere ai loro discendenti. Poi, circa 60 milioni di anni fa, serpenti velenosi apparvero in Africa o in Asia, aggiungendo più pressione sui primati per individuarli ed evitarli. Questo ebbe anche avuto ripercussioni sui loro sistemi visivi.
Stando alle inferenze degli studiosi, c’è una coerenza tra il grado di complessità nei sistemi visivi dei primati e la durata del tempo evolutivo che i primati stessi trascorsero con serpenti velenosi. Ad un estremo, il lignaggio dei primati, che comprende delle piccole scimmie con coda del Vecchio Mondo [MONKEYS], delle scimmie con grande cervello, quali gli scimpanzé, i bonobo, i gorilla, gli oranghi, i gibbone [APES] e degli umani, avrebbe la migliore visione di tutti i primati, tra cui un’acuità visiva eccellente e una visione a colori completamente tricromatica. Essendosi evoluti all’incirca nello stesso tempo e nello stesso luogo dei serpenti velenosi, questi primati hanno avuto una continua convivenza con loro, diventando diffidenti nei confronti dei serpenti.
All’estremo opposto dello spettro, i primati del Madagascar hanno i sistemi visivi più semplici. Tra le altre cose, posseggono una bassa acuità visiva perché la fovea, una depressione nella retina ritenuta responsabile della nostra acutezza visiva ovunque focalizziamo i nostri occhi, è poco sviluppata, qualora presente. Sebbene il Madagascar abbia serpenti costrittori, non ha serpenti velenosi, quindi i primati su quell’isola non hanno mai dovuto affrontare quella particolare pressione selettiva. Le prove comportamentali rivelano, anche, che non tutti i primati del Madagascar reagiscono con timore ai serpenti. Alcuni camminano persino su serpenti o modelli di serpenti, trattandoli come se fossero solo un altro ramo.
I sistemi visivi delle scimmie del Nuovo Mondo si trovano nel mezzo dello spettro. Hanno una migliore acuità visiva rispetto ai primati del Madagascar, ma una maggiore variabilità nei loro sistemi visivi rispetto alle scimmie del Vecchio Mondo. Ad esempio, le scimmie urlatrici del Nuovo Mondo sono tutte tricromatiche, ma in altre specie di primati del Nuovo Mondo, solo alcuni individui sono in grado di distinguere il rosso dai toni verdi. I primati del Nuovo Mondo facevano originariamente parte del lignaggio dei primati antropoidi in Africa, comprendente, anche, scimmie piccole con coda del Vecchio Mondo e scimmie senza code e cervello più grande, e avrebbero dovuto occuparsi di serpenti velenosi per circa 20-25 milioni di anni, per poi, circa 36 milioni di anni fa, lasciare l’Africa e arrivare in Sud America dove i serpenti velenosi non erano presenti fino a circa 15 milioni di anni dopo. A quel punto, stando alle interpretazioni degli studiosi, le scimmie del Nuovo Mondo cominciarono a diversificarsi in generi diversi, e così ogni genere sviluppò soluzioni separate al rinnovato problema causato dall’arrivo di serpenti velenosi. Lynne A Isbell sostiene che non esiste altra spiegazione per la variazione nei loro sistemi visivi.3
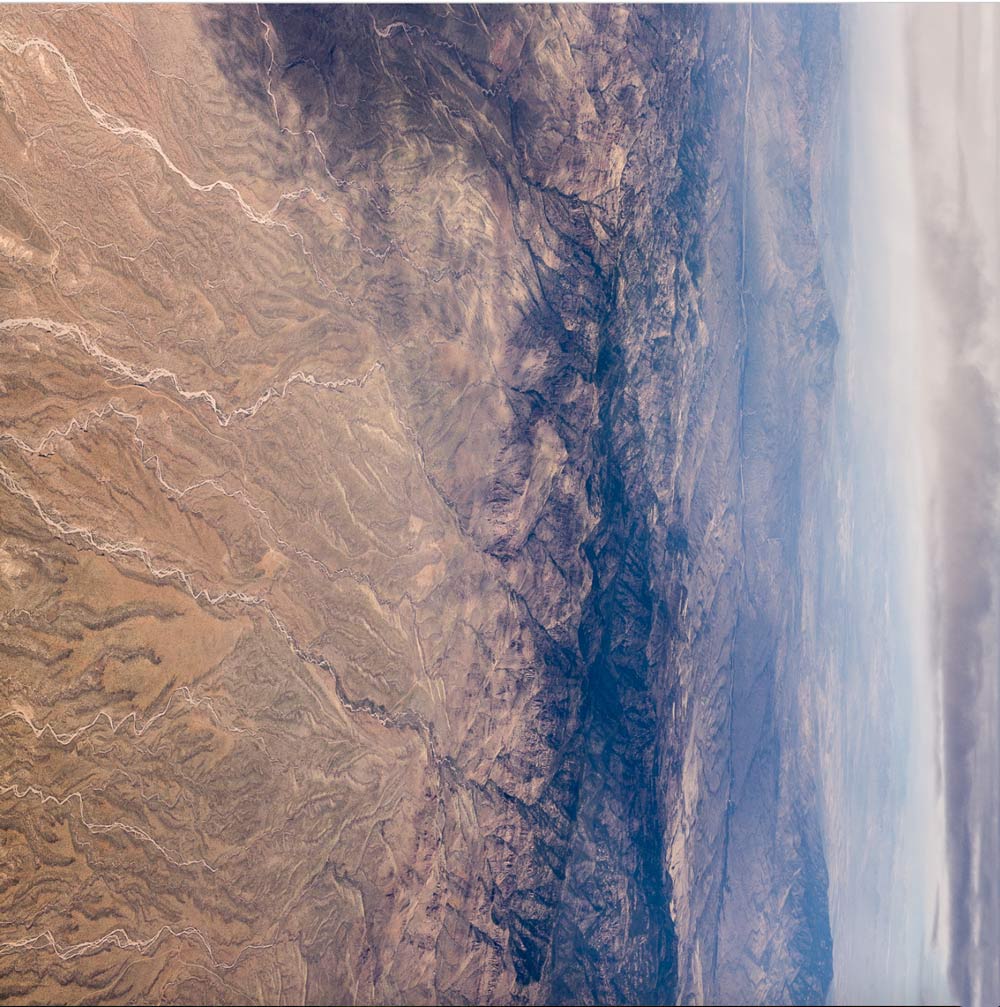
Nostro pregiudizio visivo nei confronti dei serpenti
Da quando Lynne A Isbell ha proposto la “teoria del rilevamento del serpente”, diversi studi4 dimostrarono che primati non umani e, anche, umani, compresi bambini piccoli e infanti ancora ingenui verso i serpenti, avevano un pregiudizio visivo verso i serpenti rispetto ad altri oggetti animati, come lucertole, ragni, vermi, uccelli e fiori. Gli psicologi rilevarono che noi umani cogliamo le immagini dei serpenti più velocemente o più accuratamente di altri oggetti, specialmente in condizioni di disordine o oscuramento che assomigliano ai tipi di ambienti in cui si trovano tipicamente i serpenti. Ugualmente i serpenti ci distrarrebbero5 dal trovare altri oggetti altrettanto rapidamente. La capacità umana di rilevare i serpenti più velocemente è anche, più pronunciata quando abbiamo meno tempo per rilevarli e quando si trovano nella nostra immediata periferia. Inoltre, secondo i rilevamenti degli studiosi Langeslag e van Strien, la nostra ‘area visiva primaria’ nella parte posteriore del cervello mostra6 risposte elettrofisiologiche più forti a immagini di serpenti che di lucertole da 150 a 300 millisecondi dopo che le persone vedono le immagini, fornendo una correlazione fisica misurabile del nostro maggiore pregiudizio visivo nei loro confronti.
Poiché le attività che regolerebbero la visione sembrano localizzate principalmente nel cervello, dobbiamo rivolgerci alle neuroscienze per comprendere i meccanismi del nostro pregiudizio visivo nei confronti dei serpenti. Tutti i vertebrati hanno un sistema visivo7 che consente loro di distinguere potenziali predatori da potenziali prede. Questo è un sistema visivo non conscio che coinvolge8 solo strutture sottocorticali, incluse quelle che nei mammiferi sono chiamate collicolo superiore e pulvinar, e consentirebbero una rilevazione visiva e una risposta molto veloci. Quando un animale vede un predatore, questo sistema visivo non conscio attingere direttamente anche a risposte motorie come il freezing9 e il darting10.
Come vertebrati, i mammiferi non solo hanno questo sistema visivo non conscio ma posseggono, anche, incorporata, la visione nella neocorteccia. Nessun altro animale ha una neocorteccia. Questo sistema visivo, un po’ più lento e consapevole, consente ai mammiferi di prendere coscienza degli oggetti per quello che realmente sono. Il primo arresto neocorticale è l’area visiva primaria, particolarmente sensibile ai bordi e alle linee di diversi orientamenti11.
In uno studio ritenuto dagli esperti in materia “rivoluzionario”12, un gruppo di neuro-scienziati ha sondato le risposte dei singoli neuroni nel pulvinar di macachi giapponesi mentre gli venivano mostrate immagini di serpenti, volti di scimmie, mani di scimmie e semplici forme geometriche. Documentato con accuratezza, molti neuroni pulvinar hanno risposto più forte e più rapidamente ai serpenti che alle altre immagini. I neuroni sensibili al serpente sono stati trovati in una sottosezione del pulvinar che è collegata a una parte del collicolo superiore coinvolto nel comportamento motorio difensivo come il freezing e il darting, e all’amigdala, struttura subcorticale coinvolta nella mediazione delle risposte di paura. Tra tutti i mammiferi, i primati, il lignaggio con la più grande esposizione evolutiva ai serpenti velenosi, comprendente scimmie antropoidi, scimpanzé e altri primati senza coda e di cervello grande come bonobo, gorilla, orango, gibbone e gli umani, ha anche il più grande pulvinar. Questo ha perfettamente senso nel contesto della teoria del rilevamento del serpente.
L’ophidiofobia quale prova della nostra stretta relazione evolutiva con la natura
Se ancora una volta ci ponessimo la domanda circa cosa succeda con i serpenti che li renderebbe così “affascinanti”? Naturalmente, per risponderle potremmo utilizzare tutti gli spunti disponibili come, ad esempio, la forma del corpo oppure l’assenza di gambe. Stando, però, alle considerazioni di esperti, come Isbell e Etting13, la loro scaglia potrebbe essere ritenuta una chiave importante per rispondere alla nostra domanda. A parer loro, sembra che la sola percezione visiva di una piccola chiazza della pelle del serpente possa essere sufficiente per farci scattare in una reazione di paura difensiva. Le scimmie vervet selvatiche dell’Africa, ad esempio, sono in grado, con la loro superba acutezza visiva, di rilevare solo un centimetro di pelle di serpente entro un minuto dal suo avvicinarsi. Nelle persone, le risposte elettrofisiologiche nell’area visiva primaria rivelano una maggiore attenzione visiva iniziale alle scaglie di serpente rispetto alle pelli di lucertola e alle penne degli uccelli. Di nuovo, l’area visiva primaria risulta poi molto sensibile ai bordi e alle linee di diversi orientamenti e le pelli di serpente, con le loro scaglie a picca, offrono questi spunti visivi.
Indubbiamente, la teoria del rilevamento del serpente prende i nostri atteggiamenti apparentemente contraddittori sui serpenti e li rende un insieme coerente. La nostra lunga esposizione evolutiva ai serpenti spiega perché l’ophidiofobia sia la fobia più segnalata dell’umanità. L’attrazione e l’attenzione umana ai serpenti è così forte che li abbiamo persino inclusi in modo prominente nelle religioni e nel folklore.
L’interesse editoriale di BIO nella teoria del rilevamento del serpente vorrebbe, però, spingerci oltre alla questione specialistica, proponendovi la seguente considerazione riconoscendo che la nostra visione il nostro comportamento sono stati plasmati da milioni di anni di interazioni con un altro tipo di animale, ammettiamo la nostra stretta relazione con la natura. Infatti, non siamo mai stati al di sopra o al di fuori della natura, come vorremmo pensare, ma ne abbiamo sempre fatto pienamente parte.
- Lynne A Isbell. The Fruit, the Tree, and the Serpent: Why We See So Well. Harvard University Press, 2009
- Lynne A Isbell. Snakes as agents of evolutionary change in primate brains. In “Journal of human evolution”, 51(1): 1-35, Jul. 2006
- Lynne A Isbell. Snakes as agents of evolutionary change in primate brains. In “Journal of human evolution”, 51(1): 1-35, Jul. 2006
- V. LoBue & JS DeLoache. Superior detection of threat-relevant stimuli in infancy. In “Developmental science”, 13(1): 221-8, Jan. 2010SC Soares, B Lindström, F Esteves & A Ohman. The Hidden Snake in the Grass: Superior Detection of Snakes in Challenging AttentionalConditions. In “Plos One”, 9(12): 114724, Dec. 2014
- SC Soares. The lurking snake in the grass: interference of snake stimuli in visually taxing conditions. In “Evolutionary psychology”, 10(2): 187-97, April 2012
- Langeslag SJE, JW van Strien. Early visual processing of snakes and angry faces: An ERP study. In “Brain Research”, 1678: 297-303, Jan 2018
- L’apparato visivo dei vertebrati è formato da due organi esterni pari e simmetrici posti nella regione anteriore della testa, gli occhi, considerati come un’appendice dell’encefalo, sia per derivazione embriologica, sia per una serie di correlazioni funzionali, come la capacità integrativa propria delle strutture nervose, che si ritrova a livello della retina. L’apparato visivo nel suo insieme è un sistema di elaborazione specializzato formato da un insieme di zone cerebrali diverse.
- Sc Soares, RS Maior, LA Isbell, C Tamaz & H Nishijo. Fast Detector/First Responder: Interactions between the Superior Colliculus-Pulvinar Pathway and Stimuli Relevant to Primates. In “Frontiers in neuroscience”, 11:67, Feb 2017
- La paura è una naturale reazione del nostro organismo in condizioni di pericolo che ci permette di attuare risposte volte a garantire la nostra sopravvivenza: l’attacco o la fuga. Nelle situazioni in cui non sembra esserci possibilità di salvezza il nostro organismo va oltre, generando una risposta di freezing. Il freezing è una particolare risposta di paura che si manifesta attraverso bradicardia e immobilizzazione, appare come un totale o parziale “congelamento” dell’organismo in situazioni di emergenza e può avere una durata compresa tra pochi secondi e 30 minuti.
- Movimenti rapidi improvvisi.
- Sc Soares, RS Maior, LA Isbell, C Tamaz & H Nishijo. Fast Detector/First Responder: Interactions between the Superior Colliculus-Pulvinar Pathway and Stimuli Relevant to Primates. In “Frontiers in neuroscience”, 11:67, Feb 2017
- Q VanLe, LA Isbell, J Matsumoto, M Nguyen, E Hori, RS Maior, C Tamaz, AH Tran, T Ono & H Nishijo. Pulvinar neurons reveal neurobiological evidence of past selection for rapid detection of snakes. In “Proceedings of the National Academy of Science of the USA”, 110(47):19000-5, Nov 2013
- LA Isbell, SF Etting. Scales drive detection, attention, and memory of snakes in wild vervet monkyes (Chlorocebus pygerythrus). In “Primate”, 58(1):121-129, Jan 2017








