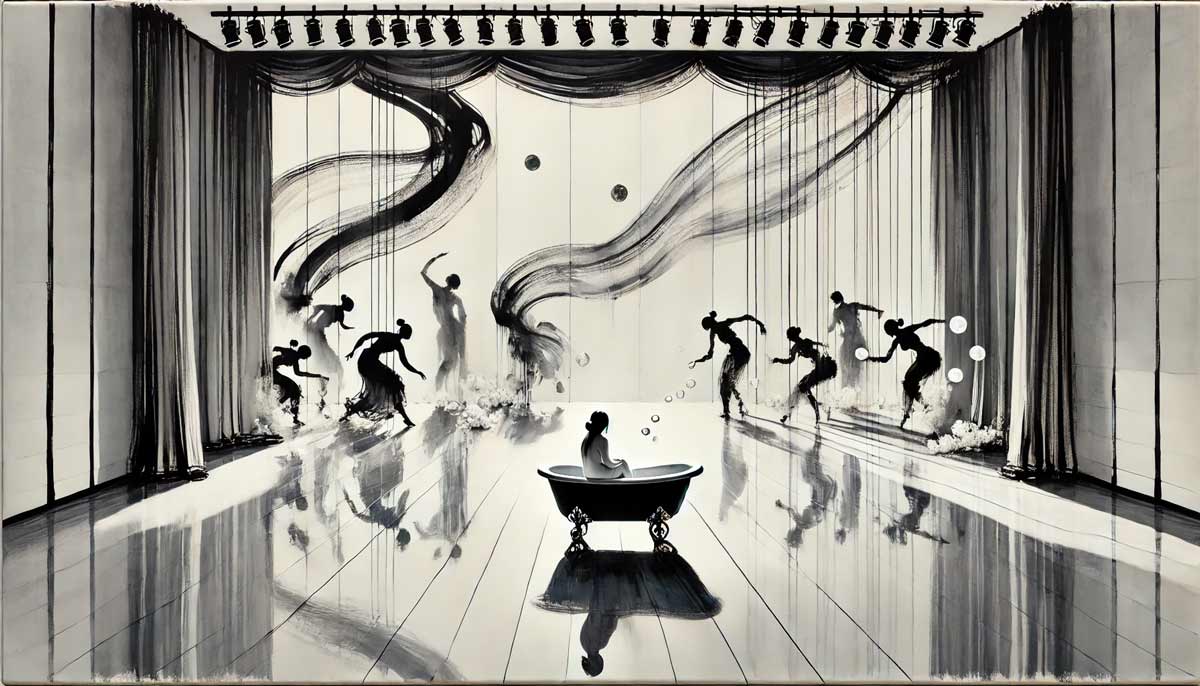BIO – Medicina Costruzione Sociale nella Post-Modernità – Educational Papers • Anno VI • Numero 24 • Dicembre 2017
Scritto in collaborazione con Eugenia D’Alterio – biologa
Sistema & mondo della vita
Secondo Jürgen Habermas, l’agire strumentale e l’agire comunicativo di noi umani compongono due ambienti diversi ma tra loro complementari della società in cui ci troviamo a vivere: la società come “sistema” e la società come “mondo della vita” [Lebenswelt]. Il sistema, come suggerisce il termine, è qualcosa di rigidamente disciplinato dall’agire tecnico, strumentale e strategico: esso trova i suoi elementi qualificanti nel denaro (sfera economica) e nel potere (sfera politica, burocratica, statale).1
Contrapposto al “sistema” [o establishment] è quello che Habermas definisce “mondo della vita”, concetto che egli mutua da Edmund Husserl: il “mondo della vita” è caratterizzato dall’agire comunicativo, da valori condivisi, da spontaneità, da tradizioni; esso fa, per così dire, da sfondo e da orizzonte dell’agire comunicativo, rendendolo possibile. Utilizzando le parole di Habermas, il mondo della vita è “il luogo trascendentale nel quale chi parla e chi ascolta si incontrano, e avanzano, reciprocamente, la pretesa che le loro comunicazioni si armonizzino con il mondo (quello oggettivo, sociale e soggettivo) e nel quale i dialoganti possono criticare e confermare queste pretese di validità, esternare il proprio dissenso e raggiungere l’intesa”.2 Allo stesso tempo, il mondo della vita è il grande contenitore in cui si conservano e si trasmettono i risultati delle interpretazioni delle generazioni precedenti. Non bisogna però pensare al mondo della vita come a un qualcosa di vitale privo di razionalità: al contrario, il mondo della vita è pervaso dalla razionalità, ma non da quella strategica, bensì da quella comunicativa. Tra il “sistema” e il “mondo della vita” vige un rapporto conflittuale che Habermas descrive in maniera simile a quella con cui Marx descriveva la lotta tra “forze produttive” e “rapporti di produzione”. Habermas è convinto che il “sistema”, in particolare lo Stato, coi suoi apparati di potere e il suo ordinamento economico, si sia reso autonomo rispetto al mondo della vita, entrando poi in conflitto con esso: cercando di intervenire nel mondo della vita, il sistema ne minaccia l’esistenza. Infatti, il potere e il denaro (che caratterizzano il sistema) sono, per loro natura, non solo un qualcosa che non comunica ma, anche, un qualcosa che tende ad azzerare la comunicazione, creando sudditanza e passività.3
Alla luce di questa considerazione, occorre combattere strenuamente per difendere il mondo della vita dai reiterati tentativi di colonizzazione violentemente esercitati dal sistema. Ben si capisce, in questa prospettiva, perché Habermas abbia duramente polemizzato contro Niklas Luhmann,4 il teorico dei “sistemi”, rinfacciandogli di non aver tenuto conto, nella sua elaborazione che riduce tutto a sistemi, del “mondo della vita” e dei movimenti che si oppongono al sistema stesso.
La questione nel “mondo della vita” pone, inevitabilmente, la domanda sulla “vita giusta” e la “società giusta”. La filosofia metafisica e la religione rispondevano al problema della vita giusta ponendo modelli (alcuni non proponibili alla massa, ma solo ad un’élite) che dovevano essere imitati sia dai singoli individui sia dalla comunità politica. Il fallimento di tali modelli di vita, determinanti e vincolanti, ha, oggi, nella Post-Modernità, posto nuove domande sulla vita giusta e sulla società giusta, domande che esigono una risposta secolarizzata non più legata alla tradizione religiosa e metafisica.
Per il sistema, oggi, la “società giusta” sarebbe quella che lascia le persone libere di decidere “che uso fare” del tempo della loro vita, e garantisce loro pari libertà di sviluppare un’auto-comprensione etica, al fine di realizzare una personale concezione di “vita buona”. Inoltre, oggi, le teorie della giustizia e della morale hanno preso una strada diversa da quella dell’etica classica, il punto di vista morale chiede di astrarci da quelle immagini di “vita riuscita”tramandateci dalle religioni e dalla metafisica.
La filosofia stessa, però, si ritira in una sorta di meta-livello, compie un’astensione giustificata verso i contenuti dei processi di auto-comprensione, limitandosi ad indagarne le caratteristiche formali. Kierkegaard fu il primo a rispondere con il concetto post-metafisico del “poter-essere-sé-stessi” alla domanda sulla “vita giusta”. Egli in “Aut- Aut”5 contrappone un modello di “vita etica” alla “vita estetica”. Nella “vita etica” l’individuo deve assumere, con decisione, la coscienza della propria individualità e libertà e diventare capace, sul piano sociale, di rispondere delle proprie azioni e di stringere obblighi nei confronti degli altri. Ossia, ognuno si incarica di sé stesso, un compito che gli è imposto in quanto è la persona stessa a sceglierlo liberamente.

Quale potrebbe essere un sistema compassionevole?
Riguardo la contrapposizione tra “sistema” e “mondo della vita”, da anni recenti, alcuni studiosi, come i psicologi Daniel Goleman, Peter Senge e Richard Davidson, stanno riflettendo su quale potrebbe essere un sistema compassionevole, cioè un sistema etico dove l’individuo deve assumere la coscienza della propria individualità e libertà e diventare capace di rispondere delle proprie azioni e di stringere obblighi nei confronti degli altri. Sappiamo ben poco delle persone in generale, dei sistemi in cui vivono, per non parlare della questione dal lato scientifico. È per questo che molti governi applicano enormi tagli alla scienza. Adesempio, Steven Cohen, direttore dell’Earth Institute della Columbia University, ha affermato che la ricerca alla Columbia- leader mondiale nella scienza del clima – potrebbe essere ridotta di un 80% da proposte politiche
Perché un governo può farla franca in questo modo? Perché non c’è scalpore al di là di un stretto circolo di scienziati e persone comuni? Perché pochi di noi comprendono la scienza e il valore sociale attribuibili alla guida di una bio-politica centrata su di noi, quali esseri senzienti e valutativi? Parte di questa situazione di “ignoranza” ha a che fare con una generale mancanza di consapevolezza dei sistemi in cui il mondo della vita è incastrato. Energia e tecnologia, economia e cultura, sono i sistemi che renderebbero, più chiaramente, perché la scienza è così essenziale per il miglioramento della nostra vita e della società e perché un ricercatore ha a che fare, indirettamente, con ciascuno di noi.
C’è, al riguardo, una grande disconnessione tra “sistema” e “mondo della vita”, ma un punto di intervento potrebbe essere l’istruzione: possiamo spiegare meglio a bambini e adolescenti, particolarmente quando sono a scuola, cosa sono i sistemi e cosa è il mondo della vita, perché i sistemi sono importanti e come un qualcosa più prossimo a noi possa riferirsi a qualcos’altro altrove (connessioni tra sistemi). Poi, i più giovani mentre attraversano il mondo della vita con questa comprensione di fondo, con questa impalcatura di base della conoscenza, farebbero connessioni che, oggi, non sono neanche contemplate. Se, invece, gli adolescenti crescessero con questa comprensione dei sistemi in cui è irretito il mondo della vita, il mondo diventerebbe abbastanza diverso (più equo) avanzando verso il futuro.
Per Daniel Goleman, l’ambiente è stato una preoccupazione a lungo termine, non solo per il riscaldamento globale ma, anche, per i sistemi globali che supporterebbero la vita. Del ciclo del carbonio,6 ad esempio, la maggior parte di noi ne sa almeno qualcosa, ma ci sono diversi altri sistemi di supporto fondamentali alla vita, dai molecolari a quelli ambientali, come il ciclo dell’acqua, in particolare, e l’approvvigionamento di acqua potabile. L’apporto umano, poi, con tutte le sue conseguenze disfunzionali, dalla prelazione di territori naturali alle modifiche ambientali che distruggono interi ecosistemi, ha portato il declino della biodiversità con il conseguente estinguersi, negli ultimi 100 anni, di una enorme quantità di specie.
Secondo queste interpretazioni, riguardo l’intreccio tra “sistemi” e “mondo della vita”, il modo in cui viviamo, ora, sul pianeta starebbe, inesorabilmente, erodendo tutti quei sistemi che supportano la vita stessa. L’unica eccezione,molto significativa, riguarderebbe l’ozono. L’ozono, che naturalmente ci protegge dai raggi del sole, era in diminuzione a livello planetario, poi, in qualche modo, c’è stato un divieto mondiale per le sostanze chimiche industriali emesse nell’atmosfera che esaurivano questo gas, in particolare quelle utilizzate per la refrigerazione. Così, lo strato di ozono ha cominciato, lentamente, a ricostituirsi.
Questa esperienza costituisce un importante segnale di ciò che potremmo fare se riuscissimo a cambiare i modi in cui le nostre abitudini distruggono, complessivamente e quotidianamente, il “mondo naturale” e della vita”. In questa prospettiva, ci sarebbe da combattere, in primis, quella disconnessione tra le nostre azioni quotidiane e le decisioni che prendiamo, ossia tra ciò che acquistiamo o motiviamo, e le conseguenze che impattano il pianeta.
Per colmare tale disconnessione, alcuni studiosi, come Peter Senge7 e Daniel Goleman, stanno cercando di portare avanti una campagna di divulgazione educativa, circa i “sistemi compassionevoli” come risposta alla crisi di sostenibilità della nostra civiltà, proponendo che nelle scuole venga adottata la materia come parte del programma di studi. Uno dei programmi scolastici interessati a questo è “The International Baccalaureate High Schools (l’IB).
Questo Baccalaureato8 punta a formare giovani cittadini curiosi, competenti ed altruisti che possano contribuire a creare un mondo più pacifico attraverso il dialogo interculturale e il rispetto. A questo fine l’organizzazione lavora con scuole, governi e organizzazioni internazionali per sviluppare programmi di studio che, mediante l’introduzione dell’apprendimento sistemico, incoraggino gli studenti a diventare attivi, compassionevoli e aperti alla possibilità che altre persone, pur nelle loro differenze, possano avere, ugualmente, giudizio e ragione.
Infatti, questo programma ha aggiunto l’ingrediente mancante: compassione ed empatia. Si può avere una comprensione dei sistemi di prim’ordine ma se non c’è interesse agli impatti che le conoscenze consentono, allora, dobbiamo affrontare le conseguenze di conoscenze e avidità ingannevoli. Difatti, abbiamo aziende che utilizzano scienza e sistemi per i loro interessi personali, senza preoccuparsi degli effetti collaterali sulla vita e sull’ambiente: uso di prodotti chimici industriali non testati, emissioni tossiche in acqua, suolo e aria (per citarne alcune).
Di fatto, è diventato luogo comune apprendere dai notiziari che un divieto di utilizzo di un pesticida, comunemente utilizzato nelle aziende agricole in tutto il mondo ma pericoloso, soprattutto, per i bambini, gli anziani e per i lavoratori agricoli stessi, venga vietato. Le documentazioni scientifiche (o probabilistiche) che particolari antiparassitari siano un pericolo per la salute sono schiaccianti, tuttavia, continuamente si adottano decisioni politiche che non tengono conto di questi fatti.
Questo va al di là dell’attuale gestione dell’analfabetismo scientifico. C’è una parte molto grande della società, del popolo dei votanti, che non capisce e non si preoccupa della scienza né di come la scienza ci aiuti come misura di costruzione di “verità relative o contestuali” (naturalmente la scienza è probabilistica, non una misura ultima). Così, ignorando ciò che la scienza postula, si possono fare profitti decidendo, in campo industriale, di usare un pesticida di cui è stata testata la pericolosità, purtroppo queste decisioni non sono, quasi mai, né al servizio della società né palesate nel loro complesso.
Il modo in cui una prospettiva sistemica potrebbe aiutarci con la crisi ambientale è aiutandoci a capire che abbiamo una gamma molto limitata di concessioni,9 di scelte. Per esempio, i nostri arredi domestici sono fabbricati con piattaforme industriali che sono, più o meno le stesse, dal dopoguerra a quasi fine XX° secolo. Eppure negli ultimi decenni abbiamo visto l’emergere dell’ecologia industriale, una scienza che offre una metrica per comprendere gli impatti del ciclo di vita di ognuno di questi oggetti, dall’inizio al fine utilizzo, in termini di come influenzano e influenzeranno i sistemi globali che supportano la vita sul nostro pianeta. Ora che abbiamo questi dati e una metrica per utilizzarli, possiamo meglio gestire i processi che comportano l’uso e la fabbricazione di ogni oggetto che possediamo. Abbiamo una metrica per reinventare tutto nel mondo materiale per sostenere quei sistemi che sorreggono la vita.

Reinventare sistemi con un cervello vetusto
Dal Paleolitico, per il cervello umano e, presumibilmente, per la cosiddetta “natura umana”, è stato un periodo evolutivo molto lungo, dove i nostri istinti sono stati modellati e questa influenza rimane forte ancora oggi. In parte, le vestigia di quel periodo evolutivo ci hanno portato alla nostra attuale confusione. Ad esempio, un fattore che sembra aver aiutato noi umani a sopravvivere nei primi tempi di evoluzione, quando si poteva morire di fame o essere divorati da un predatore, era l’istinto per accumulare tanto cibo, quanto si poteva al momento, perché non c’era la certezza o prevedibilità di poter procurarselo di nuovo. Questo rende l’avidità una parte fondamentale di ciò che è il nostro modello di interpretazione della natura umana. Ma il maggiore accesso ai beni o alle merci che la civiltà offre è stato ampliato enormemente nel secolo scorso con la nostra capacità di avvalerci del combustibile fossile. Siamo stati in grado di manipolare più energia come mai nella storia dell’umanità. Ciò ha portato un enorme tasso di crescita del mondo e della cultura materiale, così come l’abbondanza di beni che alcuni di noi accumula.
Studiosi come Daniel Goleman, Peter Senge e Richard Davidson non credono che l’istinto umano primitivo, di cibarsi di grassi, zuccheri e accumulare quanto più si può, cambierà molto presto. Di fatto, appena un’economia favorevole rende più persone benestanti i tassi di obesità si alzano. Quell’impulso sembra profondamente integrato nel piano di gioco umano. D’altra parte, noi umani, abbiamo una capacità compensativa di inventare, innovare, ripensare, di ingannare il nostro cervello paleolitico, utilizzando la stessa capacità con cui abbiamo creato il meraviglioso mondo materiale in cui adesso viviamo. E questo è il momento in cui il pensiero sistemico viene, nuovamente, da noi richiamato in aiuto.
Il ciclo di vita di qualsiasi prodotto materiale mostra che esso incide (negativamente) nei sistemi globali che supportano la vita. Mettiamo insieme l’incidenza negativa dei cicli di tutti i prodotti materiali in circolazione tra gli oltre 7 miliardi di persone sul pianeta e abbiamo le crisi che ci troviamo di fronte ora. Gli studiosi dell’ambiente chiamano gli ultimi cinquant’anni “la Grande Accelerazione”10 e quando tracciano questi impatti negativi nel corso del tempo, ne evidenziano un impatto che peggiora sempre più rapidamente.
Mentre gli impatti negativi della nostra vita materiale accelerano, abbiamo cambiato poco nel modo in cui operiamo. A partire dall’età del bronzo, la scoperta e ricerca di materiali, che mescolati e riscaldati ad alta temperatura hanno fornito le primitive materie prime, continua con una incentivazione e perfezione estenuante. Ma perché dobbiamo usare così tanto calore e per così tanto tempo? Perché non reimpostiamo i sistemi aggressivi?
Ci sono dei laboratori che hanno già reinventato il mattone. Hanno trovato che si potrebbero mescolare e riscaldare le sostanze necessarie di un ipotetico “futuro mattone” ad una temperatura più bassa e per un tempo più breve. Se si dovesse mettere in scala (o utilizzare “adobe green”), un procedimento del genere porterebbe un enorme miglioramento dell’impatto ambientale cumulativo derivante dalla produzione di mattoni. Con un po’ di ingenuità e sperimentazione si potrebbe, presumibilmente, fare lo stesso con altri materiali, ma, finora, la produzione, in generale, non è cambiata di molto e gli altiforni sono ancora in funzione. In altre parole, è giunto il momento per noi di ripensare a tutto nel mondo materiale alla luce della nostra comprensione più sofisticata della fisica, della chimica e della biologia, e degli impatti specifici dei processi industriali sulla salute e sull’ambiente.
Le piattaforme industriali che usiamo, oggi, non sono cambiate molto dal secolo scorso. Ecco perché le pro- duzioni petrolchimiche, per esempio, sono alla base di molto di quello che usiamo, come le plastiche. Il sistema dell’acqua in bottiglia di plastica ha un impatto negativo nel mondo della vita. Troppe di queste bottiglie finiscono negli oceani, dove si scompongono in cosiddetti nurdles,11 piccoli bit che pesci e altre vite acquatiche traducono come cibo ma i prodotti chimici di degradazione possono essere altamente cancerogeni o agire come disgregatori endocrini.
Se si apre lo stomaco di un uccello marino, perché è in cima a una certa catena alimentare – che si nutre di pesci che mangiano, a loro volta, pesci più piccoli – è stato rilevato pieno di plastica. La plastica sta uccidendo la vita nel mare. Allora perché se ne siamo consapevoli non ripensiamo ad una possibile soluzione? Abbiamo tanta scienza stupefacente in corso. Perché non reinventare le cose che degradano i sistemi di sostegno della vita del pianeta?
Una delle sfide più importanti è come fare che qualcuno ripensi i sistemi che degradano e reinventi sistemi che la sostengano. Quando si tratta di cambiare il modo in cui l’industria fa le cose, rileviamo gruppi, all’interno di aziende e corporazioni, che stanno iniziando a operare quei cambiamenti che si vorrebbero vedere. Perché lo stanno facendo, perché si adattano ai nostri valori e li incorporano nella loro missione?
Queste aziende stanno operando sui nuovi valori per un paio di motivi. Il primo motivo: stanno operando allineando decisioni ed azioni con i valori morali. Il secondo motivo: le persone che ci lavorano si sentono meglio gratificate come lavoratori e come esseri umani. In più, fattore molto importante, questo processo migliora la posizione di un’azienda o di una corporazione per il futuro. Altra motivazione è, anche, perché la nuova generazione in corso è ancora in età infantile ma crescendo dovrà affrontare circostanze sempre più gravose nel mondo naturale, per non parlare del mondo economico e politico. Cambiamenti, auspicabili, porteranno un valore maggiore in questa particolare prospettiva etica – ad esempio, si desidererà lavorare, quanto possibile, per un’organizzazione, un’azienda, i cui valori si adattano ai propri e dove il lavoratore può sentirsi adeguato. Purtroppo, ancora poche aziende seguono questi criteri.
Aziende e corporation stanno attuando strategie in termini di chi saranno i loro clienti in futuro. Le aziende non si preoccupano molto dei clienti più anziani, vogliono i giovani, perché se ottengono fedeltà al brand da qualcuno più giovane, l’avranno per il resto della vita di questi, il miglior affare per i loro investimenti. Le aziende stanno valutando che l’attrattiva di “fare la cosa giusta” ripaga. E ciò che sta succedendo al riguardo – importante notarlo – è al di là della politica e dei governi: è solo un buon lavoro.
Per esempio, ci sono trilioni di euro in quello che viene chiamato “investimento d’impatto” [“impact investing”], mettendo i nostri soldi in aziende e corporation che andranno a guadagnare i soldi nel cosiddetto modo “etico”, non nel modo oggi socialmente svalutato, questo darà sempre più capitale alle persone che stanno cercando di fare le cose in modo migliore. E ci sono ancora trilioni di euro investiti con un occhio di riguardo per evitare il “rischio climatico”, le esondazioni, il calore torrido, le tempeste superiori e simili, che si prevedono arrivare in maggiore intensità con il riscaldamento globale.
Già si attuano numerosi sforzi per migliorare gli impatti ecologici che si verificano fuori dalla vista dei consumatori, come per esempio le attività di B2B, cioè business-to-business, per non comprare olio di palma da una piantagione che abbia devastato una foresta per ottenerlo, come è accaduto in parti dell’Indonesia e in altri paesi del mondo. Ora, molte grandi corporazioni non commercializzano più olio di palma.12 Ciò significa che l’industria dell’olio di palma deve fare in modo che quest’olio sia ricavato correttamente per entrare nel mercato.
Al riguardo, David Goleman, nella sua conversazione sui sistemi compassionevoli condivide una storia sull’olio di palma.[efn_not]Ibidem[/efn_note] Gli è capitato di incontrare il pronipote dell’uomo che fondò un business in Belgio e nei Paesi Bassi, nel XIX secolo. Quella parte d’Europa era il più grande produttore di margarina. Questo pronipote ha affermato che il suo bisnonno,possedendo il brevetto per la produzione di margarina, riuscì a citare in giudizio i concorrenti, riuscendo, così, a metterli fuori dell’attività o acquisendoli. L’olio di palma era l’ingrediente principale della margarina e quest’uomo che aveva reso la sua attività un grande marchio aveva saputo che c’era un’altra azienda che usava una grande quantità di olio di palma: era una società che produceva sapone.
Negli anni ‘30 queste aziende si unirono sotto un unico nome. Chiaramente, la visione della società produttrice di margarina faceva parte del DNA della nuova società. Tempo dopo, la nuova società acquistò una catena di produzione di gelati. Perché hanno comprato tale catena? Un membro del consiglio di amministrazione rispose: “Speriamo che i valori dei produttori di gelati [che all’epoca organizzarono una campagna no profit in cooperazione con il Children’s Defense Fund] infettino il resto dell’organizzazione”.
Tempo dopo, il CEO (direttore generale) del gruppo, annunciò obiettivi veramente ambiziosi per la società. Non voleva solo ridurre emissioni di anidride carbonica – molte grandi aziende lo stavano già facendo – ma, anche, annunciare un piano per aiutare mezzo milione di piccole fattorie agricole, nel terzo mondo, a diventare fornitori del gruppo.
Ciò ha significato che queste piccole fattorie agricole hanno avuto un reddito stabile e per raggiungere questo obiettivo vengono assegnati gli aiuti necessari per aggiornare i loro metodi di coltivazione e allevamento. Questa mossa rendeva la catena di approvvigionamento del gruppo più robusta, quindi, aveva un senso strategico. Ma, anche la Banca Mondiale dice che il modo migliore per aiutare un’economia rurale impoverita è, esattamente, quella di aumentare il reddito dei piccoli agricoltori. Quindi il risultato è promuovere un’istruzione migliore, una migliore salute e un’economia di piccole comunità agricole più solida e duratura.
L’organizzazione di cui si discute sta facendo la giusta cosa per un certo numero di motivi, tra i quali: semplificare il tipo dicambiamenti che aziende e corporation possono attuare e indurre sempre più aziende e corporation a farlo. Tali strategie costituiscono una modalità per non rincorrere la politica. Non importa quanto i governi non rispettino l’accordo sul clima diParigi se abbastanza aziende e corporation stanno agendo in modi da raggiungere gli obiettivi climatici. In tutto il mondo, i governi sono entità paralizzate dalle fazioni, mentre i business aziendali, presumibilmente, non lo sono e, in questo modo, rimane una pista aperta all’incentivazione di nuovi valori.
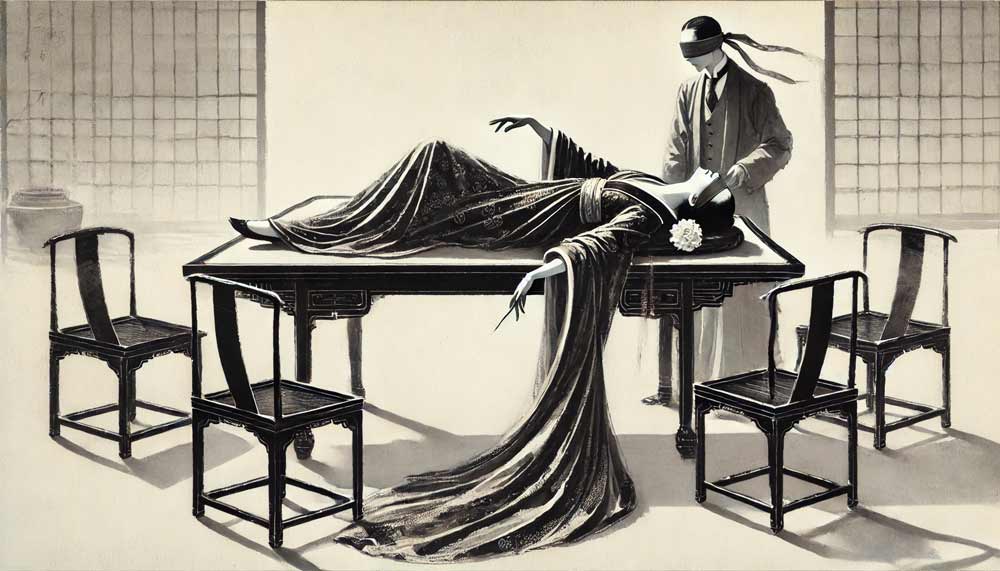
Dove risiede la dimensione etica di un sistema?
Altre propensioni preoccupano alcuni studiosi: l’intelli- genza artificiale e il fatto che i big data [grandi dati] possono venire fuori con algoritmi che prevedono il comportamento umano al di là della possibilità di qualsiasi singolo individuo. Navigando nel futuro, ci saranno androidi, robot che opereranno mediante algoritmi potenti che possono sconfinare il pensiero umano, a monte, dunque, si è preoccupati per ciò che riguarda i sistemi in generale, ossia, dove risiede la dimensione etica di un sistema? Come si fa ad ottenere un sistema di intelligenza artificiale che si preoccupi degli esseri umani e del futuro umano?
In qualche modo una tale Intelligenza Artificiale dovrebbe essere programmata a tale scopo, ma non si sente molta discussione in merito e ciò inquieta. Nella misura in cui il potere migra dai governi alle corporazioni, la preoccupazione è che con la buona volontà e le buone intenzioni migrino, anche, gli algoritmi che gestiscono le nostre vite. Chi, in modo imperscrutabile, sta a scrivere questi codici e perché? La questione è controllare e limitare le nostre scelte. Di fatto, queste decisioni incorporate (embedded) sono arbitrarie: qualcuno ha deciso che questo algoritmo deve essere dietro il tuo telefono o nel tuo Apple o TV. Non abbiamo altre scelte: noi ci fidiamo ciecamente.
Ciò che sta succedendo, nella misura in cui Intelligenze Artificiali [AI], codici e algoritmi assumono le nostre vite e la invadono in maniera molto user-friendly, è che noi non vediamo cosa stiamo perdendo; non vediamo quali sono le altre scelte, né abbiamo, come nella politica, alcuna capacità di votare per questo o contro questo. In un certo senso siamo ricettori molto passivi di qualunque ipotesi sia stata fatta per noi e quelle decisioni sono invisibili a noi, utenti. Ciò è da intendersi come bio-politica di effettivo pericolo.
Le persone del mondo che conteranno più nel futuro, come nel mondo delle tecnologie e nel mondo delle Intelligenze Artificiali (AI), possono avere buone intenzioni, ma il potere tende a corromperle. Come si comporta una società contro queste situazioni?
Come inoculare una società contro la corruzione del potere? L’apprendimento socio-emotivo
Questa preoccupazione è fondamentale per il curriculum delle scuole internazionali di baccalaureato, scuole che stanno attuando sistemi di apprendimento, ma li stanno combinando con la compassione. Il mondo diventerà più triste se le persone che hanno il potere reale non si preoccupano del benessere globale: questo tipo di educazione offre un’inoculazione contro quel pericolo.
Venti anni fa circa, quando Goleman scrisse l’Intelligenza Emotiva,13 si discuteva di un curriculum che insegnasse ai ragazzi la gamma di auto-consapevolezza, auto-regolazione, empatia, abilità sociali, cioè l’intelligenza emotiva. Questi curricula sono chiamati “apprendimento socio-emotivo”, o SEL [social-emotional learning], che si trova oggi in migliaia di scuole in tutto il mondo. Alcuni stati lo hanno reso obbligatorio. Quando si parla di implementare un’unità di empatia nel programma dei sistemi compassionevoli, si sta sostenendo la pedagogia già esistente e che si sta diffondendo. Si sta diffondendo in gran parte perché i dati supportano l’apprendimento sociale ed emotivo (SEL).
I ragazzi, specialmente quando si trovano nella scuola media e nella scuola superiore, sono più orientati verso i loro coetanei rispetto a chiunque altro, compresi i loro genitori. E sono aggrappati ai melodrammi della loro vita, preoccupazioni come:“perché non mi hanno invitato alla festa?” Questi episodi conquistano la loro attenzione. Potendo aiutarli a gestire meglio le loro reazioni emotive e la loro vita sociale, i ragazzi posso- no prestare maggiore attenzione alla scuola.14
Roger Weissberg,15 primo direttore del Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning [Programma per l’apprendimento socio-emotivo] è uno psicologo di grande fiuto che ha documentato come l’apprendimento sociale ed emotivo (o SEL) sia importante. Per esempio, egli ha utilizzato un’enorme meta-analisi che aveva i dati di un quarto su un milione di bambini, alcuni dei quali stavano seguendo i programmi SEL ed altri, demograficamente correlati, che non lo facevano. Con SEL c’era una riduzione del 10% dei comportamenti anti-sociali come le lotte o il bullismo. C’era, anche, un aumento del 10% degli indicatori pro-social come la simpatia per la scuola. E i punteggi di studio accademici erano aumentati dell’11%.
La neuroscienza ci dice che ci sono tre tipi di empatia, ognuno di essi collocato in circuiti neurali discreti. La prima è l’empatia cognitiva, che è il tipo di empatia che un algoritmo ci darà con grandi studi sui big data, sapendo come le persone pensano alle cose, ossia capisce i modelli mentali delle persone. E questo permette di comprendere e/o manipolare i loro modelli mentali ma non sempre nel loro interesse. Non c’è compassione nell’empatia cognitiva, ma risulta un potente strumento per capire come la gente pensa.
La seconda è l’empatia emotiva, dove si avverte come si sentono le altre persone. Questo potrebbe portare alla compassione, ma, se l’altra persona soffre e prova dolore e l’empatia emotiva ci porta agli stessi sentimenti, la maggior parte delle persone staccano la connessione emotiva perché non vogliono sentire il dolore dell’altro, per cui la loro sintonizzazione sull’altro va a diminuire la probabilità che possano davvero aiutare. Inoltre, l’empatia emozionale può essere utilizzata anche da un esperto politico o da un dittatore per manipolare la folla. Non è necessariamente un bene per la società.
La terza è l’empatia definita preoccupazione empatica, e utilizza i circuiti per la custodia genitoriale, i cablaggi fondamentali dei mammiferi. È l’amore di un genitore per il figlio. Questa empatia può essere denominata cura o compassione.
La neuro-plasticità è la nozione che postula che si possono costruire o degradare circuiti neurali, usandoli o meno, e che la pratica rende i circuiti più forti. La neuro-plasticità è stata combinata, adesso, con la comprensione dei tre tipi di empatia proveniente dal laboratorio di Tania Singer16
presso l’Istituto Max Planck di Lipsia. Hanno trovato che se la gente usasse, sistematicamente, l’uno o l’altro di questi tre circuiti, le loro abilità in quel particolare tipo di empatia migliorerebbero e il circuito sottostante diventerebbe più forte.
Le persone del Baccalaureato Internazionale [IB] stanno aiutando i ragazzi, mediante sistemi di apprendimento socio-emotivo, a costruire quel circuito, in modo che loro possano sviluppare quei circuiti neurali per prendersi cura, compassionevolmente, di altre persone. Questa combinazione di potere cognitivo puro, che è l’apprendimento sistemico o dei sistemi con la preoccupazione per il benessere umano, può aiutare a mantenerci sulla strada giusta, oggi e in futuro.
Certamente, l’insegnamento di un’empatia sistemica compassionevole riproporrebbe la domanda del “mondo della vita”, cioè quale sia la vita giusta o la società giusta? Come accennato nell’introduzione “Sistema e Mondo della Vita” di questa breve relazione, fino alla modernità le élite utilizzavano i modelli della filosofia metafisica e della religione per rispondere al dilemma della vita giusta imponendo modelli che dovevano essere imitati sia dai singoli individui sia dalla comunità politica. L’erosione di tali modelli di vita, determinanti e vincolanti, derivata dalla secolarizzazione che la modernità stessa ha generato, oggi, nella Post-Modernità, pone nuove domande sulla vita giusta e sulla società giusta, domande che esigono una risposta secolarizzata per rifondare nuovi valori di aggregazione e compassione non più legati alla tradizione religiosa e metafisica. La fondazione di un’idea di vita giusta basata sulla “compassione per la specie” (e per le altre specie animali e vegetali) sarebbe, per noi umani, una scelta equa di giustizia.
- Jürgen Habermas -Teoria dell’agire comunicativa. Critica della ragione funzionalistica, vol. II, Il Mulino, 1997 p. 714.
- Ibidem
- Ibidem
- Luhmann, Niklas, Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale. Bologna, Il Mulino, (Collezione di testi e di studi), 2001, pp. 761.
- Aut-Aut: opera del filosofo Søren Kierkegaard che tratta ed esplora le prime due modalità esistenziali: la vita estetica e la vita etica.
- Il ciclo del carbonio è il ciclo bio-geo-chimico attraverso il quale il carbonio viene scambiato tra la geosfera (all’interno della quale si considerano i sedimenti e i combustibili fossili), l’idrosfera (mari e oceani), la biosfera (comprese le acque dolci) e l’atmosfera della Terra. Tutte queste porzioni della Terra sono considerabili a tutti gli effetti riserve di carbonio (carbon sinks). Il ciclo è infatti solitamente inteso come l’interscambio dinamico tra questi quattro distretti. La crosta terrestre contiene la maggior riserva di carbonio presenta sulla terra. Le dinamiche di interscambio sono legate a processi chimici, fisici, geologici e biologici.
- Peter Senge. The Fifth Discipline: The art and practice of the learning organization, Doubleday, New York, 1990. La quinta disciplina: l’arte e la pratica dell’apprendimento organizzativo è un libro di Peter Senge (docente del MIT) che si concentra sul problem solving di gruppo utilizzando il pensiero sistemico come metodo per convertire le imprese all’apprendimento organizzativo. Le cinque discipline rappresentano l’approccio (teoria e metodi) per sviluppare tre aree di capacità fondamentali di apprendimento: promuovere l’aspirazione, lo sviluppo di conversazione riflessiva e la comprensione della complessità.
- Licenza di scuola media superiore Internazionale.
- Il concetto trae origine dalla psicologia della Gestalt durante gli anni ‘20 e ‘30, secondo tale approccio noi percepiamo la funzione di un oggetto in modo immediato, così come percepiamo il colore e la forma. Il concetto di affordance è stato coniato dallo psicologo James Jerome Gibson nel 1979 nel suo libro The ecological approach to visual perception, (“to afford” significa offrire, dare o fornire). Sulla scia degli studi psicologici di quegli anni, Gibson focalizza i suoi studi sulla percezione e formula la “Teoria della percezione diretta” dove i sensi sono sistemi percettivi diretti che hanno la funzione di cogliere le invarianti strutturali disponibili nell’ambiente, cioè quelle caratteristiche che rimangono sempre uguali a loro stesse a prescindere dal soggetto. Le informazioni quindi sono già presenti nella stimolazione e possono essere colte direttamente, come afferma Gibson: “Le affordance dell’ambiente sono cosa questo offre, cosa fornisce, sia nel bene che nel male”. Una affordance pertanto offre un indizio che aiuta le persone nell’utilizzo di un determinato oggetto. Per Gibson l’affordance è legata sia all’ambiente che alle possibilità di azione del soggetto, l’affordance di un oggetto non è legata all’oggetto in sé, ma al contesto in cui esso è inserito e che ci permette di comprenderla.
- Si riferisce alla “Grande Accelerazione” delle attività umane dall’inizio della rivoluzione industriale dal 1750 al 2010 e i successivi cambiamenti nel Sistema Terrestre, cioè livelli di gas serra, acidificazione degli oceani, deforestazione e degrado della biodiversità. Quando sono stati aggregati per la prima volta le serie di dati al riguardo, ci si aspettava di vedere grandi cambiamenti, ma ciò che ha sorpreso agli studiosi è stata la tempistica. Quasi tutti i grafici mostrano lo stesso schema. I cambiamenti più drammatici sono avvenuto dal 1950. Possiamo dire che intorno al 1950 c’è stato l’inizio della Grande Accelerazione”. Anthropocene Review. Jannuary 16, 2015.
- Chiamati nurdles, plastic pellet o, più poeticamente, mermaid tears (lacrime di sirena) questi piccoli granuli di plastica hanno forma e dimensioni simili alle lenticchie o, a volte, a piccoli cilindri di circa mezzo centimetro. Costituiscono la materia prima prodotta dalle industrie che, dopo esser trasportata, arriva in siti di produzione nei quali vengono fusi e trasformati negli oggetti di plastica che tutti noi utilizziamo quotidianamente.
- Compassionate Systems. A Conversation With Daniel Goleman. Op. cit.
- Daniel Goleman. L’Intelligenza Emotiva. BUR Rizzoli Milano 1996. L’intelligenza emotiva è un aspetto dell’intelligenza legato alla capacità di riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo consapevole le proprie ed altrui emozioni.
- Il Baccalaureato Internazionale è riconosciuto come diploma equivalente all’Esame di maturità dal Ministero dell’Istruzione. È tuttavia una qualificazione ancora poco diffusa in Italia (nella sessione di esami maggio 2009 si sono registrati 525 studenti di nazionalità italiana, ma solo 247 candidati hanno sostenuto l’esame di Italiano come lingua madre). L’IB è riconosciuto come esame di ammissione universitaria in più di 80 paesi del mondo e dalle più autorevoli università a livello mondiale.
- Roger P. Weissberg è professore emerito di psicologia & educazione del College of Liberal Arts and Sciences dell’ University of Illinois at Chicago e presidente della NoVo Foundation per il Social and Emotional Learning all’Università dell’Illinois in Chicago (UIC). All’UIC presiede il Community and Prevention Research Program nel Dipartimento di Psicologia e dirige anche il gruppo SEL Research Group SEL Research Group.
- Bosworth, S. J., Singer, T., & Snower, D. J. Cooperation, motivation and social balance. The Journal of Economic Behavior and Organization. 2015.
Steinbeis, N., Engert, V., Linz, R., & Singer, T. The effects of stress and affiliation on social decision-making: Investigating the tend-and-befriend pattern. Psychoneuroen- docrinology, 62, 138-148. 2015.
Singer, T., & Ricard, M. (Eds.). Caring Economics: Conversations on Altruism and Compassion, Between Scientists, Economists, and the Dalai Lama. St Martin’s Press. New York, 2015 Singer, T., & Tusche, A. (2013). Understanding others: Brain mechanisms of Theory of Mind and empathy. In P. W. Glimcher (Ed.), Neuroeconomics. Decision making and the brain. Academic Press. London, 2013.