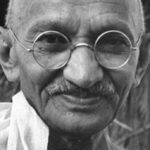Pittore, scrittore, antropologo, politico, Carlo Levi ha attraversato il Novecento italiano con sguardo fervido e gentile, protagonista indipendente della vita culturale e politica italiana nel ventennio fascista e negli anni successivi al secondo conflitto mondiale: antifascista, anti-totalitario, attivista meridionalista. Di formazione gobettiana e senatore indipendente di sinistra degli anni sessanta, è stato un’artista con una visione dei problemi fortemente politicizzata, ma allo stesso tempo un uomo non docilmente allineabile all’esistente. Tra il 1935 e il 1936 viene condannato dal regime al confino in Lucania, un’esperienza che plasma la sua modalità di cogliere con gli occhi, di accostarsi agli altri e a se stesso e che darà vita, dieci anni più tardi, alle pagine dense di Cristo si è fermato a Eboli, scritte tra il ’43 e il ’45 in una stanza di Piazza Pitti a Firenze mentre è braccato dai nazisti: «La casa era un rifugio: il libro una difesa attiva, che rendeva impossibile la morte»1.
Le pagine del Cristo si è fermato a Eboli ci accompagnano con osservazione umile nella vita del mondo contadino, nell’insofferenza per le ingiustizie e i mali dell’organismo civile, ma anche nella riaffermazione della responsabilità personale e collettiva. La sensibilità verso la civiltà contadina si manifesta fin dagli inizi della sua espressione artistica riconoscendo nella pittura quella risorsa, a volte spontanea e a volte laboriosamente affinata, in grado di cogliere la straordinaria composizione della realtà nelle sue infinite sfumature:
«[…]. È la terra della fatica contadina, della miseria e della civiltà contadina. Il suo colore è quello della terra antica, nuda, bruciata da tutti i soli, lavata e spogliata da tutte le piogge; lo stesso colore del viso degli uomini e delle donne, il colore della malaria, della fame, della fatica, della pazienza e del coraggio di vivere. Gli uomini e le donne e i bambini che vivono su questa terra, coi loro animali, l’asino e la capra, e gli usi antichi e le credenze ereditate, estranei e ostili allo Stato e alla storia, pare non si distinguano da lei, essi stessi indistinti all’occhio del viaggiatore frettoloso. Ma questo mondo contadino è invece ricchissimo di verità e di potenza umana, differenziato, pieno di personalità e della poesia delle cose nascenti, e, sotto l’apparenza della sua secolare immobilità, è tuttavia in movimento, alla ricerca, attraverso le infinite storie individuali e le sofferenze infinite della vita quotidiana di una sua originale autonomia»2.
Pittura e scrittura scorrono parallele nell’arco del suo percorso umano e artistico, vicendevolmente si nutrono fino a pervenire, nell’ultima fase della sua vita, a una naturale simbiosi che si esprimerà nel suo ultimo meraviglioso lavoro, Quaderno a cancelli, partorito in un letto d’ospedale. In queste alterne pagine in cui i disegni accompagnano la scrittura in prosa e in poesia, la coscienza interna dell’Autore si espande, l’intima e incessante tensione all’unità che fino a quel momento lo aveva accompagnato, trova la propria affermazione nell’evoluzione creatrice, nello slancio vitale che si nutre della vita stessa, la sua e dell’altro. Osservare, raffigurare le cose, scriverle diviene il modo per congiungersi con l’ “aperto”. È curioso che questo avvenga in un momento in cui Carlo Levi è impossibilitato a vedere. Nel 1973, anno della stesura del Quaderno a cancelli, l’Autore è ricoverato alla Clinica San Domenico di Roma dove è stato sottoposto più volte ad intervento chirurgico per un distacco della rètina. Nonostante non possa cogliere con gli occhi la realtà che lo avvolge, Levi riesce a portare a compimento quel processo di “familiarità” con l’esterno da sé cui aveva sempre aspirato, il solo che rende possibile la conoscenza3. L’uomo non è solo di fronte al cielo e a se stesso, scrive, «dinanzi all’io sta l’altro – tutti gli altri, l’umanità. Ogni rapporto umano, prima di essere libero, è sacro e religioso – poiché è possibile soltanto se l’io è l’altro, se si identifica con lui. […] il contatto con gli altri è possibile soltanto attraverso quello che a tutti è comune, attraverso l’indifferenziato, che col suo permanere fa comprensibili tutte le differenziazioni»4. È questo indifferenziato che Levi, privato della vista, abbraccia nel più intimo rapporto con la sua anima.

C’è da chiedersi come possa un pittore vivere l’improvvisa cecità. In che modo un uomo che si relaziona al mondo principalmente attraverso gli occhi può trovare la luce percorrendo il buio e dipingere l’armonia dell’esistere? Per rispondere ci viene in aiuto un aforisma di un altro grande pittore: «Chiudi il tuo occhio fisico, in modo da vedere prima l’immagine con l’occhio spirituale. Quindi porta nell’oscurità la luce diurna che hai visto, così che ci sia una reazione dall’esterno all’interno». Questo atteggiamento, nota la Volpi riferendosi al Friedrich, si ascrive a una capacità di spogliare l’immagine da artifici per giungere, attraverso una «distillazione assoluta» a «un’alta quota di concentrazione filosofica»5. Carlo Levi si consegna al mondo lasciando cadere ogni barriera. Spazio e tempo, interno ed esterno – nell’esperienza della cecità – non si manifestano come categorie dicotomiche chiuse, ma come universi interconnessi. Tempo e spazio si annullano in un apparente vuoto, ma vitale perché denso di un principio unico e supremo:
[…] Unità del mondo e dell’uomo (unità che, se esiste, non può non essere in ogni momento, in ogni istante: nell’interno della parola, nella forma della frase, nell’origine stessa del pensiero e del sentimento[…]6.
La ricerca di tale ‘familiarità’ con ciò che è esterno a sé, inizia molto presto in Carlo Levi, dal momento in cui decide di intraprendere la professione medica. L’oggettività del conoscere – insieme alla straordinaria capacità d’analisi visiva dei fenomeni naturali, alla sensibilità e all’empatia – , è accompagnata dall’intuito innato e dall’attenzione al dettaglio. Queste doti fanno di Carlo Levi un medico, un uomo e un artista attento e scrupoloso in cui la concretezza dell’intuizione, lontana dall’essere estranea o incompatibile con la conoscenza scientifica, ne costituisce una condizione operativo-costruttivistica necessaria, che facilita il processo di conoscenza, di contatto, di empatia e, dunque, in ambito medico di diagnosi della malattia individuale e – in ambito antropologico e politico -, della malattia sociale, che lo scrittore ravvisa nella rottura fra l’uomo e la realtà, come tristemente confermerà in un articolo su «L’Espresso» del 3 giugno del ’62: «[…] che la rottura di ogni possibile rapporto fra l’uomo e la realtà sia da considerarsi senz’altro come il solo fenomeno importante e caratterizzante della nostra epoca, la rottura del rapporto tra l’Io e il mondo». L’arte e la medicina al di là dal rappresentare in lui due poli opposti, reciprocamente si sostengono offrendo la possibilità di cogliere il senso profondo dell’interrelazione fra le cose, in cui il caos lascia il posto all’ordine e i rapporti armoniosamente si aggrovigliano e confondono restituendo all’intelletto soluzioni e composizioni precedentemente impensabili:
Ogni uomo nasce dal caos e può riperdersi nel caos: viene dalla massa per differenziarsi e può perder forma e nella massa riassorbirsi. Ma i soli momenti vivi nei singoli uomini, i soli periodi di alta civiltà nella storia, sono quelli in cui i due processi di differenziazione e di indifferenziazione trovano un punto di mediazione e coesistono nell’atto creatore»7.
Al di là delle tante possibili interpretazioni del percorso politico-filosofico pittorico e letterario di Carlo Levi, quello che mi preme cogliere è il rigore che troviamo in ogni suo gesto, in ogni suo pensiero. Italo Calvino ha correttamente definito l’amico Carlo Levi come lo scrittore «più dedito alle cose, al mondo oggettivo, alle persone. Il suo metodo è di descrivere con rispetto e devozione ciò che vede, con uno scrupolo di fedeltà che gli fa moltiplicare particolari e aggettivi. La sua scrittura è un puro sentimento di questo suo rapporto amoroso col mondo, di questa fedeltà agli oggetti della sua rappresentazione»8. Rigore e scrupolo di fedeltà sono sorretti da una attitudine umana e introspettiva non costretta entro angusti dettami, il fine ultimo resta non tanto la cura del male individuale e sociale, quanto quella che amo definire pratica della cura che si realizza nella paziente osservazione di se stessi nello scorrere della vita, di quella vita di cui – come medico e come uomo – percepisce paradossalmente l’impossibile cura9, ma alla quale partecipa sempre con amorevole enfasi di rinascita, con gioia quasi sublime, quella gioia innata che, apostrofando Freud, verrebbe da ricondurre alle sue origini ebraiche (Freud in una lettera alla fidanzata Martha riconduceva la gioia allo spirito ebraico: «L’ebreo è per la gioia e la gioia è per l’ebreo»).
Levi, pur abbandonando quasi immediatamente la professione medica per dedicarsi alla pittura, alla scrittura e all’attività politica dei movimenti clandestini antifascisti, prosegue nell’indagine, nell’analisi, nella ricerca della sintesi e dell’unità proprio attraverso la “pratica della cura”, fatta di dedizione al vissuto proprio e altrui, che forgia nel tempo nuove modalità e forme espressive: pittura e scrittura divengono nella realtà concreta comunicazione che aspira, se non a sanare, almeno a lenire il dolore di quella frattura tra uomo e realtà.
Io penso effettivamente e intimamente che, se mi si chiede in modo poetico se gli organi umani hanno una propria vita e se sia possibile dunque curarli come se avessero orecchie, che sia possibile con appropriate tecniche della parola, intendendo sempre con la parola non solo e non esclusivamente la parola parlata, ma qualunque modo di esprimersi, di «parlare», sia esso un intervento chimico, biologico, medico, in tutti i sensi, con tutti i modi e gli strumenti: qualcosa che si rivolga a una memoria da ricostruire o da modificare o da riprendere o da guarire10.
Carlo Levi sente che la rottura tra uomo e realtà abita prima di tutto in se stesso, per questo anela all’unità attraverso la pratica della cura, egli sa che «la storia del mondo è iscritta nella malattia assai meglio e più chiaramente e profondamente incisa che nella storia delle idee e delle istituzioni, assai più ingannevole e equivocabile e alterabile e sofisticabile che non quella dei tessuti, della carne e del sangue, del cuore e del respiro», questo scrive nel Quaderno a cancelli riflettendo sul diabete che è all’origine della sua cecità. Qui l’Autore proietta addirittura all’interno di un discorso di relazione biochimiche prodotte dall’organismo umano, modalità diverse di rapportarsi alla realtà e all’altro, suddividendo il genere umano in diabetici e allergici.
«La grande civiltà orgogliosa degli Eroi che sdegnano il pericolo nascosto o palese, e la cui vera virtù è un sorriso coraggioso e superbo (e anche, in certo modo, superiormente pietoso) tutto questo è, ahimè, il Diabete», e prosegue, affermando che i diabetici, sono coloro che non costruiscono «frontiere, passaporti, permessi, eserciti, finanze, divieti»11. Nel loro organismo le sostanze circolano fra i tessuti «senza trovare difese, le osmosi interne non hanno altro ostacolo che le leggi della fisica chimica; i cibi sono considerati amici come tutti gli altri elementi della natura; che è tutta cibo, cioè conoscenza […]». Al contrario, gli allergici sono tenuti all’erta da un nemico costante e forse immaginario, che impone frontiere e intolleranza, paura dell’alterità e rituali simbolici, ricercano nella società un colpevole, sono gli inventori del complesso di colpa, degli stati, della vita difensiva di gruppo, dei clan, delle città, delle frontiere, e sentono di doversi continuamente proteggere dagli stimoli esterni, irrigidiscono il confine dell’io per preservarsi dall’intrusione, ai loro occhi dannosa, si chiudono di conseguenza al mondo e all’altro.
Italo Calvino all’indomani della pubblicazione postuma del Quaderno a cancelli avvenuta nel 1979, acutamente nota come l’Autore abbia identificato i caratteri diabetici partendo da un suo autoritratto ideale, da un modello d’atteggiamento verso il mondo12. Tuttavia, come medico preparato e scrupoloso, Levi sa bene che anche il diabete sottopone il sistema immunitario a un grande lavoro di difesa e di attacco nei confronti delle proprie cellule. Questo autoritratto ideale manifesta anch’esso, dunque, delle crepe. L’unica alternativa è lasciar cadere ogni muro, ogni frontiera, e faticosamente accedere alla vita fatta di oscurità e di luce, e di materia. Di terra. Terra «antica, nuda, bruciata da tutti i soli, lavata e spogliata da tutte le piogge» dello stesso colore «del viso degli uomini e delle donne […] della pazienza e del coraggio di vivere».
L’unica via è praticare con magmatica presenza la cura del vivere.
Isolato dagli uomini mi volgo alle immagini, richiamo i ricordi di un passato che pare pieno di luce come a trovarvi una prova della vita, una certezza oggettiva che nulla nel presente mi potrebbe fornire […]. Tuttavia, in questo mondo che non è tale pure io vivo […] io debbo dare tutto, ricostruire, cavandoli di dentro a me, i termini e le distinzioni, e, senza mattoni e calce, riedificare la città, e, riedificata, operosamente abitarla.
Fonte immagini: Paolo Monti – Available in the BEIC digital library and uploaded in partnership with BEIC Foundation.The image comes from the Fondo Paolo Monti, owned by BEIC and located in the Civico Archivio Fotografico of Milan., CC BY-SA 4.0. – wekimedia
- Da una lettera a Einaudi, in prefazione a Cristo si è fermato a Eboli, edizione Einaudi.
- C. Levi, Contadini di Calabria, in «L’Illustrazione italiana», 6 giugno 1963.
- Non fu facile portare a termine Quaderno a cancelli nell’immobilità di un letto d’ospedale e nella cecità, seppur temporanea. Carlo Levi si avvalse dell’ausilio da lui stesso ideato di una sorta di scrittoio: un «quaderno» di legno a cerniera, munito di cordicelle tese tra le due sponde per guidare la mano. Per un approfondimento del periodo in questione si rimanda al catalogo della mostra, Carlo Levi. I disegni della cecità, tenutasi a Padova dal 3 al 30 settembre 2013 e realizzata in collaborazione con l’Archivio Storico Tono Zancanaro.
- Carlo Levi, Paura della libertà, in Scritti politici, a cura di D. Bidussa, Einaudi, Torino 2001, cit., p. 135.
- Marisa Volpi, L’occhio senza tempo. Saggi di critica e storia dell’arte contemporanea, Lithos, Roma 2008, p. 701.
- Dalla lettera a Giulio Einaudi in parte inserita nella prefazione al Cristo si è fermato a Eboli, di cui questa citazione non inglobata, e conservata fra le carte della Fondazione, FL, busta 59, c. 7764.
- Carlo Levi, Paura della libertà, Einaudi, Torino 1946, p. 19.
- Italo Calvino, La compresenza dei tempi, in Paura della libertà, in Saggi 1945-1985, a cura di M. Barenghi, Vol. 1, Mondadori, Milano 1995p. 1125.
- Filippo La Porta, L’impossibile “cura” della vita, Castelvecchi, Roma 2021.
- Intervista dell’agosto 1970, in Scrittori, malattia e medicina, ora in Un dolente amore per la vita, Donzelli, Roma 2003, p. XV.
- Carlo Levi, Quaderno a cancelli, a cura di R. Gasperina Geroni, Einaudi, Torino 2020, p. 180.
- Italo Calvino, Carlo Levi. Il quaderno a cancelli, in Saggi. 1945-1985, a cura di M. Barenghi, Mondadori,