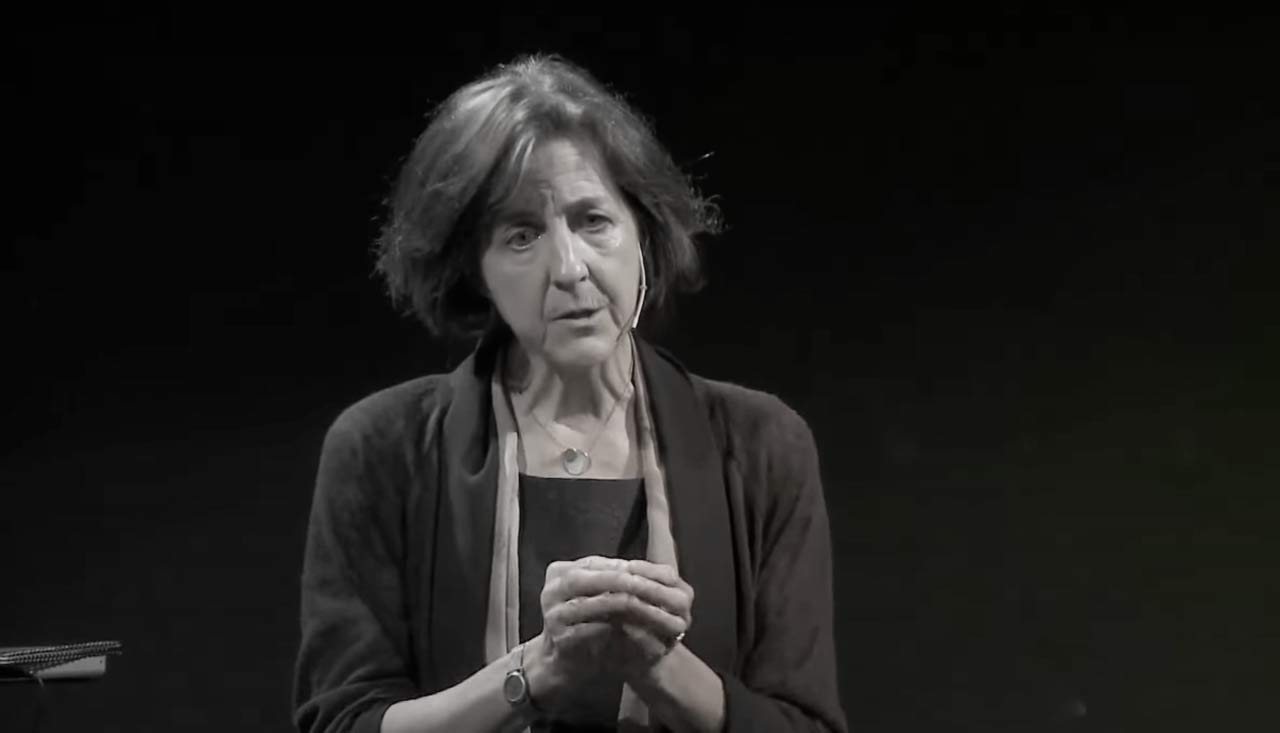Rita Charon (nata nel 1949), medico internista e studiosa di letteratura, ha pubblicato nel 2006 il testo di riferimento del Programma di Medicina narrativa da lei creato e diretto alla Columbia University.
Medicina narrativa. Onorare le storie dei pazienti
Nella Prefazione a questo libro scrive che offrire ai medici delle competenze narrative può essere loro di grande aiuto: “possiamo offrire quello che manca alla medicina di oggi: l’attenzione agli individui, il senso di responsabilità, l’umiltà e l’empatia”.
“La formazione narrativa include una vasta gamma di competenze. Noi insegniamo ad analizzare i testi con cura e a scrivere in maniera riflessiva, disciplinata e ponderata. Trasmettiamo la capacità di recepire le storie degli altri con onestà e rispetto”.
“Bisogna saper ascoltare gli ammalati, rispettarne le storie, lasciarsi coinvolgere per agire nel loro interesse”.
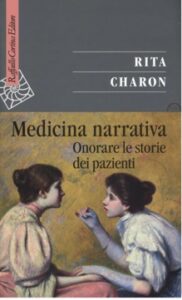 Nell’epoca del suo grande sviluppo tecnologico, la medicina deve a maggior ragione avere l’esigenza di essere anche il luogo di incontro di esperienze vissute, di essere una rete di storie di cura. La medicina narrativa va evidentemente incontro al bisogno di umanizzare la medicina.
Nell’epoca del suo grande sviluppo tecnologico, la medicina deve a maggior ragione avere l’esigenza di essere anche il luogo di incontro di esperienze vissute, di essere una rete di storie di cura. La medicina narrativa va evidentemente incontro al bisogno di umanizzare la medicina.
“Per comprendere la sofferenza ed essere clinicamente d’aiuto, si deve entrare nel mondo del paziente, guardarlo e interpretarlo attraverso i suoi occhi, anche solo con l’immaginazione. Per arrivare a diagnosi accurate, c’è bisogno di immergersi nella storia naturale dei disturbi, indagando minuziosamente i cambiamenti corporei sul lungo periodo”.
La malattia non è solo un’entità nosografica, il malato è anche la sua storia. Un caso clinico è un mistero da risolvere ed una storia da raccontare. La medicina è scienza ed è anche arte: anzi – come ha scritto Novalis – “La medicina deve trasformarsi nell’arte di vivere”.
Tra i sintomi del paziente ci sono sicuramente anche le sue emozioni, le sue paure, le sue vergogne. Perciò: “il cuore della medicina è la relazione”.
La Logica della Narrazione
La Narrazione è la logica che ci fa capire da dove proveniamo e verso dove stiamo andando, organizza l’esperienza della nostra vita verso i superiori scopi dell’esistenza.
Nella pratica clinica è giusto che si sovrappongano tempi diversi. “Il tempo è l’asse portante del processo diagnostico, della prevenzione, delle cure palliative, della guarigione. È anche l’ingrediente fondamentale della relazione terapeutica: ci vuole tempo per ascoltare, per comprendere, per curare. Se si rispetta questo elemento, la medicina ne esce trasformata”.
La singolarità di ogni paziente si rivela nelle forme in cui egli si narra. “La tendenza della medicina alla replicabilità e all’universalità non ci dà modo di cogliere la singolarità delle nostre osservazioni. Siamo persone uniche, e abbiamo che fare con persone uniche”. Un paziente che racconta la sua esperienza prende la vita tra le sue mani, riafferma la sua soggettività.
Nella trama di un racconto si conserva un nesso di causalità, ma al tempo stesso esso diviene complesso e non lineare, si apre ad una rete di possibili letture ed interpretazioni, offre imprevedibili punti di svolta.
La relazione terapeutica è leggibile come una metanarrazione: “Si basa su testi molto complessi, fatti di parole, silenzi, risultati fisici, misurazioni di sostanze e segnali del corpo”.
C’è anche un aspetto deontologico nell’ascolto di un paziente. “Siamo legati a chi ci consegna una storia”. Chi cura può aiutare chi racconta a capire cosa intendesse dire, a dare forma alla storia delle sue sofferenze. È come se il paziente potesse, attraverso chi gli presta cura, ascoltare se stesso.
La biopatografia di un paziente è essenziale. “Senza narrazione e senza ascolto, non si può comunicare a nessuno, neanche a se stessi, quello che si sta vivendo, né, in maniera più radicale ma forse ugualmente vera, coglierne il senso”.
E l’arte del medico è anche arte dell’ascolto. “Abbiamo l’onore e l’onere di assimilare, nel corso del tempo, quello che i nostri pazienti decidono di dirci sulla loro salute, sul loro passato, sulle loro esistenze, sulle loro speranze. Gli facciamo da specchio, restituendo unità, coerenza e significato alle loro storie attraverso l’ascolto”.
L’ascolto come testimonianza
L’ascolto è anche la testimonianza di una sofferenza, di una violenza subita. “Il testimone non compie un ulteriore atto di violenza e non interferisce con il racconto, ma è impegnato in un ascolto attivo e rispettoso”.
La malattia può gettare una luce folgorante sulla vita del malato. “Se la malattia apre le porte, noi non possiamo chiuderle. Dobbiamo saper fare da levatrici per le storie che nascono, cogliere le varie voci e trame, avere le giuste reazioni”.
La narrazione trasforma la cura e la individualizza, poiché ogni narrazione è diversa dalle altre, ed è in essa che si costruisce un rapporto di fiducia. “La medicina narrativa, condividendo gli obiettivi delle cure centrate sul paziente, apre le porte alla ricerca di senso, esattamente come la malattia”. È allora che il sintomo può diventare il punto di incontro, l’inizio della storia comune tra il medico ed il paziente.
C’è una valenza etica nell’ascolto di una persona. La bioetica stessa diviene narrativa, dato il ruolo che la narrativa ha nella vita. I problemi etici, le questioni di senso sono racconti e storie di vita prima che concetti e norme. “Il bioeticista narrativo si siede accanto al paziente, gli presta ascolto, gli dà la possibilità di raccontare e quindi di comprendere la malattia”. “Una cosa è certa: quando ci comportiamo con benevolenza e coraggio verso qualcuno che soffre, ne usciamo trasformati”.
Ne esce fuori una visione più adeguata di come in generale intendere la cura e la salute“. La medicina narrativa aiuta a trovare gli strumenti per lavorare insieme alla costruzione di una sanità equa, umana ed efficiente”.
Narratologia
Si può ritrovare nella narratologia uno strumento prezioso e transdisciplinare. Lo studio delle strutture narrative diviene importante, ogni volta che uno storytelling sia al crocevia tra realtà ed illusione.
La narrazione fa della storia un’arte. Nel senso proprio per cui Aristotele riteneva l’arte, in quanto rappresentazione dell’universale, pure superiore alla storia, che è rappresentazione del particolare. In ogni narrazione c’è quella funzione simbolica di far diventare universale il particolare.
È del 2023 Storythinking, il libro di un neurobiologo oltre che dottore di ricerca in letteratura, Angus Fletcher. Cercando, dice l’autore, “di individuare l’elusivo momento in cui le storie prendono vita”, ovvero “di cogliere il secondo alchemico in cui la narrazione si fonde con la coscienza umana, trasformandola”, ci si trova davanti ad una scoperta: che le storie servono a pensare.
La selezione naturale ha reso l’uomo creativo per la sua capacità di rispondere a sfide ed opportunità impreviste organizzando nuove trame, rendendosi finalmente capace di immaginare vari mondi possibili e realtà contingenti. Lo storytelling perciò può essere non solo una forma di comunicazione, ma pure una forma di pensiero, creativo.
Il cervello umano opera anche come una macchina narrativa, e ciò lo avvicina alle nostre emozioni. La paura ci fa immaginare cose. La capacità di cambiare prospettiva e punto di vista ci educa alla compassione, e viceversa.
La medicina sappiamo come sia arte e scienza. Ma nel contesto più generale per cui il pensiero stesso è logos e mythos. Il pensiero scaturisce dalla parola: che è discorso scritto, razionale ed analitico; ma che era già prima racconto orale ed affabulatorio.