BIO – Medicina Costruzione Sociale nella Post-Modernità – Educational Papers • Anno XIV • Numero 53 • Marzo 2025
Una lacuna nella storia del pensiero biologico: la questione degli errori negli organismi viventi
Poiché quest’argomentazione anziché un peer-review paper costituisce soltanto un mio sforzo divulgativo di una questione in discussione dagli esperti nella materia, suggerisco di leggere questo testo come un mio tentativo di equilibrio narrativo derivato dalla lettura accademica e la mia visione del mondo.
Prendiamo la strada di questa discussione che ipotizza che l’errore si riscontra ovunque vi siano sistemi viventi con un poco di leggerezza, lasciandoci guidare dal filosofo David S Oderberg e dal suo gruppo di ricerca1. Certamente, ci capita di dimenticare dove abbiamo parcheggiato. Smarriamo le chiavi. Leggiamo male le istruzioni. Perdiamo la cognizione del tempo. Chiamiamo le persone con il nome sbagliato. Chiaro: errare è umano, come scrisse Alexander Pope nel suo Essay on Criticism (1711). Ma non è esclusivamente umano.
Stando al gruppo di ricerca2 del progetto Mistakes in Living Systems: A New Conceptual Framework for the Study of Purpose in Biology,3 tutti gli animali e perfino gli organismi più semplici fanno cose che impediscono loro di sopravvivere, riprodursi, essere al sicuro o essere felici. Tutti gli animali sbagliano. Si pensi a un pesce che abbocca all’amo di metallo. Si pensi ai cani che dimenticano dove hanno seppellito le loro ossa o alle rane che mancano di pochi millimetri la cattura di un insetto o puntano la lingua nella direzione sbagliata. Gli uccelli costruiscono nidi fragili. Le balene si arenano. Oppure si pensi a quelle galline domestiche che cercano di far schiudere palline da golf, come elencano Oderberg e citando le ricerche di Bauer e Mathesius, Plant Responses to Bacterial Quorum Sensing Signals4.
Ma, è pensiero comune perfino per i partecipanti al progetto di ricerca Mistakes in Living Systems, che non tutto nell’Universo sembra commettere errori. Mentre gli esseri viventi navigano in un mondo pieno di “errori biologici”, i cosiddetti mattoni fondamentali del cosmo aderirebbero, fino a prova contraria, alle leggi della fisica con incrollabile coerenza. Come segnala Oderberg, basandosi sulle ricerche di Ramamoorthy, Abraham, e Isaac Mitochondrial Dysfunction and Electron Transport Chain Complex Defect in a Rat Model of Tenofovir Disoproxil Fumarate Nephrotoxicity’5, nessuno ha mai colto un elettrone in errore, per non parlare di un atomo, uno ione di sodio, un pezzo d’oro, una goccia d’acqua o una supernova. Gli oggetti che i fisici studiano, i puri oggetti della fisica, non commetterebbero errori. Invece, seguirebbero leggi ineluttabili.
Ed è qui che emerge un problema, puntualizza Oderberg. Gli organismi che commettono errori, come ogni altra cosa nell’Universo, sono fatti di atomi e molecole rispettosi della legge. Di conseguenza, s’impongono, coerentemente, una serie di domande: – dove inizia e finisce l’errore negli esseri viventi? Quanto in profondità va? Le parti e i sottosistemi degli organismi, come i sistemi immunitari o le piastrine nel sangue, possono commettere errori? E, se lo fanno, c’è qualcosa che colleghi gli errori umani a quelli commessi dai sottosistemi biologici in generale?
Ovviamente, possiamo renderci conto che le risposte a queste domande hanno profonde implicazioni sul modo in cui pensiamo alla vita. Se le cose vanno male solo quando la fisica diventa biologia, la biologia potrebbe essere, davvero, irriducibile alla fisica e alla chimica, nonostante secoli di riduzionismo affermino il contrario. Dinanzi a tali domande complesse c’è il rischio di scivolare nella metafisica, congetturando che ciò possa addirittura significare che gli organismi abbiano davvero obiettivi e scopi “corretti” da cui possono deviare erroneamente. Questo ragionamento implica che gli organismi siano, davvero, teleologici, nonostante una lunga storia di argomenti meccanicistici affermino il contrario, come asserisce Oderberg facendo riferimento anche ai lavori di A. L. Crawford, Metaphor and Meaning in the Teleological Language of Biology6,
Visto lo stato dell’arte della narrazione sugli errori degli organismi, Oderberg e suo gruppo propongono che se gli errori della vita sono, davvero, onnipresenti come sembrano, ciò può significare che abbiamo bisogno di un articolato paradigma per spiegare cosa succede quando le cose vanno male. In breve, abbiamo necessità di una teoria degli errori biologici.
Come filosofo, Oderberg, ha trascorso gran parte della sua vita a studiare i rompicapi della metafisica e dell’etica. Ha esplorato la natura della realtà, il concetto di essere e le implicazioni morali dell’azione umana. Ma, negli ultimi anni, ha lavorato, con dedizione, sul problema degli errori con il suo team di ricercatori presso l’Università di Reading nel Regno Unito7. Ciò che li ha attirati verso quest’argomento è stato il loro stesso sconcerto per una lacuna importante nella storia del pensiero biologico.
Sorprendentemente, la questione degli errori è stata per lo più ignorata dai ricercatori, perfino tra biologi e filosofi della biologia, e le definizioni tradizionali della vita hanno ampiamente trascurato il ruolo degli errori, concentrandosi invece su successi, adattamenti e mutazioni benefiche. Ecco perché, alla fine del 2010, il team di Oderberg, impegnato nel progetto Mistakes in Living Systems: A New Conceptual Framework for the Study of Purpose in Biology, ha iniziato a studiare come uno sguardo più rigoroso circa l’emergere degli errori negli organismi viventi possa generare nuove ipotesi scientifiche. Come, si sarebbero chiesti, gli errori potevano essere compresi in modo più sistematico e interdisciplinare?
Negli ultimi secoli, studiosi e scienziati si sono concentrati su ciò che va bene piuttosto che su ciò che va male. L’idea di correttezza negli esseri viventi ha assunto molte forme. Nel XVII secolo, durante i primi giorni della rivoluzione scientifica, René Descartes caratterizzò gli animali come automi: macchine fatte di tessuti che obbedivano a leggi meccaniche, come i movimenti di un orologio. Nessun movimento poteva aver luogo, scrisse Descartes, né nei corpi delle bestie, né nei nostri corpi umani stessi, se questi corpi non avessero in sé tutti gli organi e gli strumenti per mezzo dei quali gli stessi movimenti sarebbero compiuti in una macchina. L’idea degli automi implica che gli animali possono solo funzionare male o rompersi piuttosto che commettere errori. In questa interpretazione, comprendere i circuiti interni direbbe tutto ciò che si dovrebbe sapere sul modo “giusto” in cui un animale deve comportarsi.
Stando alla narrazione storica della questione proposta da Oderberg e il suo gruppo, due secoli dopo, una diversa visione della correttezza e dell’errore biologico emerse attraverso il lavoro di Charles Darwin. Da una prospettiva darwiniana, se qualcosa conti come un errore può essere valutato solo alla fredda luce del tempo evolutivo, dopo che una specie abbia perpetuato la sua discendenza o si sia estinta. Gli organismi, secondo la visione standard dell’evoluzione, sono, semplicemente, il prodotto di una cieca selezione naturale che opera attraverso il successo della variazione genetica casuale. In questo caso, la variazione giusta porterebbe una specie a essere più adattata al suo ambiente e più propensa a sopravvivere, riprodursi e continuare a evolversi.
Stando al resoconto della questione secondo Oderberg e il suo gruppo impegnato nel progetto Mistakes in Living Systems: A New Conceptual Framework for the Study of Purpose in Biology, per comprendere come le cose possano andare male per gli animali al di fuori del tempo evolutivo, i comportamentisti studiosi degli animali del XIX e XX secolo avvevano posto una rinnovata enfasi sullo studio dei singoli organismi. Al riguardo suggeriscono di pensare a comportamentisti come B. F. Skinner, ma anche a etologi come Charles Otis Whitman, Oskar Heinroth, Konrad Lorenz e Nikolaas Tinbergen. I loro scritti contengono esempi di errori commessi dagli animali, come gabbiani che identificano male le uova e anatroccoli che si attaccano a oggetti inanimati. I biologi influenzati dalle opere seminali di Lorenz e Tinbergen ora indagano regolarmente gli errori in varie forme. Tuttavia, stando a Oderberg, non esiste ancora un grande quadro concettuale, nessuna teoria degli errori, che potrebbe creare un’interfaccia tra filosofia e biologia.
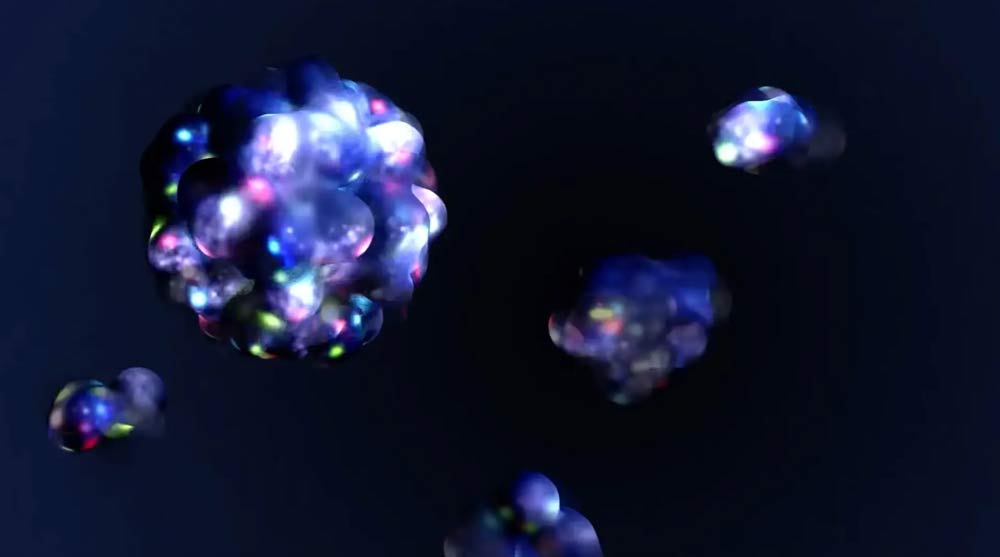
La necessità di una teoria degli errori negli organismi come un’euristica per la ricerca in biologia e per una reinterpretazione del costrutto vita
Per Oderberg e il suo gruppo di ricerca nel progetto Mistakes in Living Systems: A New Conceptual Framework for the Study of Purpose in Biology, pensare agli errori biologici ci fornirebbe il giusto tipo di orientamento per comprendere noi stessi e gli altri organismi. Concentrerebbe la nostra attenzione sul fatto che i sistemi viventi, dai parameci8 alle persone, sono soggetti a standard normativi di giusto e sbagliato. Ciò può, nell’interpretazione di Oderberg, essere spiegato semplicemente: quando gli esseri viventi operano in un certo modo, vanno bene; quando operano in un altro modo, le cose vanno male.
La vita, in questa teoresi, sarebbe disseminata di tentativi di evitare, correggere o minimizzare gli errori. Gli esseri viventi impiegano tutti i tipi di strategie per mantenersi sulla retta via normativa. Sotto questo aspetto Oderberg considera che non sorprende che il recente lavoro di ricercatori come Daniel Kahneman e Amos Tversky9 sugli errori umani sia stato così importante e influente. Noi umani utilizziamo euristiche, scorciatoie mentali o regole empiriche, per giudicare situazioni, classificare preferenze, valutare persone e così via. Molto spesso queste euristiche ci servono bene, ma altre volte ci portano fuori strada. Non importa quanto una specie possa essere elevata o potente nel suo ambiente, tutte sbagliano10.
Ecco perché il team del progetto Mistakes in Living Systems: A New Conceptual Framework for the Study of Purpose in Biology11 avrebbe cercato di sviluppare un rigoroso framework concettuale per riflettere sugli errori e sulla normatività. Con un tale framework, questo gruppo si augura di aiutare a generare nuove ipotesi verificabili per i biologi sperimentali e potrebbe far luce su molti degli errori a cui noi esseri umani siamo inclini. Ma sviluppare il loro framework o paradigma euristico li avrebbe portati in direzioni inaspettate. Al riguardo, confidano nella loro ipotesi che suggerisce che commettere errori potrebbe illuminare la natura della vita stessa. Potrebbe perfino documentare e accreditare l’ipotesi, una volta per tutte, che sostiene che la biologia sarebbe irriducibile alle leggi della fisica e della chimica perché gli atomi, ricordate, non commettono errori. Sotto questo aspetto, avanza qualsiasi commento sulla rilevanza della questione per la medicina stessa e la nostra salute perché la faccenda riguarda palesemente il costrutto della normatività biologica!
Le aporie del costrutto di normatività biologica
La domanda iniziale di Oderberg, in termini di filosofia della scienza, inevitabilmente è: – se gli organismi sono fasci di atomi che obbediscono alle leggi fisiche fondamentali, come emergono gli errori? Oltre a tutto il resto nell’Universo, siamo anche influenzati da leggi fisiche come la gravità. Ma al riguardo, Oderberg e il suo gruppo propongono una controversa considerazione: le leggi non sarebbero tutto ciò che influenza quello che fanno gli organismi. Certamente, questo non devia la loro ricerca su scorciatoie metafisiche, affermando che c’è qualcos’altro che accade quando fasci di atomi diventano organismi viventi e questo sarebbe la fenomenologia sotto il costrutto di normatività biologica.
Stando al costrutto di normatività biologica, gli organismi sono governati da norme di comportamento corretto e, quando si allontanano da queste norme, possono ammalarsi, non adattarsi, soffrire, morire o disintegrarsi. Per evitare tali destini, avrebbero principalmente bisogno di fare ciò che è giusto per loro: devono agire al momento e nel luogo giusti, nelle circostanze giuste, nel modo giusto. Per scaricare le connotazioni valutative delle precedenti asserzioni, che rendono la tonalità del discorso fin troppo manichea e umana, aggiustiamo la visione di Oderberg, aggiungendo il suo esempio magistrale di normatività biologica: il predatore deve avere il tempismo giusto, colpire con precisione, spendere abbastanza energia per sottomettere la preda senza esaurirsi!
Allora, se da una parte gli organismi seguirebbero, per legge, una normatività e, tuttavia, commetterebbero errori, si potrebbe congetturare che le leggi fisiche da sole non possano spiegare cosa sia giusto o sbagliato per un organismo perché, in fisica, tutte le sequenze di eventi accadrebbero alla pari, ovvero sarebbero tutte trattate allo stesso modo. Per chiarire il suo ragionamento Oderberg ci invita a considerare il fenomeno del trasferimento di elettroni da una molecola all’altra, noto come catena di trasporto degli elettroni. Questo trasferimento sarebbe fondamentale per generare energia nella maggior parte, se non in tutti, degli esseri viventi e mantenere gli organismi vivi e sani.
Come spiega Oderberg da una prospettiva puramente fisico-chimica, il processo di trasporto degli elettroni è sempre lo stesso. Ciò che lo storico Arnold J Toynbee disse della storia potrebbe in effetti essere detto della fisica: Solo una dannata cosa dopo l’altra. Tuttavia, il processo di trasferimento degli elettroni può andare molto male. Ad esempio, una molecola che non riesce a trasportare gli elettroni nel modo giusto causerà una disfunzione mitocondriale, che porterà ad un organismo malato, come si desume dei lavori di Ramamoorthy, Abraham e Isaac. Di conseguenza, ragiona Oderberg, si è costretti a suppore che, malgrado le leggi della fisica e della chimica, non tutti i casi di trasporto degli elettroni sarebbero uguali.
Da questa premessa si può allora suggerire, sostiene Oberberg, che quando si tratta di vita, alcune sequenze sono semplicemente migliori di altre perché promuovono la salute, l’integrità, la sopravvivenza. Tali successioni promuovono la fitness o prosperità. Oppure, si può considerare che diversi corsi d’azione lavorano a favore o contro l’organismo nel suo ambiente. Il corso d’azione sbagliato sarebbe, pertanto, un errore nell’andamento biologico dell’organismo, prendendo in considerazione anche il lavoro di R. N. Brandon, Adaptation and Environment.12
Tali nozioni e ragionamenti possono sembrare ovvi, ma le idee racchiuse in una tale definizione di normatività biologica sono complicate e controverse. Per alcuni, segnala Oberberg, affermare che il corso d’azione sbagliato sia un errore potrebbe davvero puzzare di teleologia13, pensiero che è stato praticamente bandito per gran parte del XX secolo. La nozione deriva dal greco telos, cioè fine o scopo, che è il termine classico per ciò che ora è più comunemente chiamato orientamento all’obiettivo o finalità. Invocare la teleologia era un serio problema per i biologi del XX secolo. Nel 1988, il biologo evoluzionista Ernst Mayr contestò il concetto perché riteneva che implicasse la postulazione di misteriose cause retrostanti. Ma contestare il costrutto comportava una domanda propriamente difficoltosa: – in che modo gli obiettivi futuri possono orientare il comportamento attuale degli organismi?
Come avrebbe affermato il biologo Colin Pittendrigh: “Per un po’ di tempo i biologi erano pronti a dire che una tartaruga era scesa a riva e aveva deposto le uova, ma si sono rifiutati di dire che era scesa a riva per deporre le uova”14. Dire che la tartaruga era scesa a riva con l’obiettivo di deporre le uova suggerisce che, anche mentre si trovava nell’oceano, la tartaruga era stata guidata da uno stato futuro che l’aveva indirizzata verso la spiaggia lavorando misteriosamente a ritroso nel tempo per influenzare il suo comportamento qui e ora. La causalità a ritroso è un ragionamento difficile da accettare per la maggior parte dei filosofi, insieme al resto di tanti altri studiosi. Stando a Oderberg e al suo gruppo certamente, qualsiasi cosa spieghi il comportamento della tartaruga nel deporre le uova dovrebbe essere interamente qui e ora, un prodotto di passati processi evolutivi.
La questione dello stato futuro nelle aporie della normatività in biologia
Gli obiettivi o gli scopi si riferiscono, effettivamente, a stati futuri in cui un organismo mira a trovarsi, come riprodursi, sopravvivere, adattarsi all’ambiente, essere sani o vivere in un gruppo sociale ben funzionante. Tuttavia, secondo i ricercatori del progetto Mistakes in Living Systems: A New Conceptual Framework for the Study of Purpose in Biology sarebbe rozzo identificare lo stato futuro con l’obiettivo puro e semplice. Nella loro interpretazione della questione della normatività in biologia, l’obiettivo non può essere uno stato futuro.
Tuttavia, per chiarire che il costrutto degli obiettivi potrebbe essere reinterpretato e farlo rientrare, senza esalazione di teleologia, nella teoria degli errori biologici, Oberberg suggerisce di considerare la questione in questi termini.
Ad esempio, si potrebbe avere l’obiettivo di scalare l’Everest molto prima di mettere piede sulla montagna. Lo stesso potrebbe valere per tutti gli altri organismi. Avere un obiettivo significa rendere qualcosa reale. Significa perseguire qualcosa, che si tratti di cercare cibo, riparo o un compagno, piuttosto che essere spinti in giro nel presente da uno stato futuro. Gli obiettivi in biologia, sostengono, dovrebbero essere chiaramente intesi come quelli cablati negli organismi come pulsioni, tendenze e disposizioni ad agire in determinati modi, come essere sani o sopravvivere. L’orientamento all’obiettivo deve essere presente qui e ora mentre indirizza un organismo verso stati futuri. E niente di tutto ciò implicherebbe alcun requisito di consapevolezza, per non parlare di qualcosa di così complesso come l’autocoscienza, sostiene Oderberg e il suo gruppo, facendo riferimento al lavoro di S. Okasha, Agents and Goals in Evolution15.
Negli ultimi decenni, però, secondo Oderberg, il divieto di teleologia è stato revocato e alcuni filosofi sono stati disposti a prendere sul serio il concetto. Ma molti, specialmente quelli influenzati dal filosofo della scienza Ernest Nagel16, continueranno a insistere sul fatto che l’orientamento all’obiettivo si riduca alla fisica e alla chimica. Per questi pensatori, sostiene Oderberg e il suo gruppo, non ci sono spiegazioni biologiche sui generis sul perché gli organismi sbagliano. La loro sarebbe, però, stando a Oderberg e il suo gruppo di ricercatore nel progetto Mistakes in Living Systems: A New Conceptual Framework for the Study of Purpose in Biology, una visione riduttiva che fraintende il modo in cui vengono commessi gli errori. L’interpretazione di Oderberg e il suo gruppo sarebbe che per commettere questo tipo di errore, un organismo dovrebbe discostarsi dagli standard di correttezza. Dovrebbe fare qualcosa di sbagliato. Ma, e questo sarebbe uno dei contributi più significativi del nuovo paradigma concettuale proposto dai ricercatori del Mistakes in Living Systems: la correttezza o normatività in biologia non deriverebbe dalla fisica o dalla chimica.
Stando alle considerazioni dei partecipanti nel progetto Mistakes in Living Systems, per gli scettici riduzionisti, le nozioni di buono e cattivo sono facilmente spiegate dall’evoluzione. Per questi scettici, facendo riferimento al lavoro di L. Heil, The Universe as We Find It17, che rifiutano la proposta che considera che normatività in biologia non deriverebbe dalla fisica o dalla chimica, spiegano Oderberg e il suo gruppo, la normatività non sarebbe altro che un gioco di numeri e la cattiveria apparirebbe quando una specie non riesce a produrre abbastanza prole per adattarsi e perpetuarsi. La bontà sarebbe l’inverso, apparirebbe quando una specie si riproduce con successo abbastanza da generare le variazioni genetiche necessarie per adattarsi e sopravvivere.
Per comprendere la normatività, quindi, sarebbe sufficiente comprendere come un organismo contribuisce all’idoneità (fitness) della sua specie. Gli organismi o aiutano la loro specie ad adattarsi al loro ambiente creando con successo prole, oppure contribuiscono all’estinzione della loro specie non riuscendo a riprodursi. Per lo scettico riduzionista, spiega Oderberg facendo riferimento esplicito a Heil, che pensa che gli unici errori significativi che un organismo possa fare siano legati all’idoneità, non ci sono azioni buone o cattive perché la normatività biologica non esiste.
I partecipanti nel progetto Mistakes in Living Systems non credono che l’assenza di normatività spieghi adeguatamente il commettere errori. Per loro la prosperità o fitness biologica non riguarda solo la riproduzione di successo. Comporta anche fare cose come catturare prede o trovare cibo meglio della concorrenza. In effetti, sostengono che sia perché un uccello costruisce il tipo giusto di nido con il tipo giusto di materiali nel posto giusto che può crescere con successo la prole. Costruire un nido fragile sarebbe un errore. Prendendo una posizione rispettosa, per i partecipanti al progetto Mistakes in Living Systems, la normatività può esistere, pure se si abbia ancora una scarsa comprensione di ciò che sarebbe buono o cattivo per un organismo.
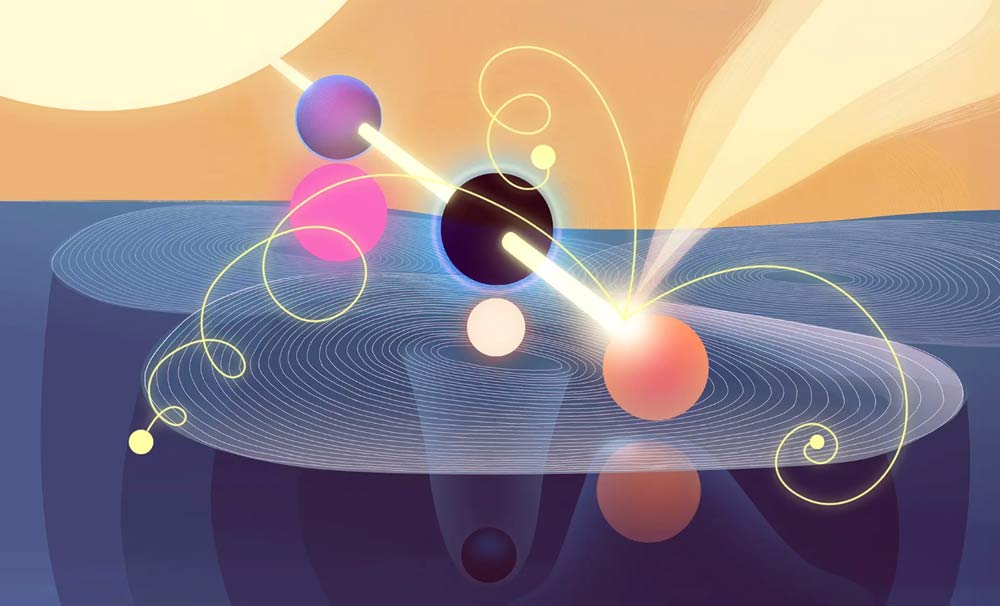
La sopravvivenza di un organismo sarebbe più di un gioco di numeri
Cercando di costruire un’euristica per la ricerca dell’errore in biologia, il nostro gruppo di ricerca di riferimento nel progetto Mistakes in Living Systems18 si chiede se le informazioni fisiche e chimiche sarebbero sufficienti per prevedere cosa conta come errore per un dato organismo, come ad esempio cosa conterebbe come errore nel caso di un uccello che costruisce un nido. In realtà si pongono domanda in linea con R. N. Brandon, in Adaptation and Environment19.
Stando a loro, nemmeno la visione dello scienziato francese Pierre-Simon Laplace di un demone onnisciente, un osservatore onnisciente che sa, momento per momento, tutto sullo stato fisico dell’Universo, sarebbe in grado di fare una previsione accurata. Per loro, comprendere perfettamente le strutture fisiche di un organismo, i movimenti del corpo, le emissioni sonore, le capacità di costruzione del nido o altre caratteristiche, non ci consentirebbe di prevedere quali delle sue azioni siano corrette e quali siano errate. Perciò sostengono che non tutto può essere ridotto a fisica e chimica. La sopravvivenza è più di un gioco di numeri. Dalla loro prospettiva, invece, dovremmo sapere come tutta questa fisica si collega all’azione nell’ambiente: dovremmo capire come un organismo sperimenta il mondo. Sta prosperando? È sano? È mentalmente e fisicamente integrato? È, letteralmente, felice della sua situazione, ciò che forse non sarebbe vero per funghi o vermi, ma sicuramente lo sarebbe per cani e zebre?
La questione dei valori nella definizione degli errori nei sistemi viventi
Ci sarebbe, però, un problema più pervasivo e persistente nel prendere sul serio gli errori e la normatività biologica: i valori. Una cosa è che l’uomo comune possa asserire che gli esseri umani possono agire in modo buono o cattivo, ma i ricercatori del progetto Mistakes in Living Systems possono davvero usare quei concetti carichi di valori per descrivere il comportamento di rane o batteri? Coloro che sono scettici sulla normatività in biologia direbbero, senz’altro, non è possibile. Il filosofo della biologia Justin Garson20, ad esempio, afferma che la normatività non abbia nulla a che fare né con valori né obiettivi, obblighi o doveri, prescrizioni o comandi, né con il bene o il giusto. Se prendiamo sul serio l’argomentazione di Garson, allora il malfunzionamento del cuore di un cane non sarebbe, in alcun modo, letteralmente negativo per il cane, addirittura il cane potrebbe finire malato o morto. Tuttavia, Oderberg si chiede se un tale ragionamento possa essere accettato come corretto. Dopotutto, le cose tendono a non andare bene per un cane con un cuore malato. Le cose sembrano piuttosto buone, tuttavia, per un cane che ha tanto cibo nutriente, aria fresca e compagni con cui giocare, costruendo una parafrasi come se pensasse J. Heil.
Quindi, come contestualizzare tutte queste considerazioni, ipotesi e congettura nel quadro generale delle cose che vanno male a livello biologico? Come risposta Oderberg considera che si possa propriamente usare la nozione valore nel contesto degli errori in biologia se comprendiamo che qualcosa potrebbe essere, in termini assiologici, buono o cattivo per un animale anche se non gli attribuisca un valore cosciente. E quel qualcosa potrebbe essere buona o cattiva anche se non gli attribuiamo un valore. La posizione dei ricercatori del progetto Mistakes in Living Systems sarebbe quella di accettare che la normatività possa esistere, anche se come civiltà abbiamo una scarsa comprensione di cosa sia buono o cattivo per un organismo.
Ecco perché loro asseriscono che gli errori non possano essere banditi dalla cassetta degli attrezzi concettuale della biologia. Ed oggi, pochi biologi mai cercherebbero di farlo, al contrario dei filosofi della biologia, schiavi del riduzionismo o dell’idea di una discontinuità totale tra gli umani e gli altri esseri viventi. La posizione dei ricercatori del progetto Mistakes in Living Systems sarebbe quella di considerare che gli errori biologici aprono la porta a un modo nuovo e rinfrescante di comprendere gli esseri viventi. Guardare gli organismi attraverso i loro errori è potente perché fornisce un’ampia tela all’interno della quale esplorare e studiare, scientificamente, gli organismi. Per di più, rivendicherebbe la natura speciale della biologia.

Le aporie di una teoria degli errori biologici: cosa distingue gli errori da altri tipi di problemi
Tuttavia, ci segnalano i ricercatori del progetto Mistakes in Living Systems21, una volta accettata la possibilità degli errori biologici e dell’eventuale natura speciale della biologia, emergono una serie di problemi complessi: cosa distingue gli errori da altri tipi di problemi? E, poi, una domanda della filosofia della scienza ancora più incerta, in effetti, come possiamo individuare e identificare gli errori? Finora, si è discusso solo di organismi familiari, come uccelli, cani e persone. Sotto quest’aspetto, la loro posizione è che la normatività e la capacità di commettere errori sembrano svolgere un ruolo decisamente fondamentale nella vita sulla Terra.
Sebbene la teoria degli errori biologici al suo stato attuale implichi diverse definizioni tecniche di cosa significhi commettere un tale errore, i contorni sono, relativamente, semplici: un organismo commette un errore quando fa qualcosa che, se non mitigato in qualche modo, ne comprometterà la prosperità o fitness. La teoria in questione ci avverte, altresì, che siamo abituati a dire che gli errori capitano. Ciò, però, stando al nuovo paradigma in elaborazione, non sarebbe vero perché gli errori sono sempre commessi da individui in momenti e luoghi specifici. Ciò significa che gli errori non sono semplicemente insuccessi o malfunzionamenti.
Un fallimento, oppure propriamente un insuccesso, è qualcosa che ci capita, non qualcosa che facciamo. Essere colpiti da un fulmine non è un errore, a meno che uno ignori l’allerta meteo e vada a fare una passeggiata al parco durante un temporale. I cavalli e i bufali non capiscono le previsioni del tempo, quindi ogni volta che vengono colpiti è un semplice fallimento. Lo stesso vale se vengono attaccati da un parassita che li fa ammalare o li uccide: è solo sfortuna. Un malfunzionamento è simile. È qualcosa che va storto nel funzionamento biologico di un organismo, una incapacità di fare qualcosa in un certo modo, come una malattia o una deformità, ma è riducibile ad un errore che l’organismo fa, come sostengono anche J. Matheson, J. E P. Griffiths in Biological Criteria of Disease: Four Ways of Going Wrong22.
Un altro aspetto, che spiegano Oderberg, Hill, Austin, Bojak, Cinotti & Gibbins, riguardante queste aporie della teoria degli errori biologici è che diversi tipi di errori biologici sono simili tra loro in quanto vengono tutti commessi, ma ciò non significa che siano tutti esattamente uguali. Un modo in cui gli errori biologici differiscono, secondo loro, sarebbe in termini di prevedibilità: alcuni errori sono evitabili, altri sono inevitabili o imprevedibili. Tra i loro esempi citati per chiarire questa distinzione c’è quello delle galline domestiche chiocce che cercano di far schiudere palline da golf o altri oggetti simili a uova che vengono lasciati nel loro pollaio. Non lo fanno a causa di qualche guasto o malfunzionamento ma, semplicemente, perché non hanno l’equipaggiamento percettivo per distinguere le uova da cose che assomigliano un po’ ad un uovo. Il loro errore è inevitabile perché non c’è niente di sbagliato in queste galline.
Gli errori evitabili, d’altra parte, si verificano quando un organismo può agire in modi che lo aiuterebbero a progredire in una situazione specifica, ma non ci riesce. In particolare, si consideri un bufalo in allerta per i predatori. Se un leone che si avvicina è visibile, ma il bufalo è distratto, un attacco sarebbe un errore evitabile.
Un esempio di conseguenze importanti è quello di un anticorpo che identifica, erroneamente, un agente patogeno, come se, banalmente, uno scambiasse il cellulare di qualcun altro per il proprio. Ma che sia evitabile o inevitabile, gli errori vengono sempre commessi.
Ma forse come me lo sono chiesto io, anche voi lettori, potreste chiedervi: – ma chi o cosa, esattamente, può commettere questi errori biologici? Effettivamente, mentre il team di ricerca23 guardava più da vicino, avrebbe trovato errori che non erano limitati a singoli organismi. Perfino un insieme di organismi può commettere un errore, come documentava già nel 1975 la ricerca di R. Cummins Functional Analysis
Semplicemente si pensi ad uno stormo di uccelli che vola contro un grattacielo o a un branco di balene spiaggiato! E come documenta la ricerca in materia, seguendo i lavori di Lee et al.24, gli errori possono, ugualmente, essere commessi anche da parti di esseri viventi. Sotto quest’aspetto, alcuni degli esempi più noti riguardano il DNA. Possono verificarsi vari errori nel processo di trascrizione genetica, traduzione e regolazione, che portano a cancro, disturbi genetici, problemi di sviluppo o altri problemi. È come accennato, un altro esempio, sarebbero gli anticorpi. A volte ci ammaliamo perché i nostri anticorpi vengono ingannati da patogeni mendaci che fingono di essere parte del nostro corpo. Ad esempio, il batterio della meningite. Neisseria meningitidis può imitare l’aspetto delle cellule del corpo e indurre una parte specifica del sistema immunitario a trattenersi erroneamente dall’attivarsi contro di esso, come documentano Schneider et al25.
Un altro rebus per il team di ricerca di Oderberg è se le caratteristiche degli errori siano condivise da tutti gli esseri viventi. In superficie, ragionano loro, c’è un abisso di differenza tra gli errori degli anticorpi e delle persone. Ma oltre alle differenze, si domandano, potrebbero esserci delle somiglianze? Al riguardo, ci propongono questa considerazione attinente a due errori: un anticorpo che identifica, erroneamente, un agente patogeno ed io, Vargas, che prendo, accidentalmente, il telefono cellulare di qualcun altro al bar, scambiandolo per il mio. Il loro ragionamento è che per svolgere il loro lavoro, gli anticorpi rispondono a ciò che i teorici degli errori chiamano “marcatori”, che sono stimoli all’azione, come segnali ma senza la connotazione psicologica. I marcatori possono assumere la forma di recettori o forme sulla superficie dell’agente patogeno, che ingannano gli anticorpi. Ma utilizziamo i marcatori anche nella nostra vita quotidiana. Quando prendo per errore il telefono sbagliato, sto rispondendo al colore, alla forma, alle dimensioni o alla posizione del telefono di qualcun altro che può essere simile al mio. Le persone e gli anticorpi si affidano ai marcatori per agire, perché nessuno dei due avrebbe effettivamente il tempo o l’energia per ispezionare attentamente l’intero bersaglio. Questa, segnalano, è un’area importante ma poco studiata fino allora nell’elaborazione della teoria degli errori. I ricercatori non comprendono ancora appieno questi marcatori di azione, ma, in ogni modo, attraverso di essi, spiegano, si possono iniziare a classificare le caratteristiche comuni degli errori biologici.

Le affermazioni della teoria degli errori in biologia
A questo punto, stando a Oderberg et al., la teoria degli errori inizierebbe a fare le sue affermazioni più audaci e sorprendenti, in particolare gli errori si commettono ovunque ci siano sistemi viventi. Oppure, sono una caratteristica universale della biologia. Il suo gruppo di ricerca sospetta che gli errori possano persino comparire tra le parti e i sottosistemi degli organismi. Ad esempio, si consideri una parte a cui il team di ricerca, seguendo i lavori di Tymoczko, Berg e Stryer: Biochemistry: A Short Course26, ha pensato molto: il sistema emostatico di coagulazione del sangue. La coagulazione del sangue costituisce un complesso percorso di attivazioni molecolari che coinvolge minuscoli frammenti cellulari a forma di disco nel nostro sangue chiamate piastrine. Sembra essere una questione altamente normativa. Se il processo inizia troppo tardi, un organismo ferito può morire dissanguato. Se inizia troppo presto, l’organismo può soffrire di una trombosi debilitante poiché i coaguli di sangue bloccano vene o arterie. Il processo deve avvenire nel punto giusto, il sito della lesione. La coagulazione deve terminare al momento giusto per le stesse ragioni. Le piastrine svolgono un ruolo cruciale in questo processo normativo.
Un altro esempio di come gli errori si commettono tra le parti e i sottosistemi degli organismi è quello relativo a quando i vasi sanguigni vengono danneggiati. A quel punto il collagene al loro interno viene esposto. Le piastrine del sangue si attivano quando vengono esposte a questo collagene in un sito di lesione. Tuttavia, le piastrine possono talvolta essere attivate dal collagene che appare senza la presenza di un vaso sanguigno danneggiato. Ciò può portare a trombosi, con conseguenze potenzialmente mortali per un organismo. E ci sono altri modi in cui le piastrine possono sbagliare: il coagulo che producono deve essere della giusta dimensione e forma per funzionare correttamente. La domanda che questa questione suscita è questa: – sebbene le piastrine possano potenzialmente sbagliare molte cose, sarebbe possibile che i sistemi di coagulazione del sangue commettano anche essi errori?
È conosciuto che le piastrine siano attivate da sequenze specifiche di amminoacidi all’interno del collagene chiamate triplette GPO. Per il teorico dell’errore, questo solleva immediatamente la questione se le triplette GPO siano presenti in altre proteine o se altre sequenze proteiche o modifiche post-traduzionali possano produrre marcatori molto simili alla GPO nel collagene. In una tale circostanza: – le piastrine del sangue potrebbero identificare erroneamente il collagene? Oppure, potrebbero persino essere attivate da un imitatore del collagene? Ciò può causare un’attivazione piastrinica errata, un’attivazione causata dalla proteina sbagliata, con conseguenze potenzialmente disastrose. Dunque, sulla questione se le piastrine possano essere ingannate, non si conosce ancora la risposta. Certo è che ci sono altre incognite.
Un altro esempio, che mostra gli usi della teoria dell’errore e la possibile profondità degli errori biologici, è il canto degli uccelli. Ogni fringuello zebra maschio ha un canto specifico che canta per corteggiare potenziali compagne e insegna questo canto poi alla sua prole maschio. C’è un margine di fluttuazione nel canto appreso: deve essere una riproduzione fedele, non una copia perfetta. Ciò significa che un vero errore si verifica solo se il canto appreso si discosta troppo da quello corretto. Ma, in questa teoresi quanto sarebbe troppo? Come imparano i fringuelli zebra a cantare il canto giusto?
La ricerca in materia indica che la dopamina viene rilasciata durante il canto del fringuello zebra per mantenere il suo canto alla giusta tonalità. Con questa conoscenza, la teoria dell’errore può offrire alcune ipotesi verificabili. Secondo definizione di Oderberg e il suo team, si commette un errore solo quando la partenza mina il prosperare [la fitness] di un fringuello. In questo caso, il prosperare è correlato all’attrazione dei compagni, che implica l’attrazione di un numero sufficiente di compagni giusti al momento giusto e così via, possibilmente per generazioni. Il prosperare non è semplicemente un gioco di numeri ma, per la maggior parte degli organismi, l’idoneità riproduttiva e il successo sono parte di ciò che significa che le loro vite vanno bene. Negli esperimenti, gli spikes nella dopamina dei fringuelli zebra sono correlati in tempo reale con le fluttuazioni nella qualità del canto, suggerendo che venga effettuata una sorta di valutazione. Gli uccelli, senza alcuna consapevolezza, sembrano giudicare o calibrare l’esecuzione del loro canto in base ai cambiamenti nei livelli di dopamina. Stanno rispondendo alla correttezza o scorrettezza del loro canto. L’uccello utilizza il feedback uditivo per adattare il suo canto, ma sembra che ci sia qualcos’altro in corso: una funzione valutativa svolta dagli stessi neuroni dopaminergici.
Stando al ragionamento del gruppo di Oderberg, Hill, Austin, Bojak, Cinotti & Gibbins, forse il sistema dopaminergico ha una rappresentazione della canzone corretta con cui viene confrontata la canzone effettiva, il che lascerebbe aperta la possibilità di sbagliare. In questo caso, gli errori compaiono anche tra i sistemi neurochimici. Questo sarebbe al limite di ciò che la ricerca avrebbe potuto suggerire, ma la teoria degli errori può stimolare un’indagine organizzata su tali fenomeni.
La teoria degli errori in biologia come euristica per progredire nella comprensione della vita stessa
La teoria degli errori biologici sembra essere una caratteristica universale della biologia, che demarca il vivente dai regni della fisica e della chimica, rendendolo, quindi, irriducibile a entrambi. Nonostante ciò, gli errori non sono ancora soggetti a indagini sistematiche da parte dei biologi. La teoria degli errori è un quadro entro cui generare ipotesi nuove e verificabili. E ci sono così tante domande che necessitano di indagini sistematiche: come possono andare male le cose in relazione a tempi, posizione, misurazione, valutazione della qualità e identificazione? Come cercano gli organismi di evitare gli errori? Quali errori sono inevitabili? Come vengono corretti? Come fa un organismo a monitorare, in tempo reale, se sta deviando su un percorso che minaccerà il suo prosperare? Tutte queste sono domande su cui Oderberg e il suo gruppo continuano ad indagare nel progetto Mistakes in Living Systems: A New Conceptual Framework for the Study of Purpose in Biology.
E poi ci sono domande sui casi contraddittori in cui gli errori paradossalmente aiutano un organismo a lungo termine, nonostante ne minaccino la prosperità a breve termine. Ciò è correlato al ruolo dell’esplorazione o del gioco nella vita. Gli organismi hanno generalmente bisogno di esplorare i loro ambienti, sia alla ricerca di cibo, di un compagno, di un riparo e così via. Tuttavia, troppa esplorazione si tradurrebbe in uno spreco pericoloso. Sarebbe un errore consentire troppi errori, ma alcuni sono necessari per prosperare nei nostri ambienti. In effetti, spiega Oderberg, gli errori nella copia del DNA, ad esempio, producono la variazione che guida la diversità della vita. Ma se questi errori variano troppo, i sistemi crollano. Interrogare questi errori sperimentalmente può dare agli studiosi una finestra sul fenomeno della normatività biologica, aiutandoli a capire come gli organismi agiscono correttamente o meno nei loro ambienti.
Gli errori in questa prospettiva non sono limitati agli organismi né vincolati alla scala. Gli errori possono essere commessi dai batteri più piccoli così come dagli animali più grandi, persino da intere popolazioni. Possono anche essere realizzati da non-organismi, come piastrine, anticorpi e cellule appartenenti a organismi. È l’ubiquità dell’errore, così come il suo potenziale, che richiede una teoria altrettanto ampia per organizzare l’indagine sul fenomeno.
La vita, unilateralmente e ufficialmente, è spesso definita da ciò che facciamo bene. È spiegata dalla crescita, dalla replicazione e dall’adattamento all’ambiente. Ma gli errori sono ovunque27. Una teoria degli errori aiuterebbe la nostra civiltà a comprendere, in modo sistematico, e guidato sperimentalmente, il comportamento che minaccerebbe il prosperare degli esseri viventi. Aiuterebbe le classi dirigenti altresì ad apprezzare e rafforzare la nozione di normatività che attraversa la vita. Mentre alcuni vedono ancora la “teleologia” con scetticismo, facendo un po’ di metafisica, la teoria degli errori potrebbe essere l’antidoto che sfida la saggezza convenzionale sugli obiettivi degli esseri viventi. Nell’intricata danza biologica del giusto e dello sbagliato, gli studiosi, metafisici o no, una teoria degli errori potrebbe aiutare a trovare la chiave per comprendere scopi profondi che guiderebbero, la vita sulla Terra.
- Oderberg, David; Hill, Jonathan; Austin, Christopher; Bojak, Ingo; Cinotti, François & Gibbins, Jon
- Oderberg, David; Hill, Jonathan; Austin, Christopher; Bojak, Ingo; Cinotti, François & Gibbins, Jon
- Supportato dal programma di ricerca globale della John Templeton Foundation Agency, Directionality, and Function.
- Bauer, W. D. and Mathesius, U. ‘Plant Responses to Bacterial Quorum Sensing Signals’, Current Opinion in Plant Biology, 7, pp. 429–33, 2004
- Ramamoorthy, H., Abraham, P. and Isaac, B. ‘Mitochondrial Dysfunction and Electron Transport Chain Complex Defect in a Rat Model of Tenofovir Disoproxil Fumarate Nephrotoxicity’, Journal of Biochemical and Molecular Toxicology, 28, pp. 246–55, 2014
- Crawford, A. L. [2020]: ‘Metaphor and Meaning in the Teleological Language of Biology’, Communications of the Blyth Institute, 2, pp. 5–24.
- Oderberg, David; Hill, Jonathan; Austin, Christopher; Bojak, Ingo; Cinotti, François & Gibbins, Jon
- Il Paramecium è un genere di protisti infusori. Nella classificazione tradizionale vengono considerati protozoi appartenenti alla classe dei ciliati, ordine degli oligotrichi, di cui sono i rappresentanti più tipici
- Shefrin, H., & Statman, M. The Contributions of Daniel Kahneman and Amos Tversky. Journal of Behavioral Finance, 4(2), 54–58, 2003 7
- Camille Morvan, William J. Jenkins. An Analysis of Amos Tversky and Daniel Kahneman’s Judgment under Uncertainty Heuristics and Biases. Macat Library, 2017
- Oderberg, David; Hill, Jonathan; Austin, Christopher; Bojak, Ingo; Cinotti, François & Gibbins, Jon
- Brandon, R. N. Adaptation and Environment, Princeton: Princeton University Press, 2014
- Qualsiasi concezione filosofica secondo la quale l’universo intero è organizzato in vista di un fine, sia che esso dipenda da una volontà divina o provvidenziale, sia che esso sia immanente alla natura, come principio attivo che mette in movimento la totalità del divenire.
- Menaker M. Colin S. Pittendrigh. Nature. 381(6577):24. May 2, 1996
- Okasha, S. [2018]: Agents and Goals in Evolution, Oxford: Oxford University Press.
- Nagel, Ernest. The Structure of Science: Problems in the Logic of Scientific Explanation. Harcourt, New York, 1961 / Ernest Nagel è stato un filosofo statunitense. Insieme a Rudolf Carnap, Hans Reichenbach e Carl Gustav Hempel, è una delle figure principali del positivismo logico. Il suo libro del 1961 The Structure of Science è considerato un lavoro fondamentale nella logica della spiegazione scientifica
- Heil, J. The Universe as We Find It, Oxford: Clarendon Press, 2012
- Sponsorizzato dal programma di ricerca globale della John Templeton Foundation Agency, Directionality, and Function.
- Brandon, R. N. Adaptation and Environment, Princeton: Princeton University Press, 2014
- Justin Garson. A Critical Overview of Biological Functions (Philosophy of Science). Springer, 2016
- Oderberg, David; Hill, Jonathan; Austin, Christopher; Bojak, Ingo; Cinotti, François & Gibbins, Jon. Supportato dal programma di ricerca globale della John Templeton Foundation Agency, Directionality, and Function.
- Matheson, J. and Griffiths, P. E.: ‘Biological Criteria of Disease: Four Ways of Going Wrong, The Journal of Medicine and Philosophy, 42, pp. 447–66, 2017
- Oderberg, David; Hill, Jonathan; Austin, Christopher; Bojak, Ingo; Cinotti, François & Gibbins, Jon. Mistakes in Living Systems: A New Conceptual Framework for the Study of Purpose in Biology. Supportato dal programma di ricerca globale della John Templeton Foundation Agency, Directionality, and Function.
- FLee, D. F., Lu, J., Chang, S., Loparo, J. J. and Xie, X. S. ‘Mapping DNA Polymerase Errors by Single-Molecule Sequencing’, Nucleic Acids Research, 44, 2016
- Schneider, M. C., Prosser, B. E., Caesar, J. J. E., Kugelberg, E., Li, S., Zhang, Q., Quoraishi, S., Lovett, J. E., Deane, J. E., Sim, R. B., Roversi, P., Johnson, S., Tang, C. M. and Lea, S. M. ‘Neisseria meningitidis Recruits Factor H Using Protein Mimicry of Host Carbohydrates’, Nature, 458, pp. 890–93, 2009
- Tymoczko, J. L., Berg, J. M. and Stryer, L. Biochemistry: A Short Course. W.H. Freeman, New York, , 2015
- Walsh, D. M. Organisms, Agency, and Evolution, Cambridge: Cambridge University Press, 2015








