BIO – Medicina Costruzione Sociale nella Post-Modernità – Educational Papers • Anno VIII • Numero 30 • Giugno 2019
La comprensione scientifica delle cellule sessuali e del processo del concepimento umano è uno sviluppo relativamente recente
Nonostante la convinzione diffusa che il “naturale” sia migliore quando si tratta di sesso, gravidanza e genitorialità, in molti di noi non abbiamo idea di cosa significhi “naturale” in realtà. In termini descrittivi anziché precettistici, le origini della nostra vita riproduttiva rimangono ancora un campo d’indagine piuttosto sconosciuto. Infatti, poco si può dire sul perché siano necessarie un quarto di miliardo di cellule spermatiche per fertilizzare un uovo. È ugualmente difficile rispondere, senza alcun dubbio, alla domanda se le femmine umane siano davvero fertili solo per pochi giorni al mese? A queste domande abbiamo risposto e continuiamo a rispondere con interpretazioni culturali che, confrontate con ciò che intendiamo possano essere i “fatti”, risultano quasi narrazioni mitologiche. Un tentativo recente di esaminare la storia procreativa degli umani, per aiutarci a capire meglio le nostre pratiche riproduttive, è quello fatto dal primatologo Robert D. Martin in “How We Do It: The Evolution and Future of Human Reproduction”1. Nella sua indagine Martin attinge a quarant’anni di ricerche per individuare le radici della nostra conoscenza riguardo la riproduzione umana, a partire dalle nostre cellule sessuali.
La nostra scarsa comprensione del naturale si manifesta in modo palese nella nostra nozione circa lo sperma del maschio, dominata, sostanzialmente, dal mito anziché da una reale conoscenza scientifica. Al riguardo, Robert D. Martin, sostiene che l’idea che milioni di spermatozoi siano in una corsa olimpica per raggiungere l’uovo della femmina è una fantasia culturale, privilegiata dai maschi, circa la riproduzione umana nella guerra tra i sessi.
Prima che la scienza facesse luce sulla riproduzione umana, la maggior parte delle persone pensava che una nuova vita umana sorgeva attraverso la generazione spontanea della materia non vivente. Ciò cambio leggermente a metà del diciassettesimo secolo, quando i filosofi naturali riuscirono (a malapena) a vedere l’ovulo2 femminile ad occhio nudo. Allora teorizzarono che tutta la vita umana fosse stata generata al momento di una creazione divina dell’universo. In questa teorizzazione una persona preesisteva all’interno delle uova di una femmina, come nell’insieme di bambole dell’artigianato russo. Tale visione della riproduzione, chiamata teoria della preformazione o, semplicemente, preformismo, si adattava bene al racconto della classe dominante. “Mettendo i lignaggi l’uno dentro l’altro”, osserva la biologa dello sviluppo Clara Pinto-Correia nel suo libro “The Ovary of Eve”3, “la preformazione poteva funzionare come una dottrina antidemocratica, politicamente corretta, che legittimava, implicitamente, il sistema dinastico. Per fortuna, o purtroppo, dipende dall’ideologia di appartenenza, sicuramente i principali filosofi della rivoluzione scientifica non erano servi”.
Si può pensare che mentre la scienza progrediva avrebbe distrutto la teoria della matrioska (bambola russa) attraverso la sua lucida lente biologica. Ma non è esattamente quello che è accaduto. Invece, quando il microscopio permise, finalmente, ai ricercatori di vedere non solo l’ovulo ma anche gli spermatozoi, la teoria della preformazione si è trasformata in una nuova presunzione politica di stampo patriarcale: ora, sostenevano filosofi e alcuni studenti della riproduzione, l’uovo era semplicemente un ricettacolo passivo in attesa dell’arrivo di uno spermatozoo vigoroso per innescare lo sviluppo. Per quanto riguarda lo sperma, l’interpretazione proposta asseriva che la testa di ogni spermatozoo contenesse un piccolo essere umano – un omuncolo, per utilizzare il termine della teoria. Il matematico e fisico Nicolaas Hartsoeker, inventore del microscopio a barilotto, disegnò la sua interpretazione dell’omuncolo quando gli spermatozoi sono stati resi visibili per la prima volta nel 1695. In realtà, egli non vide un omuncolo nella testa di uno spermatozoo, lo stesso Hartsoeker lo ammise in quel momento, ma si era convinto che non poteva essere che così.
Microscopi più potenti, alla fine, relegarono l’omuncolo alla pattumiera della storia ma, in qualche modo, non è cambiato molto. In particolare, l’eredità dell’omuncolo sopravvive nella nozione, ostinatamente persistente, dell’uovo come partecipante passivo alla fecondazione, in attesa dello spermatozoo, attivo, che nuota attraverso una tempesta di sfide per perpetuare la vita. È comprensibile, anche se sfortunato, che un pubblico non-esperto possa adottare questi paradigmi errati e queste metafore di stampo sessista. Ma il problema è che perfino medici e biologi ne fanno uso.
Fu nell’anno relativamente recente del 1991, molto tempo dopo che gran parte della scienza era stata “scolpita nella pietra” che l’antropologa Emily Martin, descrisse quella che lei definì una “fiaba scientifica” utilizzando una foto che suggeriva che “i processi biologici femminili erano meno degni delle loro controparti maschili.” L’ovaio, ad esempio, era raffigurato con un limitato stock di ovociti primari, impoverito nel corso di una vita, mentre i testicoli erano descritti come produttori di nuovi spermatozoi per tutta la vita. La produzione di ovociti umani è comunemente descritta come “dispendiosa” perché da 300.000 ovociti primari presenti alla pubertà, solo 400 ovociti maturi saranno semmai rilasciate4, tuttavia l’aggettivo “dispendioso” è usato raramente per descrivere la produzione di una vita di oltre 2 trilioni di spermatozoi. Sia nella letteratura popolare che scientifica, l’accoppiamento umano è comunemente rappresentato come una gigantesca maratona di nuoto in cui lo spermatozoo “più veloce e più adatto vince il premio” di fertilizzare l’ovocita. Questa narrativa, però, non è solo un superstite pregiudizievole del nostro passato sessista o una semplice fantasia maschile. Il continuo utilizzo di informazioni distorte impedisce trattamenti di fertilità per maschi e femmine.
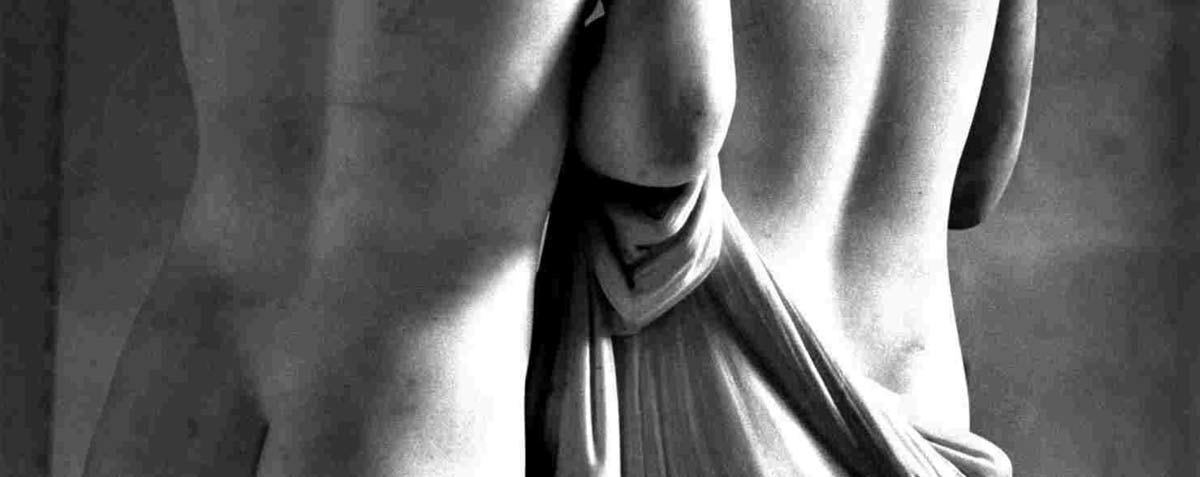
Un altro po’ di storia circa la comprensione scientifica delle cellule sessuali e del processo del concepimento umano
Per capire come siamo arrivati qui, un tour attraverso la storia può aiutare. Come precedentemente affermato, la comprensione scientifica delle cellule sessuali e del processo del concepimento umano è uno sviluppo relativamente recente. Un ovocita, la più grande cellula di un corpo umano, grosso come il punto che chiude questa frase, è a malapena visibile ad occhio nudo. Quindi, la più piccola cellula del corpo umano, uno spermatozoo, è completamente invisibile per l’occhio senza uno strumento di ingrandimento.
Lo spermatozoo era sconosciuto alla scienza fino al 1677, quando Antonie van Leeuwenhoek osservò, per la prima volta, lo sperma umano al microscopio. Intorno allo stesso tempo, ci si rese conto che l’ovaio umano produceva ovociti, anche se non fu fino al 1827 che il biologo Karl Ernst von Baer riferì per la prima volta osservazioni reali di ovociti umani e di altri mammiferi.
Dopo la documentazione o, se si preferisce, scoperta dello sperma di van Leeuwenhoek, ci volle un altro secolo prima che qualcuno si rendesse conto che esso era necessario per fecondare l’ovocita. Quella rilevazione avvenne nel 1760, quando il sacerdote e naturalista Lazzaro Spallanzani, sperimentando su rane maschi che indossavano pantaloni taffettà aderenti, dimostrò che le uova non si sarebbero trasformate in girini se lo sperma non fosse stato versato nell’acqua circostante. Stranamente, fino a quando Spallanzani non annunciò le sue scoperte, fu ampiamente pensato, anche dallo stesso van Leeuwenhoek, che gli spermatozoi fossero piccoli parassiti viventi nello sperma umano. Fu solo nel 1876 che lo zoologo Oscar Hertwig documentò la fusione spermatozoo & uova nei ricci di mare.
Alla fine, i potenti microscopi rivelarono che un eiaculato umano medio, con un volume di circa mezzo cucchiaino, contiene circa 250 milioni di spermatozoi. Ma una domanda chiave rimane senza risposta: “Perché così tanti?” In effetti, gli studi5 dimostrano che i tassi di gravidanza tendono a diminuire quando l’eiaculato di un maschio contiene meno di 100 milioni di spermatozoi.
Chiaramente, quindi, per la normale fertilità sono necessari quasi la metà degli spermatozoi in un eiaculato umano medio. La metafora popolarmente favorita per una spiegazione di questo è quella della “competizione spermatica”, derivante da quella nozione di spermatozoi in gara per fertilizzare – spesso con l’ulteriore affermazione che più di un maschio potrebbe essere coinvolto.
Esempi della cosiddetta “competizione spermatica” abbondano nel regno animale. I nostri parenti più stretti, gli scimpanzé, vivono in unità sociali che contengono diversi maschi adulti che si impegnano regolarmente in un accoppiamento promiscuo; le femmine a loro volta sono accoppiate da più maschi. Numerose caratteristiche, come i testicoli di notevoli dimensioni, riflettono un livello particolarmente elevato di produzione di sperma in tali specie di mammiferi. Oltre ai testicoli di grandi dimensioni, hanno una rapida produzione di spermatozoi, conteggi di spermatozoi elevati, midollo spermatico di grandi dimensioni (contenente numerosi mitocondri che generano energia per la propulsione), in particolare condotti muscolari di spermatozoi, grandi vescicole seminali e ghiandole prostatiche e alti livelli di cellule di sangue bianco (per neutralizzare i patogeni sessualmente trasmessi). Le vescicole e la ghiandola della prostata producono insieme il liquido seminale, che può coagularsi per formare un tappo nella vagina, bloccando, temporaneamente, l’accesso da parte di altri maschi.
L’opinione popolare e persino molti scienziati attribuiscono lo stesso scenario di competizione spermatica agli umani, ma i punti di prova segnalano una direzione diversa. In realtà, nonostante varie affermazioni in favore di questa interpretazione, non ci sono prove convincenti che i maschi siano biologicamente adatti alla presunta “competizione spermatica”. La storia dell’abbondanza di sperma negli scimpanzé che si accoppiano promiscuamente contrasta con ciò che vediamo in vari altri primati, inclusi gli umani. Molti primati vivono in gruppi con un solo maschio riproduttore dove manca la competizione diretta e hanno in particolare piccoli testicoli. In tutti i confronti rilevanti, gli umani emergono come affini ai primati che vivono in gruppi di soli maschi, compresa la tipica famiglia nucleare. I testicoli umani, a grandezza di noce, sono solo un terzo delle dimensioni dei testicoli degli scimpanzé, che hanno la grandezza simile alle uova delle galline. Inoltre, mentre l’eiaculato degli scimpanzé contiene pochi spermatozoi anormali, lo sperma umano contiene una grande percentuale di spermatozoi difettosi. I “controlli di qualità” sull’eiaculato umano sembrano essere stati allentati in assenza di una competizione spermatica diretta.
Per le specie non regolarmente esposte alla competizione diretta di spermatozoi, l’unica spiegazione plausibile alternativa per una ridondanza così alta di spermatozoi riguarda la variazione genetica. In un paio di articoli raramente citati, pubblicati più di quattro decenni fa, il biologo Jack Cohen dell’Università di Birmingham nel Regno Unito documentava un’associazione tra il numero di spermatozoi e la “generazione di copie cromosomiche” durante la produzione di spermatozoi. Durante la meiosi, il tipo speciale di divisione cellulare che produce cellule sessuali, “coppie di cromosomi” si scambiano frammenti di materiale. Quello che ha documentato Cohen è che, attraverso le specie, i conteggi di spermatozoi aumentano in tandem con il numero di crossover (scambi di geni) durante la loro produzione. Lo scambio di geni (crossing over) aumenta la variazione, la materia prima essenziale per la selezione naturale. In questo contesto possiamo immaginarci la produzione di spermatozoi come una sorta di lotteria in cui vengono stampati abbastanza biglietti (spermatozoi) per abbinare i numeri disponibili (diverse combinazioni genetiche).
Anche altri risultati della ricerca sfidano lo scenario popolare. Per esempio, la maggior parte degli spermatozoi di mammiferi non nuotano, invero, nell’intero tratto femminile, ma sono trasportati passivamente, in parte o quasi del tutto, attraverso movimenti di pompaggio e diffusione dell’utero e degli ovidotti. Sorprendentemente, lo sperma di piccoli mammiferi tende ad essere più lungo in media dello sperma di grandi mammiferi – uno spermatozoo di topo è più lungo dello spermatozoo di balena. Ma anche se questi fossero di dimensioni equivalenti, nuotare fino a un uovo comporta un tratto più lungo qualora aumenta la dimensione delle specie. Infatti, può essere possibile per uno spermatozoo di topo nuotare fino all’uovo – ma è abbastanza improbabile per uno spermatozoo di balena blu, ancora più piccolo, di nuotare 100 volte più in alto sul tratto femminile senza aiuto. Già negli anni ’90 la ricerca documentava che lo sperma umano viene trasportato passivamente su considerevoli distanze mentre viaggia attraverso l’utero e sopra gli ovidotti6.
Infatti, dei 250 milioni di spermatozoi nell’eiaculato umano medio, solo poche centinaia finiscono effettivamente nel sito di fertilizzazione in alto nell’ovidotto7. Volendo trovare una metafora più realistica si potrebbe dire che il passaggio degli spermatozoi è più simile a un impegnativo percorso a ostacoli militare anziché ad una gara di nuoto. I numeri di spermatozoi si riducono progressivamente mentre migrano lungo il tratto femminile, in modo che meno di uno su un milione dall’eiaculato originale circonda l’uovo al momento della fecondazione. Qualsiasi spermatozoo con anomalie fisiche viene progressivamente eliminato lungo il percorso, ma i sopravvissuti che circondano l’uovo sono un campione casuale di sperma intatto.
Come documenta Robert Martin nel suo articolo “The Macho Sperm Myth”, molti spermatozoi non arrivano nemmeno nel collo dell’utero (cervice). Le condizioni di acidità nella vagina sono ostili e lo spermatozoo non sopravvive a lungo. Passando attraverso la cervice, molti spermatozoi che sfuggono alla acidità nella vagina vengono irretiti nel muco. La maggior parte di quelli con deformità fisiche rimangono intrappolati. Inoltre, centinaia di migliaia di spermatozoi migrano in canali laterali, chiamati cripte, dove possono essere immagazzinati per diversi giorni. Relativamente pochi spermatozoi viaggiano direttamente attraverso la cavità uterina e il loro numero viene ridotto ulteriormente durante l’ingresso nell’ovidotto. Una volta nell’ovidotto, gli spermatozoi sono temporaneamente legati alla superficie interna e solo alcuni vengono rilasciati e lasciati avvicinare all’uovo.
Spingendo l’idea che lo “spermatozoo fertilizzante” fosse una specie di “campione olimpico” è stato oscurato il fatto che se gli spermatozoi circondano l’uovo in numero eccessivo, il rischio di fecondazione da più di uno, cioè la polispermia, si presenta con risultati catastrofici8. La polispermia si presenta occasionalmente, specialmente quando i padri hanno una conta spermatica molto alta. Nel risultato più comune in cui due spermatozoi fecondano un uovo, le cellule dell’embrione risultante contengono 69 cromosomi invece dei soliti 46. Questo è sempre fatale, di solito con esito di aborto. Sebbene alcuni individui sopravvivano fino alla nascita, muoiono sempre poco dopo. Poiché la polispermia ha in genere un esito fatale, l’evoluzione ha portato, si potrebbe postulare, a una serie di ostacoli nel tratto riproduttivo femminile che limitano, rigorosamente, il numero di spermatozoi autorizzati a circondare un uovo.
La polispermia ha implicazioni pratiche per la riproduzione assistita nei casi di fertilità o infertilità compromesse. Ad esempio, la procedura standard originale di introduzione dello sperma nella vagina per l’inseminazione artificiale è stata sostituita dall’iniezione diretta nell’utero (inseminazione intrauterina o IUI). L’introduzione diretta dello sperma nell’utero evita la riduzione dei numeri di spermatozoi che normalmente si verifica nella cervice, dove il muco elimina gli spermatozoi fisicamente anormali. Analisi di dati clinici hanno rivelato che il deposito di 20 milioni di spermatozoi nell’utero (meno di un decimo del numero nell’eiaculato medio) è sufficiente per raggiungere un tasso di gravidanza di routine.
Il numero di spermatozoi diventa ancora più importante quando si tratta di fecondazione in vitro (FIV), con esposizione diretta di un uovo a sperma in un contenitore di vetro. Questo aggira ogni singolo filtro naturale tra la vagina e l’uovo. Nello sviluppo iniziale della fecondazione in vitro, la tendenza generale era quella di usare troppi spermatozoi. Ciò rifletteva l’obiettivo comprensibile di massimizzare il successo della fecondazione, ma ignorava i processi naturali. Elevati numeri di spermatozoi tra i 50.000 e i 0,5 milioni diminuivano sempre più il tasso di successo. I tassi di fertilizzazione ottimale sono stati raggiunti con soli 25.000 spermatozoi intorno a un uovo. Sia l’IUI che l’IVF aumentano potenzialmente il rischio di polispermia e la probabilità di aborto spontaneo.
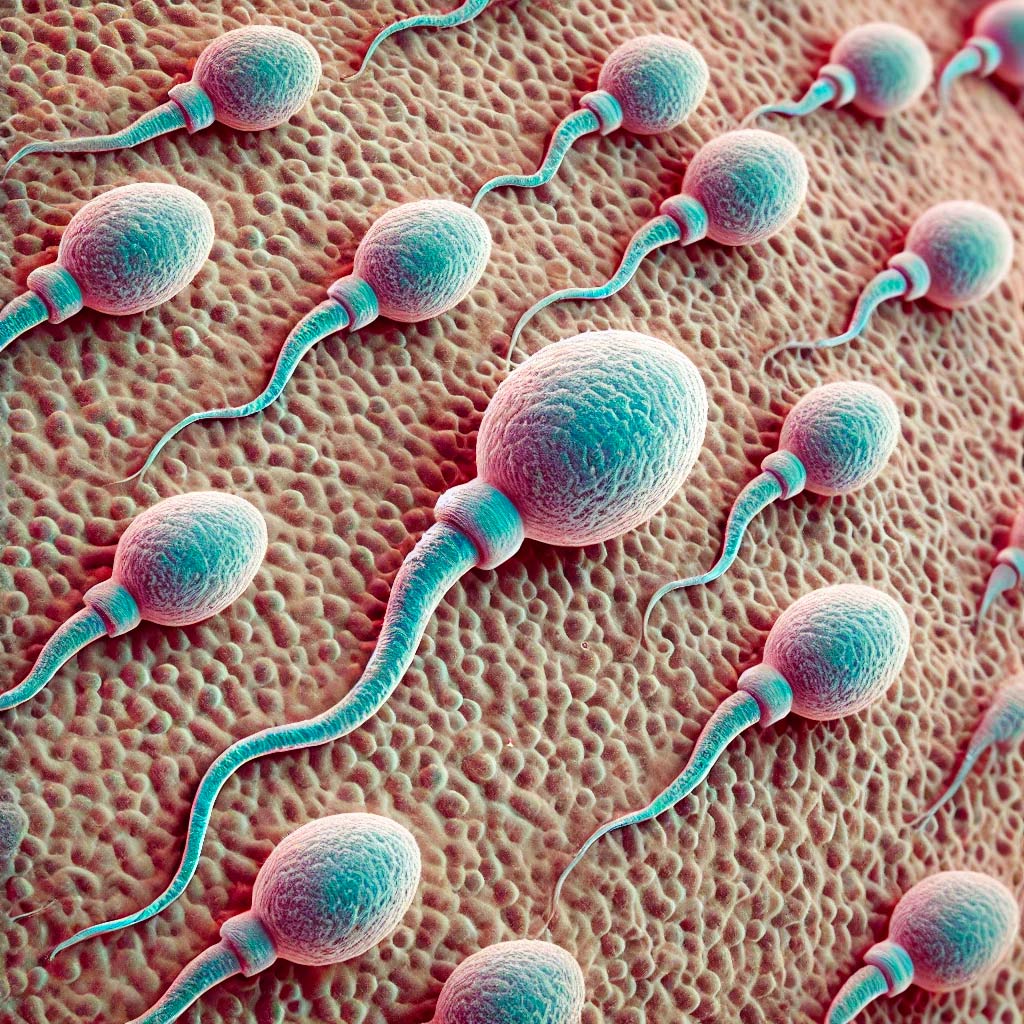
La fecondazione umana è come una gigantesca lotteria con 250 milioni di biglietti
La possibilità di polispermia getta nuova luce sull’evoluzione dei conteggi spermatici. Le discussioni sulla competizione spermatica si concentrano, in genere, esclusivamente sull’ottimizzazione del numero di spermatozoi, ma – come è comune in biologia – è implicata una sorta di compromesso. Mentre la selezione naturale può portare ad una maggiore produzione di sperma se i maschi sono in competizione diretta, favorirà anche meccanismi nel tratto femminile che limitano il numero di spermatozoi intorno all’uovo. Nei primati di accoppiamento promiscui, come gli scimpanzé, l’aumento della lunghezza dell’ovidotto nelle femmine compensa l’aumento della produzione di sperma da parte dei maschi. Questo, presumibilmente, limita il numero di spermatozoi che si avvicinano all’uovo. Mostra, anche, che il ruolo della femmina nella fertilizzazione non è affatto passivo come spesso si presume.
L’idea radicata che “il miglior seme vince” ha suscitato vari suggerimenti sul fatto che si verifichi una specie di “selezione” nella fecondazione, ma è difficile immaginare come ciò possa accadere. Il DNA nella testa di uno spermatozoo è strettamente legato e virtualmente cristallino, quindi come potrebbero essere rilevate le sue proprietà dall’esterno? Esperimenti sui topi indicano, ad esempio, che non esiste alcuna selezione in base al fatto che uno spermatozoo contenga un cromosoma Y determinante per il maschio o un cromosoma X determinante per la femmina9. Sembra molto più probabile che la fecondazione umana sia anch’essa una gigantesca lotteria con 250 milioni di biglietti, in cui, per uno spermatozoo sano, la fecondazione di successo sarebbe essenzialmente la fortuna del sorteggio.
Altre strane caratteristiche dello sperma attendono anche spiegazioni. È noto da tempo, ad esempio, che lo sperma umano contiene una grande percentuale di spermatozoi strutturalmente anormali con difetti evidenti come la doppia coda o le minuscole teste. L’ipotesi dello “sperma kamikaze” proponeva che questi spermatozoi in realtà servissero diverse funzioni nella cosiddetta competizione, come bloccare o addirittura uccidere lo sperma di altri uomini. Tuttavia, questo è stato, in effetti, efficacemente screditato10.
La radicata nozione che propone che lo spermatozoo umano, una volta eiaculato, si impegna in una frenetica corsa per raggiungere l’uovo ha completamente oscurato la reale storia della riproduzione, inclusa l’osservazione documentata che molti spermatozoi non si precipitano verso l’uovo ma sono invece immagazzinati per molti giorni prima di procedere. È stato a lungo accettato che lo sperma umano sopravvivesse per soli due giorni nel tratto genitale femminile. Tuttavia, a partire dalla metà degli anni ’70, prove crescenti rivelarono che lo sperma umano sopravviveva intatto per almeno cinque giorni. Un lungo periodo di sopravvivenza dello sperma è ora ampiamente accettato e si accetta che gli spermatozoi potrebbero durare anche 10 giorni o più.
Altri miti abbondano riguardo la riproduzione umana. Molto è stato scritto sul muco prodotto dalla cervice umana. Nei cosiddetti metodi “naturali” di controllo delle nascite, la consistenza del muco, che trasuda dalla cervice, è stata utilizzata come indicatore chiave. Vicino all’ovulazione, il muco cervicale è sottile e ha una consistenza acquosa e scivolosa. La relazione tra muco e deposito di sperma nella cervice è stata poco studiata. Infatti, la nostra conoscenza del processo coinvolto riguardo gli spermatozoi immagazzinati nelle cripte da cui score il muco è, purtroppo, limitata a un singolo studio riportato nel 1980 dal ginecologo Vaclav Insler e colleghi dell’Università di Tel Aviv.
In questo studio, 25 donne si sono offerte, volontariamente, per essere inseminate artificialmente il giorno prima della prevista rimozione chirurgica dell’utero (isterectomia). Poi, Insler e il suo team esaminarono microscopicamente lo sperma immagazzinato nelle cripte in sezioni seriali della cervice. Entro due ore dopo l’inseminazione, lo sperma colonizzava l’intera lunghezza della cervice. Le dimensioni delle cripte erano molto variabili e gli spermatozoi erano immagazzinati principalmente in quelle più grandi. Insler e colleghi hanno calcolato il numero di cripte contenenti spermatozoi e densità spermatica per cripta. In alcune donne, nelle cripte cervicali sono stati conservati fino a 200.000 spermatozoi.

Insler e colleghi hanno anche riferito che lo sperma vivo era stato effettivamente trovato nel muco cervicale fino al nono giorno dopo l’inseminazione. Riassumendo le prove disponibili, hanno suggerito che, dopo l’inseminazione, la cervice serve da serbatoio dello sperma da cui gli spermatozoi vitali vengono rilasciati gradualmente per risalire l’ovidotto. Questo risultato sconcertante è stato abbondantemente citato ma ampiamente ignorato, e non c’è mai stato uno studio di follow-up. Ad esempio, Sir Robert Edwards, vincitore del premio Nobel 2010 per lo sviluppo della FIV, nel suo libro di testo del 1980 Conception in the Human Female – più di 1.000 pagine di lunghezza – ha citato le cripte cervicali in una singola frase. Da allora, molti altri autori hanno menzionato lo stoccaggio degli spermatozoi in quelle cripte cervicali in modo altrettanto breve. Tuttavia, la conservazione dello sperma, con rilascio graduale, ha importanti implicazioni per la riproduzione umana. Fondamentalmente, la nozione diffusa di una “finestra fertile” ristretta nel ciclo mestruale dipende dalla credenza, a lungo accettata, che lo sperma sopravvivesse solo due giorni dopo essere versato nella vagina. La sopravvivenza degli spermatozoi forse per 10 giorni o più erode radicalmente la base per i cosiddetti metodi “naturali” di controllo delle nascite. L’immagazzinamento dello sperma è anche direttamente rilevante per i tentativi di trattare l’infertilità.
Un altro fraintendimento che falsa la realtà è la credenza secondo cui i maschi conservano la piena fertilità nella vecchiaia, in netto contrasto con la brusca cessazione della fertilità osservata nelle femmine in menopausa. Prove abbondanti dimostrano che, nei maschi, il numero di spermatozoi e la qualità diminuiscono con l’aumentare dell’età. Inoltre, recentemente è emerso che le mutazioni si accumulano circa quattro volte più velocemente nello sperma rispetto alle uova, quindi lo sperma dei maschi vecchi è, in realtà, pieno di rischi.
Molto è stato scritto sul fatto che nelle società industrializzate l’età in cui avviene la riproduzione nelle femmine è in aumento, accompagnata da lenti ma crescenti problemi riproduttivi. Una soluzione proposta è la procedura invasiva e costosa di “conservazione della fertilità” in cui le uova vengono raccolte dalle giovani femmine per l’uso più tardi nella loro vita. Tuttavia, l’aumento dei problemi riproduttivi dei maschi non più giovani, in particolare l’accumulo più rapido di mutazioni spermatiche, è passato in gran parte non menzionato. Un modo efficace meno costoso e meno invasivo di ridurre i problemi riproduttivi per le coppie in età avanzata sarebbe quello di immagazzinare anche campioni di sperma dai maschi giovani da utilizzare più tardi nella vita. Questo sarebbe solo uno dei benefici che si otterrebbero da un minor sessismo creazionista e da una conoscenza più affidabile nel campo della riproduzione umana, secondo alcuni studiosi della questione come riporta Martin nel suo articolo “The Macho Sperm Myth”.
Al giorno d’oggi, la storia dell’omuncolo di Hartsoeker può sembrare velata nella nebbia del tempo, menzionata solo come un’illustrazione divertente di errori grossolani nella prima esplorazione delle cellule sessuali umane. Ma la sua influenza, insieme al pregiudizio che lo ha generato, ha vissuto in forma più sottile tra gli stereotipi culturali che influenzano le domande che ci poniamo sulla biologia riproduttiva, lasciandoci, di conseguenza, con una scarsa comprensione scientifica delle cellule sessuali e del processo del concepimento umano.
- Robert D. Martin. How We Do It: The Evolution and Future of Human Reproduction. Basic Books, New York, 2013
- L’ovulo, cellula uovo, o ovocita secondario è il gamete femminile prodotto dal sistema riproduttivo femminile. Deriva dall’ovocita primario, la cellula uovo in uno stadio di maturazione non completo. La cellula uovo tipicamente non è capace di compiere movimenti attivi ed è – rispetto al gamete maschile – una cellula di grandi dimensioni, ricca di nutrienti. La funzione della grande quantità di nutrienti contenuti nell’ovulo è quella di fornire l’energia necessaria per far sopravvivere e crescere lo zigote dopo la fecondazione prima che il gamete fecondato si sia impiantato nell’utero.
- Clara Pinto-Correia. The Ovary of Eve. Egg and Sperm and Preformation. University of Chicago Press, Chicago, 1997
- Nel 5º mese di vita fetale si raggiunge una produzione di 6-7 milioni di ovociti primari (diploidi), prodotti dalle ovaie; molti di questi ovociti muoiono nel giro di pochi mesi e alla nascita ne rimangono in vita circa 2 milioni, diminuendo a 30-40.000 nella fase della pubertà. La donna sessualmente fertile matura uno degli ovociti primari ogni 28 giorni circa (ciclo mestruale), completando la prima divisione meiotica che fino a quel momento resta bloccata in Profase I o Dictiotene, ottenendo così un ovocita secondario. Solo nel caso in cui la fecondazione dell’ovocita secondario avvenga, questo compirà anche la seconda divisione meiotica, ottenendo così un ootide (aploide) ed infine un ovulo (il gamete femminile). Si stima che nell’arco della vita dell’individuo, solo 300-500 ovociti primari giungono a maturazione completa senza degenerare
- R. Slama, F. Eustache, B. Ducot, T. K. Jensen, N, J.rgensen, A. Horte, S. Irvine, J. Suominen, A. G. Andersen, J. Auger, M. Vierula, J. Toppari, A.N. Andersen, N. Keiding, N. E. Skakkebaek, A. Spira & P. Jouannet. Time to pregnancy and semen parameters: a cross-sectional study among fertile couples from four European cities. In “Human Reproduction”, Vol. 17, Issue 2, 1 February 2002, Pages 503–515
- T. Steck, W. Würfel W. Becker P. J. Albert. Serial scintigraphic imaging for visualization of passive transport processes in the human Fallopian tube. In “Human Reproduction”, Vol 6, Issue 9, 1 October 1991, Pages 1186–1191
- Suarez SS., Pacey AA. Sperm transport in the female reproductive tract. In “Human reproduction update”, 2006 Jan-Feb. 12 (1): 23-37
- Allison J Gardner, Carmen J Williams & Janice P Evans. Establishment of the mammalian membrane block to polyspermy: evidence for calcium-dependent and -independent regulation. In “Reproduction”, Vol. 133, Issue 2, pages 383-393, 2007
- Maurizio Zuccotti, Vittorio Sebastiano, Silvia Garagna & Carlo Alberto Redi. Experimental demonstration that mammalian ovocytes are not selective towards X- or Y-bearing sperm. In “Gamete Biology”, 24 March 2005
- H D Moore, M Martin & T R Birkhead. No evidence for killer sperm or other selective interactions between human spermatozoa in ejaculates of different males in vitro. In “Proceedings of the Royal Society B Biological Sciences”, 1999 Dec 7, 266(1436): 2343-2350









2 commenti
sergio
Bellissimo approfondimento. Ha toccato numerosi punti anche oscuri.. Ma la cosa più rilevante che ho letto è il tema della narrazione storica. Il fatto introiettato e proposto dal mondo scientifico accademico che la fecondazione sia un evento competitivo in cui lo spermatozoo veloce nuotatore più attrezzato ecc vinca, sta perdendo consistenza (neanche Woody Allen ci credeva veramente).
La questione in effetti non è chiara e anche la faccenda della lotteria sembra teorica, mentre a fronte di una narrazione storica pregiudizievole come si sa , l’elemento femminile accettore-selezionatore-decisore sembra prendere importanza. Così come l’idea che viene proposta in tutti i testi di biologia ecc che sia il maschile che determini il, sesso del nascituro. Ovvero che sia incontestabilmente il, cromosoma Y che determini il sesso del nascituro, idea che non tiene conto della componente selezionatrice che è indubbiamente quella femminile (tra l’altro l’Y è pure monco).
Generiamosalute
Grazie dott. Segantini, anche a noi è parso uno dei più interessanti, tra i tanti, pubblicati nella rubrica della rivista BIO.
I commenti sono chiusi.