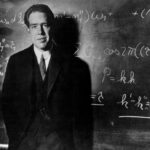Kohei Saito è un filosofo giapponese, nato nel 1987, autore di un testo, uscito nel 2020, intitolato Capital in the Antropocene.
Saito prende molto sul serio la minaccia di una catastrofe ambientale, e la collega strettamente con la globalizzazione del capitalismo. In un’analisi che rende insolitamente attuali alcune riflessioni di Marx sul capitalismo.
Il rapporto che per sua natura il capitalismo instaura tra centro e periferia sta portando questo sistema al collasso: il Nord del mondo sfrutta la forza lavoro del Sud del mondo, ma tutto il sistema capitalista sfrutta l’ambiente. “Oggetto dello sfruttamento capitalista non è solo la forza lavoro delle periferie, ma la Terra nel suo insieme.”
Il capitalismo nell’Antropocene
Quello che già fu chiamato imperialismo come fase suprema del capitalismo, prolunga i suoi effetti negativi fino ad oggi. “Il modello di vita imperiale viene perpetuamente riprodotto attraverso la nostra quotidianità. La sua violenza, però, esercitandosi in luoghi lontani, ci risulta sempre invisibile.” Ed il greenwashing, quell’idea elaborata dal capitalismo stesso che fa dell’ecocompatibilità un argomento del marketing, è solamente ingannevole.
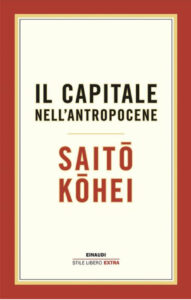 L’ecosostenibilità non affronta la radice del problema. “Per quanto il capitalismo possa sembrare in ottima forma, la Terra pone comunque dei limiti.”
L’ecosostenibilità non affronta la radice del problema. “Per quanto il capitalismo possa sembrare in ottima forma, la Terra pone comunque dei limiti.”
Saito cita l’economista Kennet E. Boulding: “Chi crede a una crescita esponenziale infinita in un mondo dalle risorse limitate o è fuori di testa, o è un economista, o è tutti e due”.
“Il capitalismo dirotta altrove le sue contraddizioni e le rende invisibili”: questo aveva già detto Marx del capitalismo, preconizzando il suo crollo. Il capitalismo non è crollato, ma anzi, a partire dalla fine della guerra fredda, lo sfruttamento scriteriato delle risorse ambientali ha avuto un’impennata.
La traslazione delle contraddizioni è una strategia del capitalismo. E tentare di risolvere la crisi ambientale attraverso lo sviluppo tecnologico è una forma di traslazione. “La traslazione tecnologica non risolve i problemi. Al contrario, l’uso sconsiderato della tecnologia non fa che aggravare le contraddizioni in essere.”
Il capitalismo è sempre in lotta contro la caduta del saggio di profitto: ma dall’esito di questa lotta dipende non tanto e non solo la fine del capitalismo, ma la fine della vita stessa sul pianeta Terra.
Altri segnali da cogliere sono le rivolte sociali legate alla crisi climatica, come indicato dall’aumentare dei profughi ambientali. “Cambiamenti climatici e profughi ambientali danno corpo e sostanza alle contraddizioni del modello di vita imperiale, fino a oggi invisibili agli occhi dei paesi sviluppati, rischiando di ribaltare l’ordine costituito.”
Prima che quella del capitalismo, si profila una grave crisi della democrazia. “La crisi alimentare, quella energetica, il problema dei profughi, sono tutti argomenti capaci di nutrire un nazionalismo fondato sull’esclusione. Cosí si creano divisioni all’interno della società, aggravando la crisi della democrazia.”
Il bivio
“Il bivio che porta alla fine del capitalismo è ora, di fronte a noi”.
Dalla crisi che stiamo vivendo è possibile uscire con una soluzione simile a quella pensata da Keynes per la più grande crisi del secolo scorso? Se ne può uscire, secondo un modello keynesiano applicato al clima, incoraggiando nuovi investimenti compatibili con scelte ecologiche? “Il Green New Deal può davvero salvare l’umanità nell’epoca dell’Antropocene?”
Possiamo pensare nei termini di uno sviluppo sostenibile, o non richiede forse il limite dello sfruttamento delle risorse soluzioni più drastiche e radicali?
Secondo Saito pensare ad una crescita economica che sia in grado tuttavia di diminuire le emissioni di anidride carbonica è un’illusione, dettata dalla coazione intrinseca del capitalismo alla produttività, una sorta di trappola della produttività. C’è piuttosto un’ecosostenibilità di facciata dei paesi più sviluppati, che fa ricadere l’aumento delle emissioni globali di anidride carbonica sulla periferia del sistema, su paesi in via di sviluppo.
L’inganno è ancora più sottile, secondo Saito. “Le energie rinnovabili non vengono consumate al posto dei combustibili fossili, ma si aggiungono a essi, integrandoli”, ed ingenerando complessivamente una ulteriore propensione al consumo non sostenibile. Neanche cercare di rendere le energie sostenibili più vantaggiose di quelle inquinanti è una soluzione, perché è in generale il mercato a non essere una soluzione affidabile.
Per esempio: incentivare le auto elettriche significa incentivare la produzione delle batterie al litio, per aumentare la cui produzione occorrono grandi quantitativi di metalli rari, la cui estrazione diviene una nuova e differente minaccia all’ecosistema.
Pure l’ipotesi delle Tecnologie ad Emissione Negativa, che siano cioè in grado di eliminare l’anidride carbonica prodotta dall’atmosfera, sono un’illusione della trappola della produttività, una finta soluzione. Si userebbero ulteriori risorse naturali (introducendo energia derivata dalle biomasse e/o catturando l’anidride carbonica e immagazzinandola sotto terra o nei mari), con relativo danno ambientale, per poter continuare ad usare combustibili fossili.
Neanche la cosiddetta smaterializzazione dell’economia è una soluzione, poiché i servizi e le nuove tecnologie digitali inducono comunque nuovi consumi ed un aumento dello sfruttamento delle risorse naturali.
La Decrescita come scelta possibile
“Il modello di sviluppo centrato sulla crescita economica sta ormai arrivando al termine.” Non che non bisogni fare in modo che crescano le parti del mondo a cui manca acqua, nutrimento, elettricità, educazione; ma proprio l’economia globale dovrebbe darsi nuovi obiettivi. Una società equa e sostenibile deve tener conto dei planetary boundaries, del tetto limite dell’ambiente. Il punto è che il capitalismo non è in grado di realizzare un’equità globale.
“Una volta oltrepassata una certa soglia, non c’è piú alcuna correlazione evidente tra crescita economica e miglioramento delle condizioni di vita delle persone.” All’interno del capitalismo una decrescita non è possibile; ed il suo modello di crescita è una condizione del persistere delle diseguaglianze e della povertà.
Saito riprende Slavoj Zizek nella sua critica alla efficacia di soluzioni edulcorate, come quella del premio Nobel per l’Economia Joseph Stiglitz. Si tratta, come appunto già detto da Zizek, della illusione che possa esserci un capitalismo progressista, in cui una equa politica salariale e fiscale e di lotta ai monopoli possa di nuovo rendere il mercato come regolatore di un capitalismo equo. La riforma invocata da Stiglitz è incompatibile con l’esistenza del capitalismo in sé. Una decrescita interna al capitalismo è impossibile.
Bisognerebbe invece fare delle scelte, politiche e non di mercato. “Ciò che va ridotto sono i Suv e la carne di manzo, è la fast fashion, non certo l’educazione e l’assistenza sociale, e men che mai l’arte.” “La decrescita punta a uguaglianza e sostenibilità. Al contrario, una lunga stagnazione del capitalismo porta disuguaglianza e povertà, oltre a inasprire la competizione tra singoli esseri umani.”
“È qui che emerge finalmente la necessità di unire Karl Marx e decrescita.”
Marx nell’Antropocene
Va secondo Saito rivalutata un’idea che Marx aveva del comunismo: quella di un bene comune da gestire non secondo i criteri del profitto privato ma secondo quelli di una tutela pubblica. Beni come l’acqua, l’elettricità, l’abitazione, l’educazione: in una concezione che dal semplice welfare si allarga alla tutela dell’ambiente e della Terra come bene comune.
La nuova edizione di appunti inediti che Marx scrisse negli anni successivi alla pubblicazione de Il Capitale getta inoltre nuova luce sulle sue riflessioni non riducibili alla vulgata marxista. Al Marx comunque fautore dello sviluppo produttivo come il motore necessario a vincere le stesse contraddizioni del processo capitalistico, si affianca e si sostituisce un Marx attento a che il lavoro ripristini un equilibrio nel rapporto tra l’uomo e la natura.
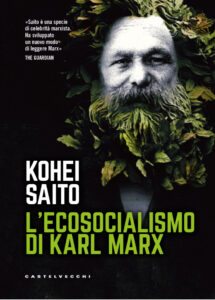 La produzione non viene più considerata da Marx come una priorità irrinunciabile, la stessa visione progressiva della storia e di un progresso trainato dall’Europa viene da lui messa in discussione. La sostenibilità, nell’elogio dell’economia stazionaria di alcune comunità premoderne, sembra invece diventare la nuova leva del raggiungimento di un’eguaglianza sociale.
La produzione non viene più considerata da Marx come una priorità irrinunciabile, la stessa visione progressiva della storia e di un progresso trainato dall’Europa viene da lui messa in discussione. La sostenibilità, nell’elogio dell’economia stazionaria di alcune comunità premoderne, sembra invece diventare la nuova leva del raggiungimento di un’eguaglianza sociale.
È in questo senso che va riletta la formula dell’utopia a cui allude Marx ne La Critica al Programma di Gotha: “ognuno secondo le sue capacità, a ognuno secondo i suoi bisogni”.
In un’epoca di crisi climatica c’è bisogno di un comunismo della decrescita.
Il capitalismo è decollato grazie allo smantellamento dei beni comuni, creando sviluppo a scapito di una maggiore scarsità dei beni primari comuni. La ricchezza privata incentivata dal capitalismo riduce però la prosperità pubblica.
Finalmente il cambio di paradigma auspicato da Saito si compendia in una nuova formulazione utopistica del comunismo: un’economia dell’abbondanza creata dal comunismo della decrescita. All’austerità che freni uno scambio fine a se stesso di merci, corrisponderebbe una nuova ricchezza del valore d’uso dei nostri beni comuni.
“Mettere la parola fine al capitalismo e ricreare un’abbondanza radicale. Ciò che ci attende dopo sarà una condizione di libertà.” Così Saito completa il suo recupero dell’utopia di Marx. “Marx distingue tra «regno della necessità» e «regno della libertà». Il primo è essenzialmente l’ambito delle attività di produzione e consumo necessarie per la sopravvivenza. Il secondo invece è l’ambito richiesto per svolgere attività umane non necessarie alla sopravvivenza ma che sono proprie dell’uomo. Parliamo di arte, cultura, amicizia, amore o sport.”
Per non far finire la storia
Il comunismo è una ragionevole alternatava alla barbarie. Saito annuncia in toni trionfalistici che il comunismo della decrescita salverà il mondo. Questa volta anche come recupero della democrazia delle decisioni importanti, di forme di autogestione e cogestione. La barbarie è invece rappresentata da due estremi di statalismo e populismo: il fascismo climatico, “in cui si costruiscono muri, i rifugiati ambientali vengono espulsi e la geoingegneria riesce a proteggere solo alcune persone”; ovvero il maoismo climatico, “in cui lo Stato tiene minuziosamente sotto controllo e punisce sistematicamente le emissioni di anidride carbonica delle imprese e dei singoli individui”.
Saito rilegge alcune pagine del Capitale alla luce delle successive riflessioni dello stesso Marx su un nuovo rapporto necessario tra la produzione ed i cicli della natura. Per un comunismo della decrescita occorre perciò: il passaggio ad un’economia del valore d’uso; ridurre l’orario di lavoro, migliorare la qualità della vita; riportare creatività sul luogo di lavoro; democratizzare il processo produttivo e rallentare l’economia; valorizzare i lavori essenziali, come quelli di assistenza e di cura.
L’utopia è dunque di nuovo quella di Marx: analizzare il capitalismo per evidenziare come le sue stesse contraddizioni interne dovrebbero portare ad un nuovo umanismo. “Se le persone riusciranno a unire le forze e a solidarizzare per difendere questa nostra unica casa che è il pianeta Terra, sarà giusto tornare a chiamare questa nuova èra Antropocene, stavolta in senso positivo.”