BIO – Medicina Costruzione Sociale nella Post-Modernità – Educational Papers • Anno XIV • Numero 55 • Settembre 2025
I nostri mondi mentali sono pieni di esperienze di assenza
Studiando la percezione dell’assenza, anche da una prospettiva amatoriale, riusciamo a cogliere qualcosa che potrebbe sembrare banale ma che, invece, riveste somma importanza circa la nostra cognizione del mondo in cui viviamo. L’evento che può sconcertarci è il venir a conoscenza del fatto che ci sono voluti secoli perché le élite e, innanzitutto, le loro popolazioni subalterne accettassero lo zero, che indica la cardinalità dell’insieme vuoto.1 Ora, però, l’idea dello zero sta perfino aiutando i neuroscienziati a capire come il cervello percepisce le assenze. La questione, perfino fuori del dibattito accademico erudito, non è banale se si pensa che l’assenza comporta una mancata presenza di un qualcosa che abitualmente dovrebbe trovarsi in un certo luogo.
Quest’esperienza un po’ imbarazzante la si capisce meglio con un esempio. Chiunque faccia bird-watching, avrà attraversato, quasi sicuramente, un’esperienza particolare e fin troppo frequente. Nel silenzio, qualche compagno ti indica la volta degli alberi e ti bisbiglia se riesci a vedere un uccello nascosto tra le foglie. Scruti le cime degli alberi con il tuo binocolo ma, con grande disappunto di tutti, vedi solo l’assenza di un uccello.Tuttavia, quest’esperienza, secondo gli studiosi, rientra, semplicemente, nella normalità.
In effetti, stando a quanto riferisce il ricercatore Benji Barn, del Dipartimento di Neuroscienze per Imaging dell’University College di Londra, i nostri mondi mentali sarebbero pieni di queste esperienze di assenza, ed è un evento ancora inspiegabile come la mente riesca a mettere in atto il trucco di non vedere nulla. Come può il cervello percepire qualcosa quando non c’è nulla da percepire?
Per un neuroscienziato, come Benji Barnett, interessato alla coscienza, quest’ultima costituisce una domanda affascinante. Studiare le basi neurali del nulla, tuttavia, pone sfide non evidenti per chi non è istruito in materia. Fortunatamente, esistono altri tipi di assenze, più tangibili, che ci aiutano a comprendere la nebulosa questione del nulla nel cervello. Ecco perché Barnett ha dedicato gran parte della sua ricerca a studiare come percepiamo il numero zero.
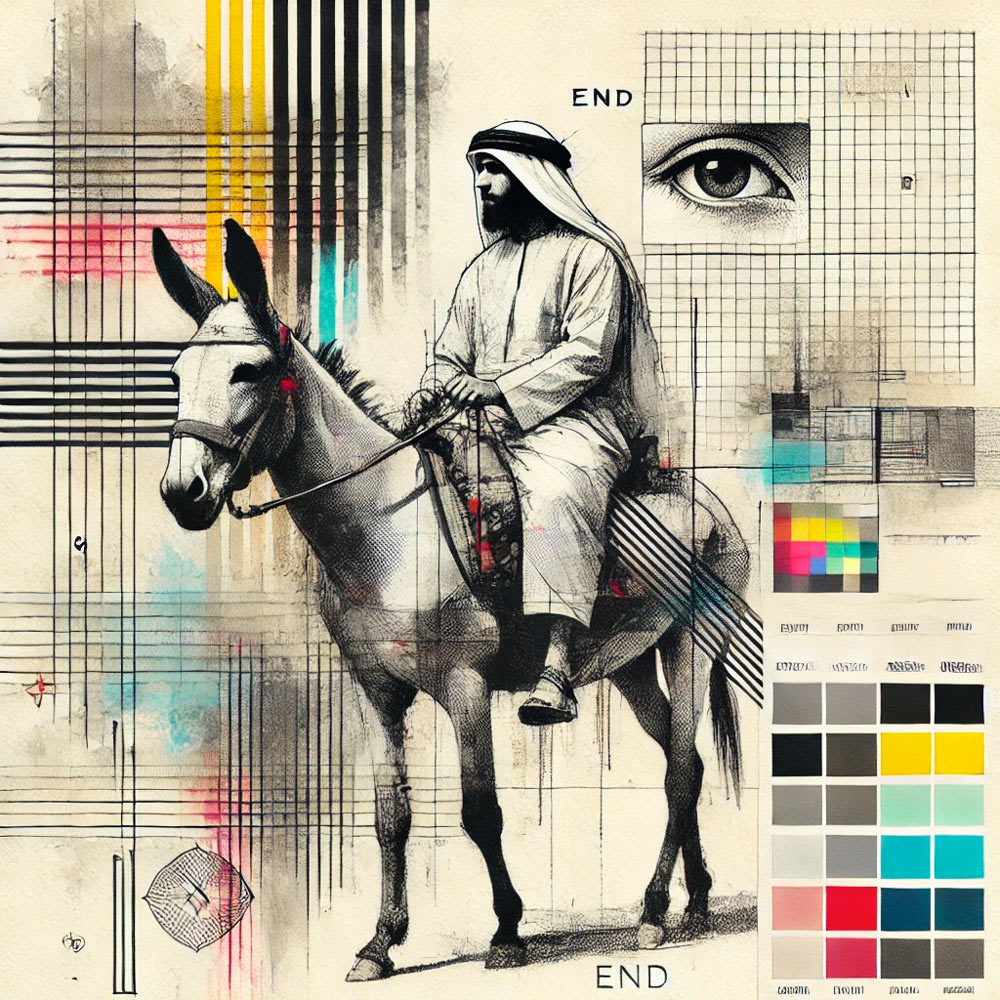
Come percepiamo il numero zero? Le basi neuronali del nulla!
Prima, però, di affrontare con un’euristica specialistica la risposta a tale questione, si deve fare qualche accenno storico al percorso dello zero nella nostra cultura attorno al 1200. Stando a Barnett,2 lo zero avrebbe svolto, perfino, un ruolo intrigante nello sviluppo delle nostre società. Il corso dell’evoluzione della specie e della storia umana, documa che il numero zero ha arrancato in civiltà timorose del nulla e, invece, prosperato in quelle che lo avrebbero accolto. Ma, non è questa l’unica ragione per cui lo zero risulti così affascinante.
In sorprendente somiglianza con la percezione dell’assenza, anche la rappresentazione dello zero come numero nel cervello umano rimane poco chiara, sostiene Barnett.3 Sotto questo aspetto, lui ci introduce nella questione dell’importanza dello zero con una domanda scolastica che destruttura i nostri limiti cognitivi. La sua domanda è: se il cervello umano ha meccanismi specializzati che si sono evoluti per contare, diciamo, i gufi appollaiati su un ramo, come fa questo sistema ad astrarsi da ciò che è visibile e a segnalare che non ci sono gufi da contare?
Per ricercatori della qualità di Barnett,4 l’evento inspiegabile che accomuna la percezione delle assenze e la concezione dello zero potrebbe non essere casuale. Nella sua interpretazione, quando nell’evoluzione umana il cervello arriva a riconoscere lo zero, puòe attivare meccanismi sensoriali fondamentali che regolano quando si può, o non si può, vedere qualcosa. Aggiungendo, per di più, che se così fosse, le teorie della coscienza che enfatizzano l’esperienza dell’assenza potrebbero trovare un nuovo utilizzo per lo zero, come strumento per esplorare la natura stessa della coscienza.
La ritardata adozione dello zero nel corso della storia
Nell’euristica presentata da Barnett, lo zero, fino a dove si è riusciti a documentare, ha avuto origine da un’impronta su argilla umida. La narrativa al riguardo propone che circa 5.000 anni fa, in Mesopotamia, i Sumeri abbiano ideato un metodo rivoluzionario per la scrittura dei numeri. Invece di inventare nuovi simboli per numeri in continua crescita, progettarono un sistema in cui la posizione di un simbolo all’interno di un numero sarebbe stato corrispettivo al valore di quel simbolo. Stando a Barnett,5 se questo ci sembra confuso, è probabilmente perché l’idea risulta così familiare che viene offuscata dalla sua spiegazione. Al riguardo, si considerino i numeri 407 e 47.Entrambi contengono un “4”, ma in ciascuno di essi “4” rappresenta valori diversi (rispettivamente 400 e 40). Il modo in cui interpretiamo, correttamente, questo simbolo è in base alla colonna in cui si trova all’interno del suo numero (ad esempio, le centinaia o le decine). Sebbene questo ci possa sembrare un semplice cambiamento di formato, le conseguenze di tale notazione posizionale furono enormi. Consentiva, ci fa notare Barnett, la registrazione rapida di numeri grandi in metodi di calcolo semplici.
Stando alla sua analisi, a un certo punto, sarebbe emerso, però, un problema: cosa dovevano fare i Sumeri quando una particolare colonna non conteneva alcun numero, come nel caso del numero 407? Fu qui, stando all’euristica in materia, che nacque lo zero: i Sumeri posizionarono un cuneo diagonale tra due numeri per indicare “niente in questo posto”.6
Nonostante il potere conferito dalla notazione posizionale e da un simbolo matematico per il nulla, il nulla o zero incontrò resistenza e persino derisione durante la sua diffusione fuori dal Medio Oriente. Le civiltà greche lasciarono poche testimonianze relative all’uso dello zero e mantennero l’uso di un sistema numerico non posizionale, molto simile ai numeri romani. In effetti, l’aristocrazia greca – coloro che studiavano i sistemi matematici – attivamente evitò l’uso dello zero, racconta Barnett. Ugualmente, ci riferisce, la Grecia era una terra di geometria e i suoi studiosi cercavano di descrivere il mondo usando linee, punti e angoli. Il concetto di “nulla” non aveva una collocazione ovvia. Per di più, il loro amore per la logica era altrettanto ostruzionistico: come poteva il nulla essere qualcosa? Aristotele concluse che il nulla stesso non esisteva – non poteva esistere. Sant’Agostino lo equiparava al diavolo: il nulla era il male più grande.
Tuttavia, ci segnala la ricerca di Barnett,7 l’utilità della notazione posizionale per i commercianti aiutò lo zero a insinuarsi nell’indifferenza di coloro che lo rifiutavano. Per questo motivo, furono le classi lavoratrici a controllare il destino dello zero, trasportandolo da Babilonia all’India attraverso le rotte commerciali intorno al III secolo a.C.
Secondo la documentazione e punto di vista di Barnett,8 a differenza dei logici greci, il nulla era intessuto nei fondamenti filosofici della cultura indiana. La varietà di parole che gli indiani usavano per “nulla” in diversi contesti (come l’immensità dello spazio, l’etere o il vuoto) descrive un sistema filosofico indiano che considerava il “nulla” come una cosa descrivibile in sé, non semplicemente come l’assenza di qualcos’altro. In quest’atmosfera, sostiene Barnett,9 lo zero prosperò. Astronomi e matematici come Brahmagupta idearono e delinearono le regole matematiche associate allo zero. Qualsiasi numero meno sé stesso era uguale a zero; qualsiasi numero moltiplicato per zero era zero, e così via. Lo zero non era più semplicemente un segno di punteggiatura che indicava una colonna vuota. Lo zero, nel sapere strumentale indiano, era ormai un concetto consolidato, alla pari degli altri numeri.
Si pensa, stando a quanto riferito da Barnett,10 che il primo utilizzo noto di un cerchio vuoto per rappresentare lo zero risalga alla città di Gwalior, nell’India centrale, nell’876, ma ancora una volta la sua popolarità tra la classe mercantile implica che precedenti reliquie dello zero, che venivano indicate solo su carta o corteccia, potrebbero essere andate perdute lungo le rotte commerciali dei secoli precedenti. Attraverso queste rotte, il concetto, nella sua forma avanzata,tornò in Medio Oriente prima di entrare in circolazione nella società europea, in particolare tramite un giovane mercante viaggiatore noto come Fibonacci. Nel 1202, Fibonacci pubblicò il suo Liber Abaci (“Il libro del calcolo”), che introdusse il concetto di zero al pubblico europeo. Eppure, lo zero era ancora osteggiato e ridicolizzato. Le regole sconosciute necessarie per calcolare con i numeri arabi portavano a frequenti errori di calcolo e l’associazione dello zero con il nulla era considerata in diretta opposizione alla divinità: se Dio aveva creato il mondo dal nulla, era ovvio che il nulla dovesse essere evitato. Come detto, al riguardo, Sant’Agostino lo equiparava al diavolo: il nulla era il male più grande.
Fibonacci pubblicò il suo Liber Abaci (“Il libro del calcolo”), che introdusse il concetto di zero al pubblico europeo. Eppure, lo zero era ancora osteggiato e ridicolizzato. Le regole sconosciute necessarie per calcolare con i numeri arabi portavano a frequenti errori di calcolo e l’associazione dello zero con il nulla era considerata in diretta opposizione alla divinità: se Dio aveva creato il mondo dal nulla, era ovvio che il nulla dovesse essere evitato. Come detto, al riguardo, Sant’Agostino lo equiparava al diavolo: il nulla era il male più grande.
Ancora una volta, nell’interpretazione avanzata da Barnett,11 la “classe operaia” si dimostrò essenziale nel promuovere l’uso dello zero. Invero, sarebbe stato con l’introduzione della partita doppia, che gli artigiani utilizzavano per registrare entrate e uscite, che l’utilità dello zero avrebbe preso finalmente piede in Europa. Intorno al XV secolo, la classe intellettuale non poté più ignorarlo e lo zero iniziò ad essere accolto con favore, puntualizza Barnett.12 Forse il caso più significativo fu che, alla fine del XVII secolo, lo zero permise agli scienziati Gottfried Wilhelm Leibniz e Isaac Newton di formulare, indipendentemente, i principi del calcolo infinitesimale, il cui centro era il calcolo dei minimi e dei massimi delle funzioni matematiche. Per questo, lo zero era fondamentale. Qualcosa era, finalmente, nato come dal nulla. Come affermò il matematico Leonhard Euler, “nulla accade al mondo il cui significato non sia quello di un massimo o di un minimo”. Nelle sue congetture, questo qualcosa poteva,potenzialmente, svelare gli eventi inspiegabili dell’Universo.
La ritardata adozione dello zero nel corso della storia trova eco nella tardiva padronanza del numero da parte dei bambini, si inoltra Barnett ad interpretare la questione. Mentre altri numeri positivi corrispondono a entità osservabili nel mondo reale, lo zero appariva inutile per contare. Comprendere e usare lo zero, sostengono gli esperti,13 richiede un allontanamento dal mondo fisico per entrare nel mondo astratto dei concetti, il che potrebbe spiegare perché i bambini impiegano più tempo a padroneggiare lo zero rispetto ad altri numeri numerabili.
Per la documentazione di base del ragionamento di Barnett14 circa l’ingresso dello zero nel nostro patrimonio cognitivo, in esperimenti con neonati pre-verbali, essi sono in grado di tenere traccia del numero di oggetti che vengono loro mostrati. Quando gli psicologi dello sviluppo mostrano ai neonati una sequenza di immagini con, ad esempio, quattro giocattoli, rimangono sorpresi nel vederne, improvvisamente, cinque. Esperimenti simili sarebbero stati condotti per individuare come i bambini piccoli possano eseguire calcoli semplici in modo implicito. Se i bambini di cinque mesi vedono un pupazzo posizionato dietro uno schermo che già nasconde quello che credono essere un altro pupazzo, stando agli esperimenti di Karen Wynn, lo fisseranno più a lungo se lo schermo viene sollevato per rivelare tre pupazzi, il che suggerisce che sono sensibili ai calcoli corretti e sbagliati.15 Questa capacità svanisce, tuttavia, aggiunge Wynn in Limits to Infants’ Knowledge of Objects: The Case of Magical Appearance,16 quando il risultato dovrebbe essere zero pupazzi.
Crescendo, come sostengono altri studiosi, tra i quali Wellman e Miller,17 i bambini iniziano a mostrare una comprensione rudimentale della relazione tra zero e “nulla”, ma non riescono ancora a coglierne appieno le qualità numeriche. Ad esempio, i bambini in età prescolare che sanno che zero significa “nessuna cosa” credono ancora che uno sia il numero più piccolo. Allo stesso modo, se viene chiesto loro di confrontare se zero sia minore di un altro numero, tendono a comportarsi come se stessero semplicemente tirando a indovinare.18 In altri studi, come quelli di Krajcsi, Kojouhaova e Lengyel,19 i bambini piccoli sono stati in grado di svolgere questo tipo di compiti di confronto, ma solo quando la parola “nulla” viene usata al posto della parola “zero”. Questi studi20 rafforzano l’interconnessione tra zero e assenza: per concepire lo zero come un numero, viene prima mappato nella categoria del “nulla” prima di prendere il suo posto all’inizio della retta numerica. Anche quando gli umani adulti concettualizzano con successo lo zero come un numero piccolo, pone comunque difficoltà cognitive. Ad esempio, sostengono gli studiosi Kutter, Dehnen, Borger et al. in Distinct neuronal representation of small and large numbers in the human medial temporal lobe all representation of small and large numbers in the human medial temporal lobe,21 le persone sono più inclini a commettere errori quando classificano lo zero come pari o dispari (nonostante venga detto loro che lo zero sia, in realtà, un numero pari) e ci vuole più tempo, come suggerisce Brysbaert,22 per leggere gli zeri rispetto ad altri numeri piccoli, il che indica un maggiore sforzo del sistema cognitivo.
Quest’euristica suggerirebbe che la nostra capacità di simbolizzare lo zero potrebbe essersi sviluppata da rappresentazioni non simboliche dell’assenza. Date queste idiosincrasie comportamentali, risulta naturale chiedersi come venga rappresentato lo zero nel cervello. Ma questa domanda è propriamente diventata oggetto di studio scientifico solo di recente. Meno di 10 anni fa, due ricerche di laboratori diversi hanno trovato prove convergenti sulla rappresentazione dello zero nel cervello di primati non umani. Registrando l’attività di singoli neuroni mentre venivano mostrati alle scimmie diversi numeri di punti, gli sperimentatori potevano identificare i neuroni che erano specificamente interessati a quantità specifiche. Entrambi gli studi individuarono cellule che rispondevano maggiormente agli insiemi vuoti (punti zero) rispetto ad altri numeri di punti. Alcuni di questi “neuroni zero” si interessavano, esclusivamente, agli insiemi vuoti e ignoravano equamente tutti gli altri numeri di punti. Per la prima volta, i ricercatori avevano dimostrato che nel cervello esistevano neuroni che codificavano specificamente per lo zero. E non era tutto: scoprirono, addirittura, altri neuroni zero, nella parte anteriore del cervello, che mostravano uno schema di attività più graduato: si attivavano di più quando le scimmie vedevano un insieme vuoto, ma si attivavano anche di meno quando vedevano un punto, e di meno quando ne vedevano due, e così via. È importante notare che questi neuroni riflettevano la concezione dello zero come numero all’inizio della retta numerica.

La nostra capacità di simbolizzare lo zero potrebbe essersi sviluppata da rappresentazioni non simboliche dell’assenza.
Date queste idiosincrasie comportamentali, apprese dagli studi riportati, risulta naturale chiedersi come venga rappresentato lo zero nel cervello. Ma questa domanda diventò oggetto di studio scientifico solo di recente. Stando alle fonti di Barnett, meno di 10 anni fa, due diversi esperimenti di ricerca avrebbero trovato prove convergenti sulla rappresentazione dello zero nel cervello di primati non umani.23 Registrando l’attività di singoli neuroni mentre venivano mostrati alle scimmie diversi numeri di punti, gli osservatori avrebbero potuto identificare i neuroni che erano specificamente interessati a quantità specifiche. Entrambi gli studi, il primo di Ramirez-Cardenas, Araceli et al.24 e il secondo di Okuyama, Kuki e Mushiake,25 individuarono cellule che rispondevano maggiormente agli insiemi vuoti (punti zero) rispetto ad altri numeri di punti. Alcuni di questi “neuroni zero” si interessavano, esclusivamente, agli insiemi vuoti e ignoravano, equamente, tutti gli altri numeri di punti. Per la prima volta, stando a questa euristica, i ricercatori dimostrarono che nel cervello esistevano neuroni che codificavano specificamente per lo zero. E non è tutto: scoprirono altri neuroni zero, nella parte anteriore del cervello, che mostravano uno schema di attività più graduato: si attivavano di più quando le scimmie vedevano un insieme vuoto, ma si attivavano anche di meno quando vedevano un punto, e di meno quando ne vedevano due, e così via. Nell’interpretazione di Barnett è importante notare che questi neuroni riflettevano la concezione dello zero come numero all’inizio della retta numerica.
Le basi neurali dello zero negli umani
Nel 2024, l’anno scorso, due nuovi studi hanno contribuito all’obiettivo di caratterizzare le basi neurali dello zero, questa volta negli umani. Questi studi hanno permesso di esaminare la capacità, prettamente umana, di rappresentare lo zero simbolicamente, ovvero come uno “0”. Uno di questi studi, condotto da Esther Kutter26 e il suo gruppo, che ha esaminato l’attività di singoli neuroni nel cervello umano, replicando i risultati degli studi sulle scimmie, questa volta per schemi di punti e numeri, studio che ha, ugualmente, rivelato come i neuroni che rispondevano a insiemi vuoti mostravano un tipo di attività leggermente diverso rispetto ai neuroni che rispondevano a un numero positivo di punti. A causa di questa differenza, è possibile ipotizzare che questi neuroni rappresentino una categoria più fondamentale di“nulla”, in contrapposizione a “qualcosa”, nel cervello, suggerendo, ancora una volta, una profonda connessione tra zero e assenza.
Questo studio della Kutter e il suo gruppo,27 ha completato un esperimento condotto da Barnett con Stephen Fleming,28utilizzando la magneto-encefalografia, che misurava l’attività combinata di migliaia di neuroni, durante compiti numerici che coinvolgono sia zeri simbolici che insiemi vuoti. Ancora una volta, l’attività di diversi gruppi di neuroni mostrava che lo zero si trova all’inizio della retta numerica cerebrale sia per gli insiemi vuoti che per lo zero simbolico. Tuttavia, in questo esperimento di Barnett e Fleming, l’attività cerebrale corrispondente agli insiemi vuoti era, almeno in parte, simile a quella prodotta in risposta ai simboli dello zero. Questo rafforza, ulteriormente, l’idea che la nostra capacità di simbolizzare il concetto di zero possa essersi sviluppata da rappresentazioni non simboliche più semplici dell’assenza. Nel loro insieme, questi studi iniziano a fornire le prime prove di una teoria, proposta per la prima volta dal neuroscienziato Andreas Nieder29 nel 2016, secondo cui la rappresentazione dello zero nel cervello umano può condividere proprietà con una capacità più fondamentale di percepire il “nulla” stesso.
Cosa significa percepire, propriamente, l’assenza o il nulla
Certamente, a questo punto dell’argomentazione possiamo porci la domanda di cosa significhi, dunque, percepire un’assenza, o il nulla? Evidentemente, tali esperienze possono essere tradotte in laboratorio, in particolare, chiedendo alle persone di individuare immagini degradate tra il “rumore” visivo, con domande del tipo – “Hai visto uno schema o era solo rumore?”. A quanto pare, a questo punto dell’argomentazione si può sottolineare come la comprensione dello zero sia parimenti rivelante alla questione di cosa serva per percepire un’assenza sensoriale, cosa che non è così semplice. Stando, ad esempio, a Barnett,30 i sistemi sensoriali del cervello sono orientati a rilevare la presenza di oggetti, piuttosto che la loro assenza: quando un oggetto invade il campo visivo, in generale, i neuroni della corteccia visiva si attivano. Inoltre, questa propensione a rilevare gli oggetti si riflette nell’in- teresse scientifico per l’argomento. In effetti, la maggior parte delle ricerche neuroscientifiche sulla percezione e la coscienza si concentrano su come diventiamo consapevoli di qualcosa. Ciononostante, le esperienze di assenza costituiscono una parte significativa della nostra esperienza cosciente. Concretamente, spesso diventiamo consapevoli di ciò che non  possiamo vedere. In effetti, individuarne le basi neurali è altrettanto importante per comprendere appieno i meccanismi che supportano la consapevolezza umana. Proprio come l’insorgenza ritardata della fluenza con lo zero, accade anche che la percezione delle assenze sensoriali si sviluppa più tardi nell’infanzia, rispetto alla percezione di caratteristiche tangibili. Una prova classica di ciò31 deriva dall’“effetto positivo delle caratteristiche”, che descrive come la presenza di qualcosa sia più facile da rilevare della sua assenza. Ad esempio,32 seguendo l’euristica della ricerca di Coldren e Haaf, quando i bambini di quattro mesi familiarizzano con la lettera “F”, rimarranno sorpresi quando il simbolo successivo ad apparire sarà una “E”, che ha un trattino in più in basso. Ma quando l’ordine viene invertito e una “E” familiare è seguita da una “F”, i bambini non si stupiscono: è come se l’assenza della linea inferiore semplicemente non venisse percepita. Curiosamente, questo è parallelo all’incapacità dei bambini di riconoscere lo zero negli esperimenti con i burattini descritti in precedenza.
possiamo vedere. In effetti, individuarne le basi neurali è altrettanto importante per comprendere appieno i meccanismi che supportano la consapevolezza umana. Proprio come l’insorgenza ritardata della fluenza con lo zero, accade anche che la percezione delle assenze sensoriali si sviluppa più tardi nell’infanzia, rispetto alla percezione di caratteristiche tangibili. Una prova classica di ciò31 deriva dall’“effetto positivo delle caratteristiche”, che descrive come la presenza di qualcosa sia più facile da rilevare della sua assenza. Ad esempio,32 seguendo l’euristica della ricerca di Coldren e Haaf, quando i bambini di quattro mesi familiarizzano con la lettera “F”, rimarranno sorpresi quando il simbolo successivo ad apparire sarà una “E”, che ha un trattino in più in basso. Ma quando l’ordine viene invertito e una “E” familiare è seguita da una “F”, i bambini non si stupiscono: è come se l’assenza della linea inferiore semplicemente non venisse percepita. Curiosamente, questo è parallelo all’incapacità dei bambini di riconoscere lo zero negli esperimenti con i burattini descritti in precedenza.
Inoltre, Coldren e Haaf,33 sostengono che il nostro svantaggio nel rilevare le assenze non è qualcosa di cui siamo in genere consapevoli. Proprio come lo zero, le nostre difficoltà nel percepire le assenze non si esaurisce nell’età adulta. In particolare, come documenta Healy, quando correggiamo un testo scritto, siamo molto più abili nel rilevare quando le lettere presentano delle caratteristiche aggiunte rispetto a quando vengono rimosse. Quando ci vengono mostrate sequenze di immagini, mostriamo anche bias di “caratteristiche positive” simili a quelli dei bambini, come riporta, anche, la ricerca di Newman, Wolff e Hearst.34 Questa documentazione è valida in una vasta gamma di stimoli uditivi e visivi, così come in animali come piccioni,35 ratti,36 api37 e scimmie,38 il che suggerisce che il rilevamento delle assenze presenti uno stato di svantaggio costante tra i sistemi percettivi naturalmente evoluti.
Non solo, come accennato, il nostro svantaggio nel rilevare le assenze non è qualcosa di cui siamo tipicamente consapevoli. Come documenta l’euristica ricavata da Mazor, Friston, Fleming e Moran39 quando diciamo di non aver visto qualcosa, di solito siamo meno sicuri di quando pensiamo di aver visto qualcosa, ma siamo anche meno abili40 nell’identificare quando questi giudizi di assenza sono probabilmente corretti o scorretti. In breve, sarebbe più difficile avere una visione autoriflessiva delle nostre esperienze di assenza che delle nostre esperienze di presenza. Questo, certamente fa sì che i ricercatori si pongano la domanda seguente: “Se il modo in cui il cervello supporta la percezione delle assenze è così distinto, come genera esattamente queste esperienze del nulla?”
Come per lo zero, prove emergenti suggeriscono che alcuni neuroni nel cervello di uccelli, scimmie ed umani siano sintonizzati sull’esperienza delle assenze percettive. In compiti in cui a corvidi41 e macachi42 veniva chiesto di rilevare se uno stimolo debole fosse mostrato su uno schermo, i neuroni in regioni approssimativamente analoghe alla corteccia frontale degli umani si attivavano appena prima che gli animali indicassero di non aver visto nulla. Allo stesso modo, in noi umani,43 singoli neuroni nella corteccia parietale si attivavano specificamente quando i partecipanti alle ricerche di laboratorio decidevano che uno stimolo vibratorio applicato al loro polso era assente, come sostengono Pereira e Megevand.44
La domanda al riguardo nella teoresi condivisa da Barnett sarebbe se questi “neuroni dell’assenza” indichino che una persona ha già deciso che uno stimolo sia assente o stia contribuendo al processo stesso di prendere questo tipo di decisione. Questi studiosi ancora non hanno una risposta. Ciononostante, ora sembra più chiaro per loro che le percezioni di assenza non sono mediate da una mera assenza di attività neurale. Piuttosto, il cervello può disporre di meccanismi unici attraverso i quali rappresenta queste esperienze distintive.45
In ogni modo, loro assumono che il cervello sia in grado di dire se i nostri sistemi di attenzione siano sufficientemente attenti da rilevare l’oggetto qualora fosse presente. Tali meccanismi sono centrali in alcune nuove teorie emergenti sulla coscienza. Questi modelli, come le teorie del monitoraggio della realtà percettiva (PRM)46 e dello spazio di stato di ordine superiore (HOSS),47 si concentrano, specificamente, sui processi cerebrali che decidono se qualcosa sia stato visto o meno. Secondo queste teorie, esistere un meccanismo neurale che interpreta l’attività cerebrale rilevata nelle aree visive (e in altre aree sensoriali), un po’ come un fact-checker. Questo meccanismo verifica se l’attività sensoriale contiene schemi sufficientemente affidabili da indicare la percezione di un oggetto nel mondo esterno, oppure se si tratta di rumore o di immagini mentali. È importante sottolineare, tuttavia, che questo sistema non è semplicemente inattivo in assenza di attività affidabile nelle regioni sensoriali. Queste teorie sostengono, invece, che il meccanismo di controllo indichi, attivamente, che non è stato percepito nulla. Infatti, questo risulta rilevante in quanto spiega come possiamo prendere coscienza dell’assenza di stimolazione.
Quindi, la domanda euristica o epistemologica continua ancora del tutto non risolta: come percepiamo esattamente le assenze quando non c’è nulla da percepire? In un modello sviluppato dal neuroscienziato cognitivo Matan Mazor,48 per poter percepire un’assenza, dobbiamo prima sottoporci a una qualche forma di ragionamento controfattuale, cioè del tipo: “se l’oggetto fosse presente, l’avrei visto”. Ciò che risulta intrigante e rilevante di questa formulazione è che richiede l’accesso all’autoconoscenza del proprio sistema percettivo: il cervello è in grado di dire se sta funzionando normalmente e se i nostri sistemi attentivi siano sufficientemente attenti da rilevare l’oggetto o il suono in questione, qualora fosse presente. Ci sono prove empiriche che suggeriscono che sia così. In uno altro studio di Mazor,49 ai partecipanti è stato chiesto se ci fosse una lettera immersa nel rumore: una volta che la loro visione delle immagini rumorose è stata oscurata da linee occlusive, i partecipanti aumentarono la velocità con cui decidevano che una lettera era presente quando realmente non c’era. In altre parole, le persone utilizzavano l’intuizione autoriflessiva che il loro sistema visivo era stato ostacolato nel rilevare la lettera, e ne tenevano conto nel loro processo decisionale.
Tutto ciò ci riporta allo zero. La domanda è: lo stesso meccanismo neurale sottostante guida le esperienze sia dello zero che dell’assenza percettiva? Se così fosse, questo ci mostrerebbe che, quando ci dedichiamo alla matematica usando lo zero, stiamo anche invocando un sistema cognitivo più fondamentale e automatico, che è, ad esempio, responsabile del rilevamento dell’assenza di uccelli quando osserviamo gli uccelli.
I sistemi cerebrali utilizzati per estrarre numeri positivi dall’ambiente sono relativamente ben compresi. Parti della corteccia parietale si sono evolute per rappresentare il numero di “cose” nel nostro ambiente, eliminando al contempo le informazioni su cosa siano quelle “cose”. Questo sistema indica semplicemente “quattro” se vedessi quattro gufi, per esempio. Summerfield, Luycks e Sheahan,50 ritengono che tale sistema sia fondamentale per apprendere la struttura del nostro ambiente. Se si scoprisse che i sistemi neurali che governano la nostra capacità di decidere se vediamo coscientemente qualcosa o meno si basano su questo stesso meccanismo, ciò aiuterebbe teorie come HOSS e PRM a comprendere esattamente come si genera questa capacità. Forse, proprio come questo sistema apprende la struttura e le regolarità del nostro ambiente, apprende anche la struttura dell’attività sensoriale del nostro cervello per aiutarci a determinare quando abbiamo visto qualcosa. Questo è ciò che PRM e HOSS già prevedono, ma basare le teorie su idee consolidate sul funzionamento del cervello può fornire loro un punto d’appoggio più solido nello spiegare i meccanismi precisi che ci permettono di prendere coscienza del mondo.
Un’ipotesi intrigante ispirata alle idee di cui sopra è che, se la base cerebrale dello zero si basa sui tipi di meccanismi neurali correlati all’assenza che i quadri teorici sopra menzionati ritengono necessari per l’esperienza cosciente, allora affinché qualsiasi organismo possa impiegare con successo il concetto di zero, dovrebbe prima dover essere percettivamente cosciente. Ciò significa che la comprensione dello zero può fungere da indicatore della coscienza.
Dato che persino le api hanno dimostrato di apprezzare un concetto rudimentale di zero, questo può sembrare, almeno ad alcuni, inverosimile. Ciononostante, sembra interessante suggerire che le somiglianze tra assenze numeriche e percettive potrebbero contribuire a svelare le basi neurali non solo delle esperienze di assenza, ma anche della consapevolezza cosciente in senso più ampio. Jean-Paul Sartre ha testimoniato che il nulla era, dopotutto, il cuore dell’essere.
L’evoluzione del numero zero ha, da questa prospettiva, contribuito a svelare i segreti del cosmo. Resta da vedere se possa aiutare a svelare gli eventi inspiegabili della nostra nozione di mente. Per ora, studiarlo ha almeno portato a una minore delusione per i nostri fallimenti nel bird-watching. Ora sappiamo che c’è una grande complessità nel non vedere nulla e che, cosa ancora più importante, il nulla ha davvero importanza!
- È il numero che precede uno e gli altri numeri positivi e segue i numeri negativi. Zero indica la cardinalità dell’insieme vuoto. Se la differenza tra il numero di oggetti in due insiemi è zero, significa che i due insiemi contengono lo stesso numero di elementi. Zero va però distinto da “assenza di valore” poiché si tratta di due concetti diversi: ad esempio se latemperatura è zero, l’acqua ghiaccia (nel caso della gradazione Celsius della temperatura); se manca il dato della temperatura, assenza del valore, nulla si può dire. Attorno al 300 a.C. i babilonesi iniziarono a usare un semplice sistema di numerazione in cui impiegavano due cunei inclinati per marcare uno spazio vuoto. Questo simbolo tuttavia non aveva una vera funzione oltre a quella di segnaposto. Il simbolo dello zero deriva dalla lettera greca omicron che si ritrova sistematicamente nelle tavole di Tolomeo e Giamblico che già lo usavano dal I secolo d.C. Il nome per esteso era οὺδἐν (ouden = nulla). Gli indiani appresero poi la sua esistenza quasi certamente dai greci dopo le conquiste di Alessandro Magno e nel tardo ellenismo. L’uso dello zero come numero in sé è un’introduzione relativamente recente della matematica, che si deve ai matematici indiani, anche se gli antichi popoli mesoamericani arrivano al concetto di zero indipendentemente. La prima menzione dello zero risale al matematico Jinabhadra Gani, che definisce 224.400.000.000 come “ventidue e quaranta e quattro e otto zeri”, in India nel VI secolo. Gli arabi appresero dagli indiani il sistema di numerazione posizionale decimale e a sua volta lo trasmisero agli europei durante il Medioevo, perciò ancora oggi in Occidente i numeri scritti con questo sistema sono detti numeri arabi.
- Ibidem
- Ibidem
- Ibidem
- Ibidem
- Ibidem
- Ibidem
- Ibidem
- Ibidem
- Ibidem
- Ibidem
- Ibidem
- Ibidem
- Ibidem
- Wynn, K. Addition and subtraction by human infants. Nature 358, 749–750 (1992).
- Wynn, K., & Chiang, -C. (1998). Limits to Infants’ Knowledge of Objects: The Case of Magical Appearance. Psychological Science, 9(6), 448-455.
- Wellman, H. M., & Miller, K. F. (1986). Thinking about nothing: Development of concepts of zero. British Journal of Developmental Psychology, 4(1), 31–42.
- Ibidem
- Krajcsi A, Kojouharova P and Lengyel G (2021) Development of Preschoolers’ Understanding of Zero. Front. Psychol. 12:583734.
- Ibidem
- Kutter, E.F., Dehnen, G., Borger, V. et al. Distinct neuronal representation of small and large numbers in the human medial temporal lobe. Nat Hum Behav 7, 1998–2007 (2023).
- Brysbaert, M. (1995). Arabic number reading: On the nature of the numerical scale and the origin of phonological recoding. Journal of Experimental Psychology: General, 124(4), 434–452.
- Benjy Barnett op. cit. 10 March 2025.
- Ramirez-Cardenas, Araceli et al. Neuronal Representation of Numerosity Zero in the Primate Parieto-Frontal Number Network. Current Biology, Volume 26, Issue 10, 1285 – 1294.
- Okuyama, S., Kuki, T. & Mushiake, H. Representation of the Numerosity ‘zero’ in the Parietal Cortex of the Monkey. Sci Rep 5, 10059 (2015).
- Kutter, Esther et al. Current Biology, Volume 34, Issue 20, 4794 – 4802.e3, October 21, 2024.
- Ibidem
- Barnett Benjy et al. Symbolic and non-symbolic representations of numerical zero in the human brain. In Current Biology, Volume 34, Issue 16, 3804 – 3811.e4, August 19, 2024
- Nieder, Andreas. Representing Something Out of Nothing: The Dawning of Zero. Trends in Cognitive Sciences, Volume 20, Issue 11, 830 – 842, November 2016.
- Benjy op. cit. 10 March 2025.
- Robert Sainsbury. The “feature positive effect” and simultaneous discrimination learning. Journal of Experimental Child Psychology. Volume 11, Issue 3, June 1971, Pages 347-356.
- Coldren JT, Haaf RA. Asymmetries in infants’ attention to the presence or absence of features. J Genet Psychol. 2000 Dec;161(4):420-34.
- Ibidem
- Newman, J. P., Wolff, W. T., & Hearst, E. (1980). The feature-positive effect in adult human subjects. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory, 6(5), 630–650.
- Hearst, E. The feature-positive effect in pigeons: Conditionality, overall predictiveness, and type of feature. Bull. Psychon. Soc. 26, 73–76 (1988)
- Crowell, C.R., Bernhardt, T.P. The feature-positive effect and sign-tracking behavior during discrimination learning in the rat. Animal Learning & Behavior 7, 313–317 (1979).
- Charles Abramson, Ibrahim Cakmak, Meghan E. Duell, Leah M. Bates-Albers, Enoc M. Zuniga, Loma Pendegraft, Amanda Barnett, Carmen L. Cowo, Joshua J. Warren, Aaron C. Albritton-Ford, John F. Barthell, John M. Hranitz, Harrington Wells. Feature-positive and feature- negative learning in honey bees. Journal of Experimental Biology, (2013) 216 (2): 224–229.
- Pace, Gary M., D. F. McCoy, and Gary B. Nallan. “Feature-Positive and Feature-Negative Learning in the Rhesus Monkey and Pigeon.” The American Journal of Psychology 93, no. 3 (1980): 409–27.
- Matan Mazor, Karl J Friston, Stephen M Fleming (2020) Distinct neural contributions to metacognition for detecting, but not discriminating visual stimuli eLife 9: e53900.
- Matan Mazor, Rani Moran, Stephen M Fleming, Metacognitive asymmetries in visual perception, Neuroscience of Consciousness, Volume 2021, Issue 1, 2021.
- Lysann Wagener, Andreas Nieder; Conscious Experience of Stimulus Presence and Absence Is Actively Encoded by Neurons in the Crow Brain. J Cogn Neurosci 2024; 36 (3): 508–521.
- Merten, & A. Nieder, Active encoding of decisions about stimulus absence in primate prefrontal cortex neurons, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 109 (16) 6289-6294.
- Pereira, M., Megevand, P., Tan, M.X. et al. Evidence accumulation relates to perceptual consciousness and monitoring. Nat Commun 12, 3261 (2021).
- Ibidem
- Benjy Barnett op. cit. 10 March 2025.
- Lau, Hakwan, In Consciousness we Trust: The Cognitive Neuroscience of Subjective Experience (Oxford, 2022; online edn, Oxford Academic, 24 Mar. 2022).
- Stephen M Fleming, Awareness as inference in a higher-order state space, Neuroscience of Consciousness, Volume 2020, Issue 1, 2020.
- Mazor, Matan. 2021. “Inference About Absence as a Window into the Mental Self-model.” PsyArXiv. February 15.
- Mazor, Matan, Rani Moran, and Clare Press. 2024. “Beliefs About Perception Shape Perceptual Inference: An Ideal Observer Model of Detection.” PsyArXiv. June 23.
- Summerfield C, Luyckx F, Sheahan H. Structure learning and the posterior parietal cortex. Prog Neurobiol. 2020 Jan; 184:101717. doi: 10.1016/j.pneurobio.2019.101717. Epub 2019 Oct 24. PMID: 31669186.








