Byung-chul Han, filosofo coreano nato nel 1959 ma che vive ed insegna in Germania, è forse oggi il più originale ed intrigante interprete della teoria critica che risale alla famosa scuola di Francoforte.
Il bersaglio della sua critica è la società digitalizzata, per aver essa smaterializzato il mondo sostituendo alle cose non tanto e non solo le merci, come da marxiana critica dell’alienazione nel mondo capitalistico, quanto la semplice immagine levigata di una mera informazione. Titolo di un suo recente libro è Le non cose. Come abbiamo smesso di vivere il reale.
 “La digitalizzazione derealizza, disincarna il mondo”. Ed il nostro stress è quello di esporci volontariamente e continuamente ad uno choc meno vissuto che virtuale. “Le informazioni simulano eventi. Si fondano sul brivido della sorpresa. Ma questo brivido non dura a lungo: ben presto emerge il bisogno di nuovi stimoli”. L’ordine digitale, dunque, derealizza il mondo informatizzandolo. “Ormai siamo tutti infomani”.
“La digitalizzazione derealizza, disincarna il mondo”. Ed il nostro stress è quello di esporci volontariamente e continuamente ad uno choc meno vissuto che virtuale. “Le informazioni simulano eventi. Si fondano sul brivido della sorpresa. Ma questo brivido non dura a lungo: ben presto emerge il bisogno di nuovi stimoli”. L’ordine digitale, dunque, derealizza il mondo informatizzandolo. “Ormai siamo tutti infomani”.
Il punto critico è ormai superato: “Da un certo momento in avanti le informazioni non informano più, bensì deformano”, circolano in uno spazio iperreale senza aver più alcun appiglio con la realtà. L’uomo sta diventando una specie ludica che anziché agire sceglie con le dita. Che più ancora che al possesso ambisce all’accesso. “Preferisce il gioco al lavoro, l’esperienza e il divertimento al possesso”.
Si può discutere, come Walter Benjamin fece, del destino dell’arte nell’epoca della riproducibilità tecnica, constatarne la perdita d’aura ovvero auspicare il potenziale rivoluzionario di questa perdita della sua distanza. Ma la questione è posta da Byung-chul Han in termini ontologici: “Il touch screen elimina la negatività dell’Altro, dell’indisponibile”. Lo smartphone, lungi dal poter svolgere quella funzione vitale che ha per un bambino l’oggetto transizionale come, per esempio, un peluche che dà al bambino sicurezza e fiducia, lo smartphone è semplicemente un oggetto narcisistico. Non rimanda che alla sua stessa immagine idealizzata di un accesso possibile ad ogni cosa. Lo smartphone non vuole le coccole, reindirizza su se stessi e quindi svuota e derealizza ogni possibile relazione con l’Altro. “Lo smartphone non è un orsetto digitale: è più che altro un oggetto narcisistico e autistico grazie al quale si percepisce soprattutto se stessi”. C’è un’ipertrofia di contatti cui corrisponde la mancanza di una reale felicità. “Tale ipercomunicazione non è tuttavia appagante. Non fa che aggravare la solitudine, poiché le manca la presenza dell’Altro”.
La nostra stessa immagine si contrae in un selfie. “Scollata dal referente, la fotografia diventa autoreferenziale”. Testimoniamo a noi stessi che noi eravamo lì, meno in un’apertura ad un diverso luogo che in un ossessivo riferimento a noi stessi. Meno che un ricordo che racconta una storia, è sempre la stessa storia che si ripete. Meno che il segno di una malinconica bellezza, il selfie è l’immagine di un’allegria digitale. Meno che la possibile rivelazione di un mistero, è la reiterata esibizione di sé stessi.
Il nostro mondo è derealizzato dallo spettro di un’intelligenza artificiale che gli si sostituisca. Ma – è banale dirlo: l’intelligenza artificiale non ha la pelle d’oca, non ascolta, non ha cuore. È un pensiero senza quella che Platone riteneva fosse la sua precondizione: l’Eros. Nella sua algida incapacità di aprirsi ad Altro, l’intelligenza artificiale è troppo intelligente per essere idiota. Ma non c’è filosofia e pensiero critico senza la capacità di fare l’idiota.
Eros in agonia
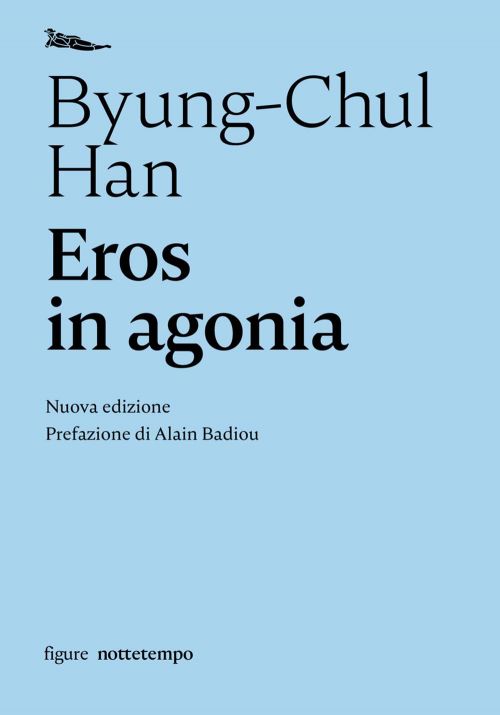 Nella cultura contemporanea tutto viene perennemente assimilato a tutto, ma questo trionfo dell’Uguale è anche la fine dell’amore. “Nell’inferno dell’Uguale, a cui la società contemporanea assomiglia sempre più, non c’è perciò alcuna esperienza erotica”.
Nella cultura contemporanea tutto viene perennemente assimilato a tutto, ma questo trionfo dell’Uguale è anche la fine dell’amore. “Nell’inferno dell’Uguale, a cui la società contemporanea assomiglia sempre più, non c’è perciò alcuna esperienza erotica”.
La diagnosi è drastica. “Il soggetto narcisistico-depressivo è esaurito e logorato da se stesso”. “La depressione si presenta come impossibilità dell’amore”.
Lo stesso poter essere liberi è una sorta di autosfruttamento nell’imperativo della performatività, dell’efficienza della prestazione. Ne scaturisce l’ansia di un fallimento che, in mancanza dell’Altro, non può incontrare né perdono né espiazione. Ma: “l’Eros è appunto una relazione con l’Altro, che si colloca al di là della prestazione e del potere”.
“Solo attraverso l’impossibilità-di-potere, l’Altro può manifestarsi”.
Altri sono i gesti d’amore rispetto alla computazione del piacere. Han li cerca nella descrizione che Emmanuel Levinas fa della carezza: “un gioco con qualcosa che si sottrae”. Non c’è Eros se non nella assenza/presenza dell’Altro. Nella fedeltà e soggezione all’Altro, l’Eros trova la sua etica e la sua follia.
Ma nella società che ha narcotizzato il dolore della passione, il desiderio si estenua. “Il desiderio dell’Altro lascia il posto al comfort dell’Uguale”. Agonizza Eros, che dovrebbe essere “il mezzo dell’innalzamento della vita fino alla morte”.
“In una società nella quale ciascuno è imprenditore di se stesso, domina un’economia della sopravvivenza: essa è diametralmente opposta alla non-economia dell’Eros e della morte”.
La società della stanchezza
 L’eccesso e l’infrazione di Eros sono negati nella nuda vita, nella terapia della salute come mera sopravvivenza. Non è più in gioco la buona vita. L’odierna società della prestazione e della competizione è solamente oscena. “Il soggetto di prestazione, che si immagina libero, in realtà è incatenato come Prometeo”. Un Prometeo stanco del suo fegato che continuamente ricresce.
L’eccesso e l’infrazione di Eros sono negati nella nuda vita, nella terapia della salute come mera sopravvivenza. Non è più in gioco la buona vita. L’odierna società della prestazione e della competizione è solamente oscena. “Il soggetto di prestazione, che si immagina libero, in realtà è incatenato come Prometeo”. Un Prometeo stanco del suo fegato che continuamente ricresce.
La società disciplinare ha ceduto il posto alla società della prestazione. Il risultato è una iperattività che è un regresso. Il risultato di un eccesso di stimoli, informazioni e impulsi è una stanchezza in cui la percezione risulta frammentata e dispersa. Il multitasking era una forma di sopravvivenza (“un animale intento a nutrirsi deve svolgere contemporaneamente altri compiti”), cui l’uomo poté cercare di sostituire un’attenzione contemplativa ai superiori scopi dell’esistenza, quelli a cui secondo Hahnemann deve potersi volgere una forza vitale guarita. La forza vitale è invece oggi irretita in una competizione fine a se stessa, in una libertà che è in realtà disarmonico autosfruttamento. “La pura frenesia non crea nulla di nuovo, ma riproduce e accelera ciò che è già disponibile”.
 Una società iperattiva deve poi specchiarsi nell’insensatezza della sua mera sopravvivenza. “Proprio alla nuda vita, che è divenuta incredibilmente fugace, si reagisce con l’iperattività, con l’isteria del lavoro e della produzione”.
Una società iperattiva deve poi specchiarsi nell’insensatezza della sua mera sopravvivenza. “Proprio alla nuda vita, che è divenuta incredibilmente fugace, si reagisce con l’iperattività, con l’isteria del lavoro e della produzione”.
La società del doping è una possibile evoluzione della società della prestazione che si assuefà alla stanchezza che essa stessa crea. “La stanchezza della società della prestazione è una stanchezza solitaria, che agisce separando e isolando”. Una mera stanchezza da esaurimento.
Che la recente pandemia ha acutizzato. “L’assenza del rituale è un’altra ragione della stanchezza indotta dal telelavoro”. Il telelavoro non allevia ma intensifica la stanchezza, facendoci avviluppare ancora più profondamente in noi stessi: “mancano le altre persone, chi potrebbe distrarci dal nostro io”.
Filosofia del buddismo e ritualità zen
L’inutile ipertrofia di attività autoreferenziali trova antidoto e naufragio nel pensiero già buddista del vuoto: “bisogna intendere il vuoto come un medium della gentilezza amichevole”.
È da questo nucleo buddista che può partire la proposta di Han di reincantare il mondo, di sottrarlo al baccano in cui il soggetto si produce girando a vuoto su se stesso, di riproporre un simbolismo rituale che liberi la società dal suo narcisismo collettivo e la riapra al senso di una vera connessione con l’Altro.
Nella coazione a produrre domina una comunicazione senza comunità, laddove i riti hanno il valore simbolico di una comunità senza comunicazione. Quella di un rito funebre di condivisione del lutto o di una cerimonia festosa di comunione di gioia. Dove anche l’autenticità è diventata una coazione individuale, Han vorrebbero che ritrovassero luogo spazi di ritualità “in cui sarebbero possibili delle digressioni giocose e festose”, “spazi dell’eccesso e della stravaganza che si distinguono dalla quotidianità profana”.
La sfida è di ritrovare luoghi di un’energia curativa anziché della dissipazione insensata di energia. Riti che sanciscano anche la chiusura, la fine, la morte, il compimento di qualcosa e non la sua insensata reiterazione. Dove al riposo festivo si ridia la possibilità di ospitare e donare il silenzio del sacro.
Forse meno utopistica che intensa è la capacità che una comunità può ancora avere di fare festa. “La festa, come forma di gioco, è un’autorappresentazione della vita. Ha un carattere esuberante. È espressione di una vita traboccante che non ha obiettivi”. La festa non di un turismo in cui tutti i luoghi sono uguali, ma quasi di un pellegrinaggio che faccia di un luogo un raduno.
Non una coazione alla felicità, evidentemente: del tipo sii felice, diventa smart. Ma un comune dare un senso al dolore, ed alla gioia. “Senza dolore non abbiamo né amato, né vissuto”.
Considerazioni che si fanno attualità. “In tempi di pandemia, il dolore degli altri scompare ancora più in lontananza”. “Vicinanza significa infezione. Il “distanziamento sociale” rafforza la perdita d’empatia”. “L’Altro è ora un potenziale portatore del virus dal quale bisogna prendere le distanze”.
Il rifiuto collettivo della nostra fragilità dovrebbe lasciare il posto alla consapevolezza che è solo attraverso il dolore che ci si apre al mondo.







0 commenti