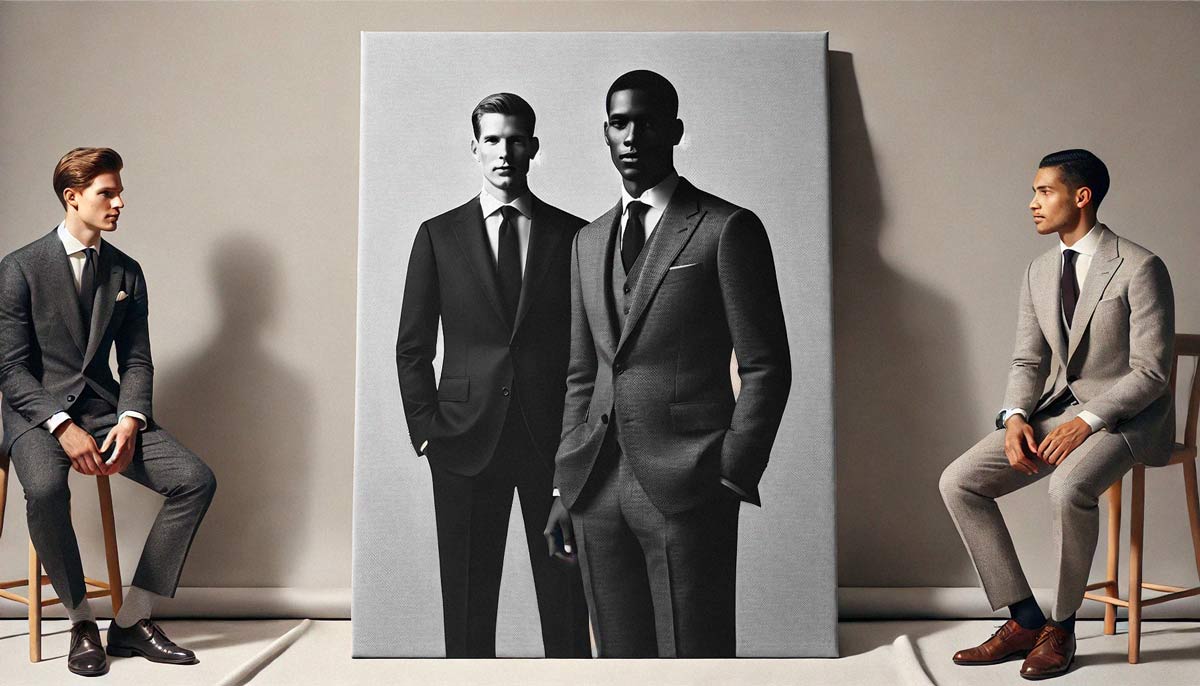BIO – Medicina Costruzione Sociale nella Post-Modernità – Educational Papers • Anno VIII • Numero 31 • Settembre 2019
Dall’idea dei bambini geneticamente predisposti ad imitare all’idea dell’apprendimento per imitazione attraverso l’esperienza dello specchio
Nella seconda metà del secolo scorso una parte degli studiosi della cognizione umana ci aveva fornito un modello esplicativo circa la cognizione umana basato sull’idea di un istinto cognitivo genetico. Oggi, alcuni studiosi iniziano a proporci un nuovo modello interpretativo della cognizione umana basato sull’imitazione dell’interazione sociale nell’evoluzione culturale, conosciuto come il modello dei gadget cognitivi. Questo modello sostiene, specificamente, che i nostri dispositivi di pensiero, cioè l’imitazione, l’interpretazione dei pensieri e delle emozioni altrui, il linguaggio ed altro, sarebbero abilità acquisite nell’infanzia attraverso l’interazione sociale anziché capacità innate progettate dall’evoluzione genetica. Per spianare la strada alla comprensione di quest’argomentazione, immaginiamo questa scena emblematica di quanto, nella dissertazione, si intende dire sull’imitazione come il gadget cognitivo per eccellenza:
un pomeriggio entriamo nella biblioteca civica del nostro comune di residenza e vediamo un papà immerso in un tomo delle opere di Benedetto Croce. Nella stanzetta di lettura, la figlia, di tre o quattro anni, piuttosto che scatenare gli scompigli del caso, sta fissando, intensamente, un libro di logica matematica, facendo, esattamente, come suo padre, con la stessa fronte aggrottata, la postura arcuata e le ditina che si accarezzano il mento.
I bambini, sostengono i ricercatori in materia, sono padroni dell’imitazione. Copiando genitori e altri adulti, apprendono il loro mondo sociale, imparano le espressioni facciali e i movimenti del corpo che consentono loro di comunicare, ottenere approvazione ed evitare il rifiuto. Per circostanziare quest’inferenza gli studiosi aggiungono che molto prima che sia possibile l’istruzione verbale, genitori e adulti già forniscono ai piccoli un apprendistato su come comportarsi quali membri della loro particolare cultura. Una vasta gamma di comportamenti, dall’uso di utensili ai costumi sociali, viene trasmessa da una generazione all’altra attraverso l’apprendimento per imitazione. Infatti, nelle culture occidentali, ad esempio, i bambini già ai primi passi tengono il loro telefono di plastica all’orecchio e parlottano. I figli degli Aborigeni Australiani, ignari ancora della cultura occidentale, non lo farebbero, si può ipotizzare, se gli capitasse in mano uno di questi giocatoli. Per di più, sembra non ci sia propensione alcuna a trattare così dei pezzi di plastica e ciò non sarebbe dovuto ad un condizionamento operante1 ma, maggiormente, all’apprendimento per imitazione, come sostiene la studiosa dell’evoluzione della “mente”2 umana, Cecilia Heyes nel suo libro, appena pubblicato l’anno scorso, “Cognitive Gadgets: The Cultural Evolution of Thinking”3.
Che l’imitazione abbia un’influenza così potente sullo sviluppo dei bambini è stato ormai così ben documentato dalle neuroscienze che le organizzazioni per la protezione dei piccoli in tutto il mondo conducono campagne che ricordano ai genitori di essere dei modelli. Di fatto, c’è il detto che sentenzia che se non si vuole che i propri figli urlino contro gli altri bambini, basta non urlare contro di loro.
Cecilia Heyes4, approcciando la questione dell’evoluzione dei nostri presumibili dispositivi cognitivi ci segnala che ancora il punto di vista convenzionale, all’interno e all’esterno del mondo accademico, è che i bambini siano “cablati”, cioè geneticamente predisposti, per imitare. Certamente, osservando la nostra propensione ad imitare, nella prospettiva della psicologia che studia l’evoluzione della mente umana, noi umani, potremmo essere rinominati, parafrasando il titolo dell’opera di Leandro Herrero, “Homo imitans”5, cioè animali nati con un ardente desiderio di copiare le azioni degli altri. L’imitazione sarebbe, per così dire, metaforicamente, “nei nostri geni”, al punto che si potrebbe asserire come caratteristica tassonomica distintiva che gli uccelli costruiscono nidi, i gatti miagolano, i maiali sono avidi e noi, umani, possediamo “l’istinto di imitare”.
L’idea che noi, umani, abbiamo “istinti cognitivi” fu, decisamente, una pietra miliare della psicologia evolutiva, in modo particolare tra i suoi precursori negli anni ’90 Leda Cosmides, John Tooby e Steven Pinker. “I crani moderni ospitano una mente dell’età della pietra”, scrissero Cosmides e Tooby nel 19976. Secondo questa visione, i processi cognitivi o “organi del pensiero” con cui affrontiamo la vita contemporanea sarebbero stati plasmati dall’evoluzione genetica per soddisfare i bisogni di piccoli gruppi nomadi, gruppi che, si può immaginare, dedicavano la maggior parte della loro energia a strappare piante e a cacciare animali. Da questa prospettiva, non ci dovrebbe sorprendere se, oggi, i nostri “istinti cognitivi” dell’età della pietra spesso offrano soluzioni goffe e anche non efficienti. Al riguardo, però, dalla prospettiva del modello dell’istinto cognitivo innato non ci sarebbe molto altro da fare, poiché noi saremmo, semplicemente, schiavi dei nostri “geni pensanti”.
Quest’interpretazione, circa i nostri dispositivi cognitivi, ci può sembrare plausibile e intuitiva. Il problema è che le prove dietro di essa sono diventate discutibili. In effetti, i cognitivisti insistono che se si guarda da vicino, risultae evidente che la psicologia evolutiva è richiamata ad una revisione. Infatti, la proposta teoretica, attualmente, sostiene che anziché da istinti cognitivi innati [o cablati, come si direbbe oggi] è molto più probabile che le nostre teste siano popolate da gadget cognitivi, ritoccati durante generazioni successive. Per di più, piuttosto che attribuire alla selezione naturale la modellazione di questi gadget cognitivi, tale conferimento di forma e consistenza è da attribuire alla cultura che non solo fornisce i contenuti dei nostri pensieri ma le modalità stesse in cui li processiamo.
Alla fine degli anni ’70, gli psicologi Andrew Meltzoff e Keith Moore dell’Università di Washington riferirono che i neonati – alcuni dei quali nati da poche ore – potevano copiare una serie di espressioni facciali, tra cui la protrusione della lingua, l’apertura della bocca e l’increspatura delle labbra. Questo “rilevamento sperimentale” lanciò l’idea che noi, esseri umani, avessimo l’istinto di imparare per imitazione. Sicuramente, un risultato così precoce poteva essere dovuto a una programmazione genetica. Infatti, ancora oggi risulta abbastanza improbabile immaginare come il bambino medio possa imparare a riprodurre le espressioni che vede sui volti intorno a lui, solo a poche ore o giorni dalla nascita. Secondo le prime interpretazioni di Meltzoff e Moore, le loro “rilevazioni” indicavano che i bambini dovevano nascere con un complesso meccanismo cognitivo, una sorta di “macchina pensante” che collegava “movimenti percepiti ma invisibili del loro sé con movimenti visti nell’adulto anche se l’adulto stesso non ne era consapevole”.
Le inconsistenze nel modello della spiegazione dell’imitazione facciale di Meltzoff e Moore, però, sono state evidenziate non appena i risultati della loro ricerca apparvero pubblicati sulla rivista Science. Fin dall’inizio, alcuni altri esperti sullo sviluppo del bambino non furono in grado di replicare i risultati cruciali, segnalando che i neonati, semmai, “copiavano” la protrusione della lingua, ma non altri gesti facciali. In alternativa, proposero che, forse, si trattasse di un semplice riflesso in risposta all’eccitazione anziché di un elaborato meccanismo di imitazione. La prova convincente che i bambini non sono nati con un programma per copiare una serie di espressioni facciali si sarebbe evidenziata in altri esperimenti dal fatto che i più grandi non copiavano alcun gesto facciale, nemmeno la protrusione della lingua.
Ulteriori imprecisioni apparvero quando fu sperimentalmente stabilito che gli adulti cosiddetti “pienamente funzionanti”, cioè persone abbastanza fortunate da aver evitato problemi di sviluppo e danni neurologici, non potevano imitare espressioni facciali se non avevano attraversato un vissuto chiamato “esperienza dello specchio”. Tale esperienza sarebbe quella che ci accade quando facciamo un’azione nello stesso momento in cui vediamo farla. Ad esempio, abbiamo “esperienza speculare” dell’innalzamento dei sopraccigli, se li innalziamo mentre ci guardiamo allo specchio, o se guardiamo noi stessi sorpresi quando cogliamo qualcuno imitando qualcun altro fare qualcosa, oppure quando guardiamo qualcun altro imitare noi. In questo modello interpretativo la ripetizione dell’esperienza speculare dovrebbe portare al miglioramento nell’esecuzione dell’azione imitata. In ogni modo, va detto che ciò che a Meltzoff interessava dimostrare era che l’imitazione, e la meccanica neurale che ne starebbe alla base, procurerebbe una comprensione delle menti altrui, comprensione che a sua volta consentirebbe al bambino di “comprendere” o “modellare” la propria mente e non viceversa .

Dall’idea di un istinto di imitazione nel neonato all’idea che noi umani impariamo a imitare allo stesso modo in cui acquisiamo altre abilità sociali
Analizzando il modello di Meltzoff, Cecilia Heyes considera che se effettivamente noi nascessimo con un kit cognitivo che collegasse “i movimenti percepiti ma invisibili del sé con i movimenti visti ma non definiti dell’altro”, o anche se avessimo sviluppato un tale meccanismo più tardi nell’infanzia, dovremmo essere in grado di migliorare le nostre imitazioni senza esperienza speculare alcuna. A parer suo, non dovrebbe essere necessario sentire il movimento del viso mentre si vede il risultato, perché potremmo, istintivamente, capire come si presenta ogni movimento percepito dall’esterno.
Per diversi decenni, gli psicologi infantili hanno assistito alla diffusione delle inconsistenze del modello senza, però, staccare dalla parete l’immagine fornita da Meltzoff e Moore. Alcune delle ragioni di questo sarebbero, verosimilmente, sociologiche. Meltzoff scrive sull’imitazione del bambino con una prosa popolare avvincente e, infatti, ogni genitore amorevole può, effettivamente, confermare che quando si mostra la lingua a un bambino, al bambino piace restituire il complimento. Infatti, proprio per questa radicata convinzione, non sorprende che nel mondo scientifico l’idea di un istinto d’imitazione diventò rapidamente una pietra miliare. Negli anni ’90, si sostenevano altre affermazioni su come la mente fosse modellata dai geni, molte di queste affermazioni furono incastonate nella psicologia evolutiva. I ricercatori, però, probabilmente se ne rendevano conto che se l’idea dell’istinto di imitazione fosse stata rovesciata, sarebbero venute a meno altre idee preziose che cercavano di rendere conto dello sviluppo cognitivo del bambino.
Malgrado le inconsistenze del modello dell’istinto di imitazione, probabilmente la ragione principale per cui esso non veniva abbandonato era solida e di carattere “scientifico”: effettivamente risulta molto difficile fare esperimenti con i neonati! Quando non dormono, sono spesso disattenti. Quando sono attenti, sono spesso assorti non dalle cose che un ricercatore vorrebbe, ma dall’etichetta del nome sul loro polso, dalla luce tremolante del soffitto o dalla fragranza di un eventuale seno vicino. Quindi, si può considerare che in ogni studio sull’imitazione del neonato, solo un piccolo numero di bambini sarebbe rimasto attento per il tempo necessario per effettuare un qualche rilevamento opportuno per sostenere le ipotesi. Insieme a piccole variazioni nella procedura sperimentale, la natura di questo tipo di campionamento può sempre produrre, facilmente, risultati inconsistenti.
Nonostante queste difficoltà, fino a poco tempo fa, l’idea di un istinto di imitazione nel neonato era ancora ritenuta scientificamente plausibile, anche se solo alcuni studi, particolarmente fortunati o attenti, sono riusciti a documentarne l’ipotesi. Forse il primo studio così ampio e approfondito come per indebolire l’idea dell’istinto di imitazione viene effettuato dall’Università del Queensland, in Australia, nel 2016. Virginia Slaughter ed i suoi colleghi avevano studiato un numero senza precedenti di bambini (106 per l’appunto e numero da cinque a dieci volte superiore della maggior parte degli studi precedenti) in quattro momenti dopo la nascita (a una, tre, sei e nove settimane). Avevano testato l’imitazione di nove gesti e avevano trovato prove per uno solo di questi: la protrusione della lingua. In tutti gli altri casi, i bambini non si mostrarono propensi a produrre il gesto dopo averlo visto di quanto non lo fossero se avessero visto qualcos’altro. Per di più, non avevano mostrato più probabilità di aprire la bocca dopo aver guardato una bocca aperta, per esempio, di quanto lo fossero se avessero visto una faccia triste.
Certo, metodologicamente, non si può provare un negativo, cioè che nessun bambino appena nato sia mai stato in grado di imitare. Ma dopo lo studio del Queensland, sembra che non esistano buone ragioni per credere che i neonati possano copiare i gesti o, quindi, che noi umani abbiamo una capacità innata per l’imitazione.
Quello che ci rimane, invece, è una ricchezza di “prove” che suggeriscono che noi umani impariamo ad imitare, più o meno, allo stesso modo in cui acquisiamo altre abilità sociali. In uno studio del 2018, Carina de Klerk e i suoi colleghi hanno documentato che la capacità di imitare dei bambini dipende da quanto le loro madri imitano le espressioni facciali dei loro bambini. Dunque, più una madre copierebbe i gesti facciali del bambino, più sarebbe probabile che il bambino imiti gli altri.
Questo rilevamento non stabilisce una legge, tuttavia, stando alle inferenze dedotte dal gruppo di Carina de Klerk, le madri che copiano le espressioni facciali dei loro bambini rendono i bambini più bravi a imitare i volti ma, curiosamente, non li rendono più bravi a copiare, ad esempio, i movimenti delle mani. Questa specificità va considerata con attenzione perché potrebbe mostrare che piuttosto sia coinvolto un semplice meccanismo di apprendimento generale. I bambini, semplicemente, non fanno altro che associare la sensazione delle loro sopracciglia sollevate alla vista delle sopracciglia della madre, la sensazione della loro bocca che si apre con la vista di una bocca che si apre. Infatti, essere imitati, sostiene la Heyes, non fa pensare al bambino che l’imitazione sia una buona idea, o che essa gli dia la capacità di imitare qualsiasi azione che gli piace. Piuttosto, nell’esperienza dello specchio del bambino, l’imitazione materna dà un’opportunità per collegare un’immagine visiva di un’azione con un sentimento. Queste connessioni, sostiene la Heyes, sono formate, non da un processo speciale e complicato, ma dall’apprendimento associativo, lo stesso tipo di apprendimento che faceva aumentare la salivazione ai cani di Pavlov quando sentivano una campana.
Nell’arco di pochi decenni, stando ai contributi dalle neuroscienze alla psicologia, è diventato chiaro che l’imitazione non è propriamente un istinto cognitivo. Ciò vuol dire che non siamo nati “programmati” per imitare e che l’imitazione, dunque, non è il risultato di un’informazione racchiusa nei nostri geni. Piuttosto, i bambini imparano ad imitare attraverso l’interazione con altre persone. Genitori, altri adulti e compagni insegnano questa capacità non solo copiando ciò che fa il bambino, ma attraverso giochi che sincronizzano le azioni, reagendo allo stesso modo e allo stesso tempo e, nella maggior parte delle culture, permettendo al bambino di trascorrere del tempo davanti agli specchi, ridacchiando, posando, scrutando, facendo una smorfia, costruendo la gamma di movimenti che potranno copiare in futuro. Che lo specchio sia reale o metaforico, l’esperienza speculare sarebbe ciò che renderebbe i bambini padroni delle imitazioni.
L’imitazione non sarebbe la sola ad aver perso l’aspetto di un istinto cognitivo. La “cheater detection” [rilevazione dell’imbroglione], nota anche come “ragionamento contrattuale sociale”, si riferisce alla possibile capacità umana di individuare persone che non rispettano una regola sociale e che beneficiano di un vantaggio a cui non hanno diritto. Un tempo, questo era un caso paradigmatico nella psicologia evoluzionistica tradizionale, ma sembra non essere più in uso. Gli esperimenti suggeriscono che siamo abbastanza bravi a controllare l’aderenza a una regola quando si riferisce a un contesto sociale familiare, come, ad esempio, l’alcolismo negli adolescenti. Ma non saremmo per niente bravi quando dobbiamo formulare giudizi, strutturalmente identici, su cose più astratte. Tuttavia, balza alla vista che questo vantaggio non si limita alle regole riguardanti l’imbroglio su un contratto sociale. Questo comportamento di “rilevazione dell’imbroglione”, stando alla teoria, si evidenzia anche quando la regola da osservare riguarda la sicurezza piuttosto che i benefici conferiti socialmente. Quindi, invece di essere specialmente esperti nel rilevamento degli imbroglioni, sembra che siamo, semplicemente, bravi a “ragionare” sulle altre persone, un vantaggio sociale dovuto, probabilmente, all’esperienza dell’interazione sociale piuttosto che ad un istinto cognitivo.
Un altro esempio di ciò che fino a poco tempo fa era considerato un istinto cognitivo è la capacità di lettura del pensiero o degli stati mentali altrui, cioè la nostra capacità di pensare a noi stessi e agli altri come se avessimo credenze, desideri, pensieri e sentimenti simili. In breve: la nostra capacità di pensare l’altro “come me”. La lettura della mente, come viene popolarmente chiamata questa capacità, nei nuovi modelli interpretativi delle neuroscienze, assomiglierebbe all’alfabetizzazione, abilità che sappiamo, per certo, non è nei nostri geni. La scrittura, si ipotizza, sarebbe in giro da soli 5.000-6.000 anni, non abbastanza tempo per noi per aver sviluppato un “istinto di lettura”. Come la lettura della scrittura, la lettura del pensiero o degli stati mentali altrui varia attraverso le culture, dipendendo fortemente da certe parti del cervello e sarebbe soggetta, anche, a disturbi dello sviluppo. Le persone con dislessia, ad esempio, hanno difficoltà con la lettura dei testi scritti, e le persone con disturbo dello spettro autistico hanno difficoltà con la lettura del pensiero e degli stati mentali altrui.
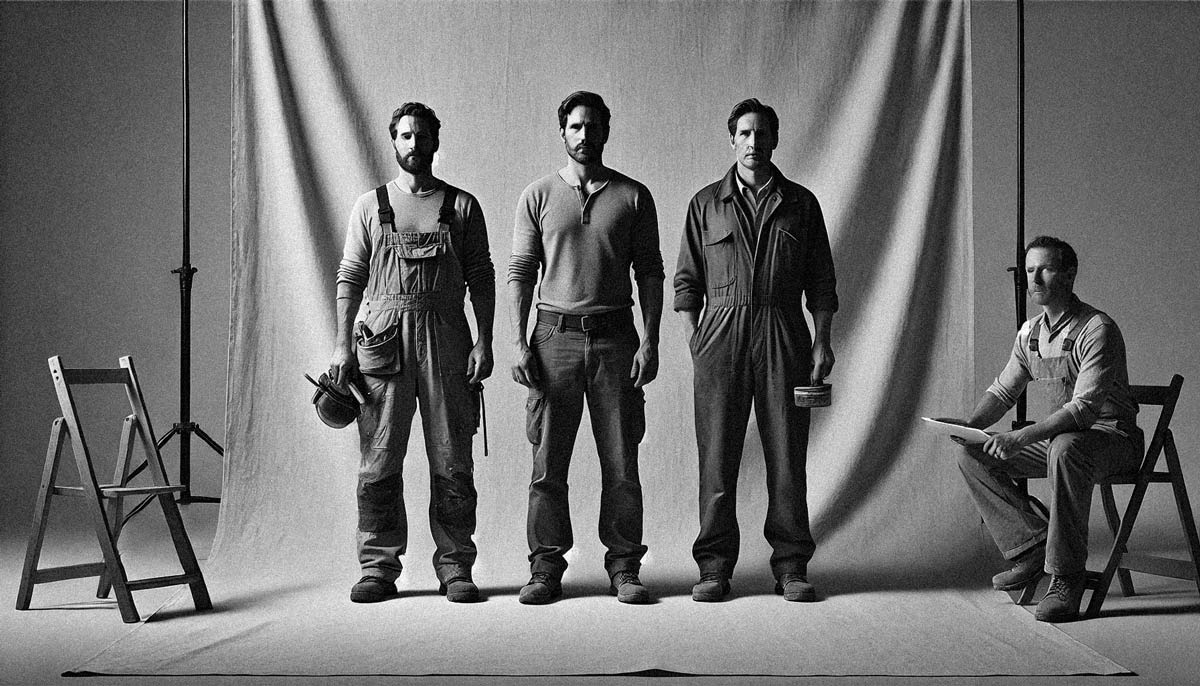
I bambini imparano a leggere gli stati mentali altrui attraverso la conversazione con i loro genitori
Il lavoro degli psicologi Mele Taumoepeau e Ted Ruffman, dell’Università di Otago in New Zealand, suggerisce un ulteriore parallelo tra questi tipi di “alfabetizzazioni” attraverso l’interazione sociale. Nel mondo occidentale, secondo questi studiosi, le madri usano, inavvertitamente, strategie simili per insegnare ai loro figli sia a leggere il pensiero altrui che a leggere la scrittura. Secondo l’interpretazione di questi studiosi, quando le mamme “parlano” con i loro infanti di 15 mesi, ad esempio nel momento di fargli il bagno, nel momento di metterli a letto, mentre li legano al passeggino, le madri accennano più spesso a desideri ed emozioni piuttosto che a credenze e conoscenze. Le madri, stando ai rilevamenti di Taumoepeau & Ruffman, dicono molto sul loro volere e sul loro sentimento e relativamente poco sul pensiero e sul sapere. Quanto frequentemente una madre accenna ai desideri e alle emozioni, secondo le inferenze statistiche degli studiosi, predice la capacità di lettura del pensiero che il suo bambino avrà un anno dopo. Ugualmente, secondo Taumoepeau & Ruffman, quanto più i bambini sentono parlare di desideri ed emozioni entro i 15 mesi, tanto meglio saranno in grado di usare il linguaggio dello stato mentale e di riconoscere le emozioni a 24 mesi. D’altra parte, ci segnala lo studio, nella conversazione con i loro bambini di due anni, le madri menzionano più spesso le credenze e le conoscenze anziché i desideri e le emozioni. A questo punto, sarebbe la frequenza dei riferimenti alle credenze e alla conoscenza a predire la capacità di lettura del pensiero o degli stati mentali del bambino in seguito a 33 mesi.
Questo modello, dunque, suggerisce che i bambini imparano a leggere il pensiero altrui attraverso la conversazione con i loro genitori e che i genitori adottano, inavvertitamente, una strategia come quella usata per insegnare ai bambini a leggere la scrittura. Proprio come i genitori mostrano ai loro figli parole facili da leggere, ad esempio, “gatto”, prima di parole difficili da leggere, come “navigazione”, parleranno, analogamente, ai loro figli dei desideri e delle emozioni, prima di discutere questioni più spinose riguardo convinzioni e conoscenza. I desideri e le emozioni sono stati mentali relativamente facili da leggere, sostiene Cecilia Heyes, perché spesso, stando alle loro statistiche inferenziali, c’è solo un tipo di comportamento o espressione che mostra ciò che una persona desidera o come si sente. Raggiungere qualcosa o piangere, sono abbastanza inequivocabili. Credenze e conoscenze sono invece molto più difficili da leggere perché si manifestano in una varietà di modi.
Anche il linguaggio, una volta ritenuto re degli istinti cognitivi, appare tra gli studiosi sempre più traballante. Nessuno dubita che le specificità di una particolare lingua, per esempio, le parole e le convenzioni idiosincratiche dell’Urdu, siano apprese, imparate. Tuttavia, seguendo l’idea di Noam Chomsky della “grammatica universale”, molti psicologi evoluzionisti hanno ritenuto che l’apprendimento delle specifiche fosse guidato da una conoscenza innata delle regole grammaticali fondamentali. Questa visione del linguaggio fu sostenuta da rilevamenti neurali, genetici e sullo sviluppo che ora vengono capovolti. Ad esempio, il “disturbo specifico del linguaggio”, un disturbo dello sviluppo, che una volta si pensava influenzasse solo l’acquisizione del linguaggio, risulta non essere specifico del linguaggio. I bambini diagnosticati con la condizione lotterebbero, ugualmente, per imparare le sequenze di luci e oggetti, non solo l’ordine delle parole. E non sembra che ci sia un “centro del linguaggio” nel cervello. L’area di Broca nell’emisfero sinistro fu a lungo considerata la sede del linguaggio, ma recenti ricerche condotte dai neuro-scienziati Michael Anderson e Russell Poldrack suggeriscono che il linguaggio sarebbe piuttosto disseminato in tutta la corteccia. Stando ai loro rilevamenti, risulta più probabile che l’area di Broca sia occupata quando le persone svolgono compiti che non implicano il linguaggio rispetto a quando leggono, ascoltano e producono parole. Allo stesso modo, FOXP2, una volta vantato come “gene del linguaggio”, è stato implicato nell’apprendimento in sequenza più in generale. I topi transgenici impiantati con la versione umana di FOXP2 risultano, negli esperimenti condotti, migliori dei loro fratelli a trovare la loro strada intorno a un labirinto.
La perdita di sostegno al coinvolgimento dell’area di Broca e del gene FOXP2 nell’apprendimento del linguaggio, tuttavia, non ha fatto crollare l’intero costrutto dell’istinto del linguaggio, anche se, ad esempio, ora sappiamo che i computer possono imparare le “regole grammaticali” senza alcuna conoscenza grammaticale “incorporata” [“innata”] per cui l’intera struttura del costrutto appare sempre più sbilanciata e insicura.
L’evidenza per la teoria degli “istinti cognitivi” sarebbe ora così debole che avremmo bisogno di un modo completamente nuovo di interpretare ciò che è distintivo della mente umana. I fondatori della psicologia evolutiva forse avevano ragione quando dicevano che il segreto del nostro successo come specie sarebbero i meccanismi computazionali – [detti anche “macchine pensanti”] – specializzati per compiti particolari. Ma questi dispositivi, inclusi l’imitazione, l’interpretazione della mente altrui, il linguaggio e molti altri, non sarebbero innati. Né sarebbero stati progettati dall’evoluzione genetica. Piuttosto, stando alle nuove interpretazioni, queste cosiddette “macchine pensanti” [o meccanismi computazionali] degli umani verrebbero costruite durante l’infanzia attraverso l’interazione sociale e verrebbero modellate, anziché dall’evoluzione genetica, dall’evoluzione culturale. In questa prospettiva, ciò che renderebbe le nostre menti uniche non sarebbero gli istinti cognitivi ma i “gadget cognitivi” o “macchine pensanti”.
Quando si afferma che i gadget cognitivi sono costruiti durante l’infanzia, non si intende sostenere che essi siano costruiti sul nulla. Infatti, le neuroscienze hanno documentato che la mente di un bambino appena nato non è una lavagna vuota. Come altri animali, noi umani nasciamo ereditando, geneticamente, una vasta gamma di abilità e ipotesi sul mondo. Seguendo alcuni modelli delle neuroscienze e della psicologia evolutiva, sembra che siamo dotati di capacità per memorizzare sequenze, controllare i nostri impulsi, imparare le associazioni tra gli eventi e tenere in considerazione diverse cose mentre lavoriamo su di esse. A giudicare da ciò che cattura l’attenzione dei neonati, pare, inoltre, che siamo nati con la predisposizione di prestare maggiore attenzione a ciò che è animato e meno interesse per ciò che avviene con degli oggetti inanimati. Per di più, gli studi sostengono che i volti e le voci siano particolarmente importanti. Queste abilità e credenze farebbero parte del “kit di partenza genetica” per la cognizione umana matura. Queste abilità e predisposizioni sarebbero cruciali perché indirizzano la nostra attenzione ad altre persone e fungerebbero da “gru” nella costruzione dei gadget cognitivi. Ma non sarebbero predisposizioni genetiche “progettate” dall’evoluzione quali meccanismi cognitivi speciali per l’imitazione, l’interpretazione della mente altrui e il linguaggio.
Quando si afferma che i gadget cognitivi sono stati, invece, progettati dall’evoluzione culturale, si vuole attestare qualcosa di molto specifico. Non si intende solo che questi meccanismi cognitivi, estremamente speciali, cambino nel corso delle generazioni e varino da una cultura all’altra. Senza dubbio, entrambe questi aspetti sembrano verificarsi, ma si sta affermando, inoltre, che le nostre “grandi macchine pensanti speciali” [o gadget cognitivi] sono state formate per svolgere il loro lavoro con un particolare tipo di processo darwiniano.
Un processo darwiniano crea un accoppiamento tra un sistema e il suo ambiente, setacciando o selezionando. Il sistema lancia “varianti” – diverse versioni di una cosa – e le varianti interagiscono con il mondo in cui il sistema si trova incorporato. Come risultato di queste interazioni, alcune varianti vivranno mentre altre moriranno. A volte, le varianti sopravvissute hanno un’ulteriore virtù. Non solo sono abili a sopravvivere: fanno anche un lavoro che, se il sistema fosse razionale e senziente, vorrebbe essere fatto bene. In tal caso, la conseguenza della selezione sarebbe l’adattamento: una migliore corrispondenza tra il sistema e il suo ambiente.

Nuove prospettive per spiegare la capacità umana di interpretare la mente altrui
Per argomentare l’idea che i gadget cognitivi sarebbero il risultato dell’evoluzione culturale piuttosto che di una progettazione genetica, prendiamo l’esempio dell’interpretazione della mente altrui. La psicologia evolutiva tradizionalmente ha pensato che la lettura delle intenzioni altrui fosse il risultato della selezione darwiniana operante su diversi geni. Secondo questa immagine, una volta, nell’era del Pleistocene, i nostri antenati non avevano idea delle idee e avrebbero considerato se stessi e l’uno all’altro, forse, come i robot, oggi, potrebbero considerarsi tra loro, senza pensieri e sentimenti sull’altro. Poi, si sarebbe verificata la prima di molte mutazioni genetiche. Queste mutazioni, stando al modello della psicologia evolutiva tradizionale, avrebbero predisposto i portatori a pensare a se stessi e agli altri come se avessero avuto degli stati interni – quelli che ora chiamiamo stati mentali – che avrebbero guidato il loro comportamenti. Alcuni, in questa corrente di pensiero, sembra abbiano congetturato, addirittura, che tali mutazioni sarebbero state iniziate con dei “geni del desiderio”, successivamente trasformatisi in “geni delle convinzioni” e, poi, avrebbero iniziato a far si che le persone riflettessero circa le complesse interazioni tra credenze e desideri più in generale. Qualunque sia la sequenza di mutazioni, secondo questo vecchio modello della psicologia evolutiva, i bambini, presumibilmente, ereditavano la capacità di interpretare le intenzioni altrui dai loro genitori biologici principalmente attraverso il DNA, considerando che un tale dinamismo si sarebbe diffuso fino a quando non si fosse fissato in tutti gli esseri umani. E si sarebbe diffuso perché le persone dotate di geni che davano loro un istinto d’interpretare desideri e intenzioni altrui erano più efficaci di altre nella cooperazione e/o nella competizione e, quindi, avevano più bambini, a cui trasmettevano quei geni.
La storia alternativa, cioè la storia evolutiva culturale, inizia anch’essa con l’ipotesi che i nostri antenati umani non avessero idea delle idee. Tuttavia, l’ipotesi dell’evoluzione culturale suggerisce che quegli antenati potrebbero essere stati un po’ più vicini a noi nel tempo e sottolinea il fatto che avessero altri modi di prevedere e spiegare il comportamento. Come gli altri animali, secondo questo modello interpretativo, i primi umani avrebbero potuto predire il comportamento in modo diretto, imparando che un pugno si ritira appena colpisce. E come quasi tutte le società umane d’oggi, avrebbero fatto affidamento su ruoli e strutture sociali.
Per questo motivo, i sostenitori del modello dei gadget cognitivi, quali risultato dell’evoluzione culturale, considerano che l’idea stessa degli stati mentali sia stata ideata da “uomini” ingegnosi che adoperavano meccanismi cognitivi polivalenti o di scopo generale. Da questa prospettiva, questi “uomini” vennero fuori con una variante culturale: un modo di intuire il comportamento che sarebbe stato ereditato attraverso l’apprendimento sociale, non attraverso il DNA. Questo modello interpretativo vuole che gli adulti tramandavano, attraverso la conversazione, queste modalità intuitive ai più giovani che erano intorno a loro, non solo ai loro bambini. Altre innovazioni, non mutazioni, nel ponderare gli stati mentali vennero ereditate nello stesso modo sociale. In alcuni ambienti, i gadget o dispositivi cognitivi per prevedere e spiegare il comportamento altrui conferiva importanti vantaggi cooperativi e competitivi, consentendo ad alcuni gruppi di dominare con la forza dei numeri, della conversione e dell’immigrazione. In altri ambienti, il gadget di interpretazione degli stati mentali altrui fu molto meno importante. Ad esempio, Cecilia Heyes sostiene che ci sono popolazioni native dell’Oceania e dell’America Centrale che trattano la nostra cosiddetta “mente” come un “contenitore opaco”, raramente invocando credenze e intenzioni degli attori nell’interpretazione del loro comportamento.
Nel caso dell’evoluzione genetica, le varianti del processo darwiniano sono prodotte da mutazione genetica. Dunque, esse sono variazioni che essendo portatrici di successo, sarebbero sopravvissute e trasmesse alle generazioni future mediante la replicazione genetica. Ma nel caso dell’evoluzione culturale, le varianti sono costituite dall’innovazione o dalla “mutazione dello sviluppo”, insegnate e tramandate tra le generazioni tramite l’interazione sociale. In questa prospettiva, i cambiamenti nell’ambiente locale, quali nuovi giochi, tecnologie e pratiche di educazione dei figli, producono differenze nel tipo di gadget cognitivi acquisite dai bambini attraverso l’interazione sociale. Dunque, stando a questo modello interpretativo, i nuovi gadget di successo si diffondono perché le persone con il nuovo dispositivo finiscono per essere ammirate e con la possibilità di trasmettere le loro abilità a un numero maggiore di persone, rispetto alle persone con il modello originale.
L’idea che le nostre menti siano piene di gadget cognitivi si basa su ricerche di antropologi, biologi ed economisti. Questi ambiti di ricerca mostrano che molte credenze e preferenze umane siano modellate dall’evoluzione culturale, come ad esempio la preferenza per famiglie grandi o piccole. Ma forse ciò che si intende affermare è ancora qualcosa di più radicale. Infatti, ciò che si chiede è di accettare la psicologia evolutiva culturale come campo di sapere di riferimento per continuare il processo umano di farci una qualche idea circa le idee che ci abitano o in cui abitiamo. E questa richiesta suggerisce che la cultura modella non solo i prodotti o gli artefatti del pensiero, ma i meccanismi stessi che ci permettono di pensare in primo luogo.
‘Gadget’ costituisce un termine appreso dalla contemporaneità per denominare un dispositivo cognitivo forgiato dall’evoluzione culturale. A differenza dell’istinto, i gadget sono processi cognitivi che ci consentono di prevedere i comportamenti affidati in ruoli e strutture sociali ed elaborati nell’interazione sociale anziché dai geni. Per rendere un’idea chiara della questione si potrebbe dire che come Alexa dipende dalla potenza dei computer collegati, allo stesso modo, i meccanismi cognitivi, tipicamente umani, come l’imitazione, potrebbero dipendere dal potere dei dispositivi cognitivi antichi; cioè sui processi di attenzione, apprendimento, memoria e controllo inibitorio che avremmo geneticamente ereditato dai nostri lontani antenati. I gadget cognitivi sarebbero costruiti da e a partire di questo kit antico. Ma un gadget cognitivo accurato, come è l’imitazione, può ancora rendere le nostre vite molto più semplici: ci permette di lanciare una palla, fare una riverenza o fare una smorfia, soltanto dal fatto di vederla fatta.
Se la teoria dei gadget risulterà idonea, le nuove tecnologie potranno stimolare l’evoluzione culturale rapida delle nostre facoltà mentali
Per onesta intellettuale va riconosciuto che la psicologia evolutiva ha fatto qualcosa di fondamentale importanza. Ci ha insegnato che vedere la mente come una specie di software in esecuzione sull’hardware del cervello potrebbe far progredire la nostra comprensione delle origini della cognizione umana. Ora, sarebbe, però, il momento di fare un ulteriore passo: riconoscere che le nostre app, distintamente umane, sarebbero state modellate dall’evoluzione culturale anziché genetica.
La psicologia evolutiva, considerata nella prospettiva culturale accennata, apre nuove strade alla ricerca futura e alla comprensione di noi stessi. Poiché l’evoluzione culturale è più veloce dell’evoluzione genetica, si può escogitare come costruire nuovi gadget cognitivi guardando alle popolazioni contemporanee e storiche. Oggi non siamo limitati a contare solo su pietre e ossa per intuire come i meccanismi cognitivi siano stati messi insieme dall’evoluzione genetica nel passato del Pleistocene. Attraverso esperimenti di laboratorio e studi sul campo, si può vederli essere costruiti in persone vive oggi. Ad esempio, la ricerca sugli effetti dell’imitazione materna e della conversazione sulla mente del bambino non sta solo indagando come le menti dei bambini vengono messe a punto dall’esperienza. Essa ha, anche, il potenziale per suggerirci o mostrarci come i nuovi gadget o dispositivi cognitivi vengano assemblati da vecchie parti attraverso lo scambio sociale.
La prospettiva dei gadget cognitivi può persino aiutarci a confrontarci con alcuni dei dibattiti sociali e morali che turbano la tecnologia. In che modo la mente affronterà una vita vissuta sempre di più nella realtà virtuale, sui social media o tra i robot umanoidi? La psicologia evolutiva standard afferma che non ce la faremo bene. Abbiamo “menti dell’età della pietra” [ricordiamocelo] costruite per la caccia, il foraggiamento e il contatto fisico con un piccolo numero di persone. La nostra attrezzatura mentale, già superata da circa 300.000 anni, è soggetta a schiantarsi, lasciandoci disorientati e in balia dell’intelligenza artificiale.
La psicologia evolutiva culturale sfida, però, questa visione distopica. I gadget cognitivi sono agili, perché codificati nei nostri ambienti ricchi di cultura e “scaricati” [downloaded] nel corso dell’infanzia. Quindi, se la teoria dei gadget risultasse corretta, le nuove tecnologie potrebbero stimolare la rapida evoluzione culturale delle nostre facoltà mentali. La realtà virtuale potrebbe darci straordinarie capacità di imitazione, superando quelle dei mimici professionisti e degli sportivi che si celebrano per le loro eccezionali capacità. I social media potrebbero darci nuovi modi di pensare alle tribù e alle relazioni intercomunitarie. Vivere e lavorare tra robot potrebbe trasformare le nostre concezioni quotidiane di come funzionano le menti, erodendo la distinzione tra mentale e meccanico, in modo che la “valle inquietante” diventi una “scena pastorale” familiare. Nei giusti ambienti sociali ed economici, le nostre “menti dell’Età dello Spazio” potrebbero germogliare nuovi gadget, perfezionare quelli vecchi e muoversi, agilmente, in qualunque cosa il futuro regga.
- Quello di condizionamento operante è uno dei concetti fondamentali del comportamentismo. Il condizionamento operante è una procedura generale di modifica del comportamento di un organismo, ossia è una modalità attraverso la quale l’organismo “apprende”.
- Anche se nella scienza positiva la mente, in quanto entità immateriale, non esiste, in quest’argomentazione verrà accolta come una costruzione controversa ma, comunque, come qualcosa distinta dal cervello.
- Cecilia Heyes. Cognitive Gadgets: The Cultural Evolution of Thinking. Harvard University Press, 2018
- Psicologa che studia l’evoluzione della mente umana, Senior Research Fellow in Theoretical Life Sciences presso l’All Souls College, professore di psicologia all’Università di Oxford e presidente della Experimental Psychology Society Cecilia Heyes.
- Leandro Herrero. Homo imitans. The Art Of Social Infection: Viral Change In Action. Meetingminds Publishing, UK, 2011
- Leda Cosmides & John Tooby. Evolutionary Psychology: A Primer. Centre for Evolutionary Psychology. University of Santa Barbara, California
Cosmides, L. & Tooby, J. (1997). Dissecting the computational architecture of social inference mechanisms. In: Characterizing human psychological adaptations (Ciba Foundation Symposium #208). Chichester: Wiley. (pp. 132-156).
Cosmides, L. & Tooby, J. (1997). The multimodular nature of human intelligence. In A. Schiebel & J. W. Schopf (Eds.), Origin and evolution of intelligence. Center for the Study of the Evolution and Origin of Life, UCLA. (pp. 71-101).