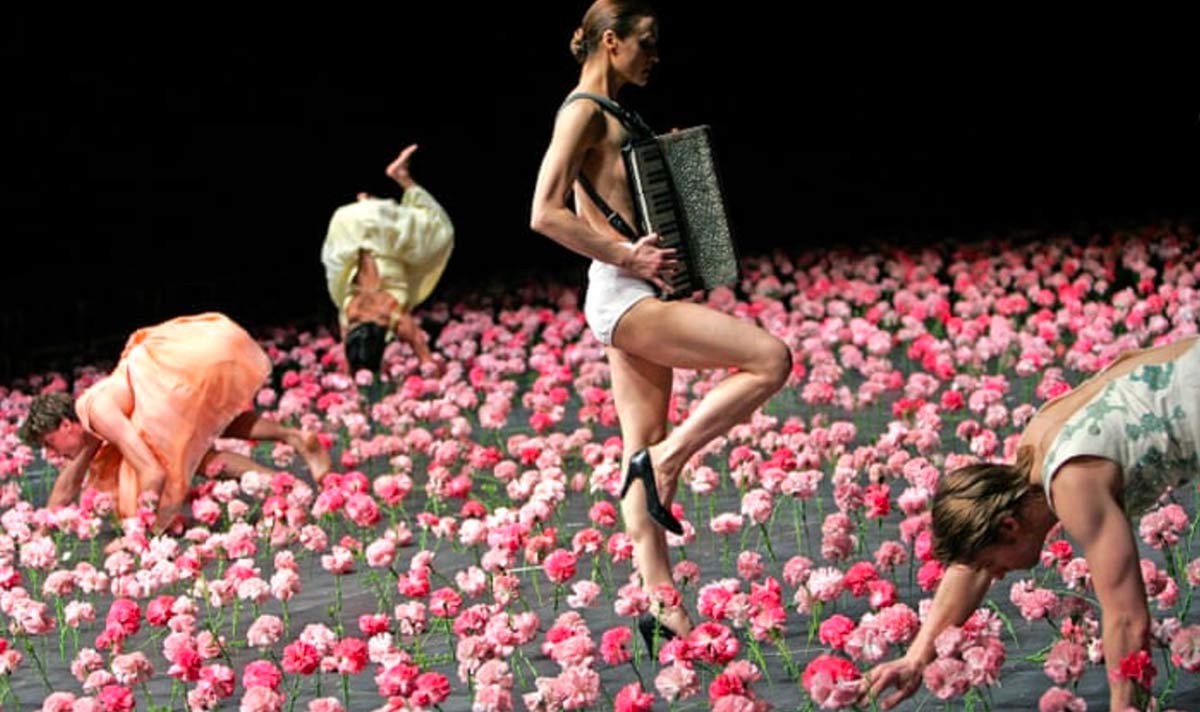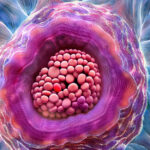BIO – Medicina Costruzione Sociale nella Post-Modernità – Educational Papers • Anno VIII • Numero 30 • Giugno 2019
Normativismo versus naturalismo: vecchie opposizioni concettuali
Le discussioni filosofiche su salute e malattia sono state tradizionalmente dominate dalla disputa tra i così definiti normativisti, secondo i quali, quando ci si ferma ad individuare e analizzare le nozioni nascoste nei nostri concetti quotidiani, la salute risulta, piuttosto che un concetto ineludibilmente valido, un preconcetto o pregiudizio carico di giudizi sociali e culturali, e i cosiddetti naturalisti, come Christopher Boorse, che credono sia possibile arrivare ad una definizione puramente descrittiva o teorica di salute basata sulla funzionalità biologica.
Christopher Boorse, filosofo della medicina, sostiene che la concezione medica della salute come assenza di malattia sia una nozione teorica obiettiva piuttosto che un giudizio di valore. Gli elementi principali di tale nozione sono la funzione biologica e la normalità statistica, in contrasto con varie altre idee prominenti nella letteratura della salute. Nella sua teoria “biostatistica”, propone che le malattie, oltre ad essere lesioni ambientali universali, sono stati interni che “deprimono” una capacità funzionale al di sotto dei livelli tipici della specie. La salute come assenza di malattia sarebbe, quindi, la normalità statistica della funzione, cioè la capacità di eseguire tutte le tipiche funzioni fisiologiche con, almeno, un’efficienza tipica. Questa concezione della salute è, stando a Boorse, libera di ogni giudizio di valore, in quanto essa si basa sull’incontestabile funzionalità biologica. A suo parere, l’opinione che la salute sia un giudizio di valore, sostenuta dalla maggior parte degli studiosi in materia, sembra abbia due fonti: l’assunto che i giudizi sulla salute debbano essere giudizi pratici sul trattamento dei pazienti o un impegno per una salute “positiva” oltre l’assenza di malattia. L’assunto però sarebbe sbagliato e l’impegno potrebbe essere descritto erroneamente.
Oltre alle diatribe concettuali tra normativismo e naturalismo, per il grande pubblico “salute” e “malattia” sono caratteristiche onnipresenti del mondo naturale e non semplici costrutti concettuali culturali o semplici proiezioni di interessi e valori sociali. A questa osservazione convenzionale si può accostare una considerazione critica radicale: anche i valori o pregiudizi sociali sono “naturali”, cioè costruiti, spontaneamente, dalla programmazione in atto nei nostri schemi cognitivi. Certamente, con l’attuale paradigma cognitivo con cui cerchiamo di interpretare il mondo in cui viviamo, i sistemi viventi, in qualche modo, ci appaiono come normativi per cui risulterebbe difficile che il grande pubblico possa pensare alla normalità come un costrutto sociale. Questa convinzione costituisce l’indiscutibile legittimazione assiomatica della nostra idea circa la normalità.
Sebbene queste annose argomentazioni circa la normalità siano state trattate a più riprese nei nostri precedenti BIO Educational Papers, in questa occasione reinterpretiamo il tema seguendo alcuni dei nuovi esponenti accademici della critica della medicina come Jonathan Sholl, Sara Moghaddam-Taaheri e Andreas de Block.

Sfuggendo alla camicia di forza concettuale
I concetti di “media”, “tipico”, “ideale”, “adeguato”, così come l’idea di “normale”, sono costruzioni storiche e, stando a Jonathan Sholl, sarebbe ora che ce ne liberassimo 1. Infatti, sottoponendo il concetto di “normalità” ad una decostruzione, seguendo le discipline della filosofia della scienza e della filosofia della medicina, concentrandosi sui processi socio-cognitivi di “naturalizzazione” dei concetti di salute e malattia, con il contributo delle intuizioni della biologia dei sistemi e dei dibattiti sociologici e antropologici sulla medicalizzazione, così come con i contributi della tradizione dell’epistemologia storica, si palesa, come documenta il professore Sholl, che l’idea di normalità non è che un costrutto medico sociale.
Nel processo di accreditarsi come scienza, il problema delle variazioni tormenta da sempre la medicina. Nel XIX secolo, uno dei fondatori della medicina sperimentale, il fisiologo Claude Bernard, affermò che la variabilità individuale era un ostacolo al giudizio medico. Se si potesse dimostrare che l’anormale sia una vera deviazione quantitativa dal normale, scrisse 2, avremmo la chiave per trattare un dato individuo, non importa quanto lui o lei si allontani dal resto. Dopotutto, se il patologico fosse una deviazione dal normale, allora non solo il fine ma la stessa possibilità dell’atto terapeutico diventerebbe chiara: restituire l’individuo malato, l’organo, la cellula o il sistema a uno stato normale.
Questa visione riduzionista e semplicistica della cura guida molta della ricerca biomedica. Infatti, organismi, cellule, reti di geni e altro, vengono “perturbati” dai ricercatori con l’idea che tale perturbazione possa suggerire come questi sistemi “normalmente” funzionino. I ricercatori assumono che interrompendo e distruggendo i “meccanismi della fisiologia” si possano stabilire standard e sviluppare nuovi trattamenti per restituire una “normalità fisiologica”. Ma di cosa si parla in medicina quando si parla di fisiologia normale? Se, come scrisse la filosofa Sara Moghaddam-Taaheri nel 2011, ritenessimo l’anormalità, non come “rottura col normale” ma come uno stato qualitativamente diverso, sarebbe difficile capire come tali interruzioni possano indicare il metodo di riportare i malati alla salute.
Mentre i ricercatori medici possono perdere punti così sottili, i filosofi della medicina, da anni, analizzano sfumature e lottano per definire ciò che sia normale. Per illustrare queste sfumature che rendono difficile la categorizzazione del normale, Jonathan Scholl suggerisce di pensare ad un esperimento mentale in cui ci richiedessero di considerare le variazioni alle estremità di uno spettro che noi non considereremo patologiche, come avere occhi verdi, essere daltonici, essere estremamente alti o bassi, avere una memoria fotografica o essere uno scrittore di saggi straordinario. Queste variazioni estreme, stando a Sholl, contrastano con condizioni che potrebbero essere problematiche solo in alcuni ambienti, come l’incapacità di riparare i danni UV, con variazioni che svantaggiano solo in alcune culture o periodi temporali, come l’albinismo o l’udire voci che non ci sono, e con variazioni così estreme (ad esempio, la malattia di Tay-Sachs) che impediscono il funzionamento complessivo. Eppure, anche in tali condizioni o variazioni, la cosiddetta vita può trovare un modo. Ad esempio, ci sono individui con un QI elevato e una vita sociale alquanto “normale” nonostante la loro idrocefalia, condizione in cui il liquido eccessivo nei ventricoli del cervello ingrandisce il cranio e spesso causa gravi danni cerebrali. Dunque, con questi accenni presi da Scholl, possiamo chiederci come può la “normalità” essere un concetto scientifico quando il suo spettro è così vasto? Cos’è, davvero, la normalità? Comprendiamo il suo significato? Come ci si conforma alle norme?

Definendo il normale
Il filosofo ceco Jiří Vácha fornì un’utile tassonomia sui vari significati di “normalità” nel 1978 in una sua monografia3 circa la normalità in biologia e medicina. Il termine potrebbe significare “frequente”, nel senso di qualcosa che è comune all’interno di una classe o popolazione, come, per esempio, aver occhi marroni nei paesi mediterranei o occhi azzurri nei paesi nordici. Potrebbe anche significare “media matematica”, come il peso o l’altezza media di una popolazione, spesso rappresentata con la familiare curva o campana, oppure un tipo, come rappresentativo di un gruppo, popolazione o classe. A volte, significa “adeguato”, nel senso di essere libero da difetti, carenza o disordine, e, altre volte, significa “ottimale” nel senso di funzionamento di punta, come, per esempio, essere fisicamente in forma o mentalmente acuto. Oppure, potrebbe riferirsi ad “un’essenza platonica ideale”, come nella perfetta bellezza o nel corpo perfetto platonici. Infine, c’è il nostro uso quotidiano di base del termine, che spesso scivola tra questi diversi significati ed usi, dall’ortodosso e standard a ciò che è previsto e ritenuto socialmente buono.
In qualsiasi gergo o ambiente, il significato specifico di “normale” ha conseguenze importanti, soprattutto se con esso viene associata una posizione privilegiata nel mondo. Qualunque cosa diverga – come avere occhi verdi nel Mediterraneo o sentire voci nel silenzio noto alla collettività – sarebbe anormale in un senso o nell’altro, cioè insolito, raro, atipico, potenzialmente inadeguato, sub-ottimale o carente in qualche modo, per cui ci sarebbe il bisogno di essere riportato ad una qualche norma o normalità. Tuttavia, può essere controverso, o semplicemente banale, patologizzare tali variazioni, innanzitutto se, in qualche modo, sono funzionali.
Quest’intuizione di base ha prestato ambiguità alla parola “normale” in medicina per centinaia di anni. Nel diciannovesimo secolo, proprio mentre Claude Bernard definiva la malattia come una deviazione dalla norma, il matematico Adolphe Quetelet stava applicando statistiche al corpo umano per trovare una serie di “tipi” attraverso una gamma di variazioni individuali. Poiché ogni variazione poteva essere soggetta a questo strumento statistico, sembrava che le medie potessero spiegare qualsiasi cosa. Di conseguenza, altezza, peso, pressione sanguigna, frequenza cardiaca, tassi di nascita e di morte o altro, potevano essere tutti presentati anche in belle curve a campana.
Per Quetelet, queste medie assumevano una vita propria e diventavano non una semplice descrizione della natura, ma diventano “ideali”, cioè quello che dovrebbe essere e, quindi, “prescrittive” o “normative”. L’ormai controverso indice di massa corporea (BMI), spesso usato come misura di salute, era originariamente chiamato l’indice di Quetelet.
Quetelet sosteneva che questi “tipi” [ideali] catturavano “l’homme moyen” [uomo medio], cioè “l’umano ideale” che la natura cercava di concretizzare, l’unico al centro di ciò che la teoria della probabilità chiama “distribuzione gaussiana”. Mentre una tale persona non ha bisogno di esistere realmente in natura, la “figura matematica” è stata vista come il vero standard con cui giudicare le deviazioni come anormali e, quindi, carenti. Di conseguenza, “l’individuo era sinonimo di errore, mentre la persona media rappresentava il vero essere umano.” Insieme al punto di vista di Claude Bernard, questo è stato un passo importante nel privilegio della normalità che vediamo oggi.

Canguilhem e la variabilità degli organismi
Il filosofo Georges Canguilhem, nonostante influenzato da Bernard, nei suoi studi del pensiero medico ha proposto una delle più convincenti critiche all’idea della normalità. Secondo lui, inseguendo il concetto di normalità, gli scienziati e i ricercatori del XIX secolo non erano riusciti a cogliere ciò che la biologia evolutiva proponeva sulla variabilità degli organismi4. In “Le normal et le pathologuique” (1943), Canguilhem descrive l’idea di Charles Darwin secondo cui gli organismi stabiliscono e mantengono regolarità, modelli di funzionamento e comportamento per soddisfare le mutevoli esigenze di vita e sopravvivenza. Canguilhem ha usato il termine “norma” per riferirsi ai diversi processi regolatori, dalla regolazione interna degli ormoni ai regimi dietetici mutevoli, per ricordarci che, indipendentemente da quanto raro o deviante possa sembrare un individuo, potrebbe ancora essere considerato normale, se il suo comportamento gli ha assicurato la sopravvivenza in un determinato ambiente.
In breve, come fa notare Jonathan Sholl, la normalità riguarda l’individuo e il contesto. Nella sua prospettiva, ciò che è normale per un individuo potrebbe essere insopportabile per un altro, e lo stesso individuo potrebbe essere normale in un ambiente e non in un altro. Basta dare un’occhiata alle differenze innate nella capacità di metabolizzare il lattosio o le variazioni acquisite come nel caso degli atleti di resistenza che hanno un cuore ingrossato e una frequenza cardiaca a riposo inferiore al.la media. Tali esempi aiutano ad illustrare che la normalità varia da un individuo all’altro, e, di conseguenza, la semplice presenza di una variazione, o anche un’anomalia, non è sufficiente per comprendere il patologico5.
La relatività ambientale, nella prospettiva di studiosi come Jonathan Sholl e Andreas de Block, sarebbe ovunque. Infatti, ci fanno notare che ci sono individui con ipertensione asintomatica che, spostandosi a quote più elevate, iniziano a soffrire di dolori al petto, nausea o mancanza di respiro a causa del cambiamento. Ci sono quelli che mostrano variazioni nella capacità di auto-ripararsi dai Danni UV della luce solare che vanno da lievi danni alla pelle a tumori e neoplasie potenzialmente letali. Esiste la dislessia, considerata dannosa solo dove la lettura è una pratica culturale necessaria. Anche un determinato ambiente non sarebbe normale né anormale. Sholl e De Block propongono, invece, che sia la relazione tra un individuo e un ambiente a determinare la linea tra variazioni normali e anormali.
Da questa prospettiva, la normalità non è assoluta né universale. Tuttavia, nel pensiero di Canguilhem, tale criticità non dovrebbe mai impedirci di vedere i fenomeni relativi alla salute e alla patologia anche da un punto di vista biologico. Preferibilmente, secondo lui, si dovrebbe vedere salute e malattia attraverso le loro specifiche regolarità fisiologiche, comportamentali e strutturali, le loro catene causali e le loro distinte “norme” biologiche.
A questo proposito, Canguilhem suggerì una distinzione tra quelle che egli definì norme “propulsive” e “repulsive”. Le norme propulsive tollerano le perturbazioni e si adattano in modo flessibile alle mutevoli esigenze, consentono in tal modo all’individuo di superare le sfide. Per esempio, una risposta immunitaria propulsiva comporta la produzione di anticorpi per contrastare i germi e le tossine che arrivano in un determinato ambiente.
Le norme repulsive evitano le perturbazioni e restringono il funzionamento dell’individuo, la loro stessa fragilità richiede un ambiente ristretto. Una risposta immunitaria repulsiva [repellente] agli agenti in arrivo in uno specifico ambiente potrebbe comportare infiammazione con conseguente ipersensibilità e reazioni allergiche esterne, come, ad esempio, il caso di un’anafilassi.
L’approccio induttivo di Canguilhem è in disaccordo con il concetto stesso di normalità come una qualità fissa, caro alla medicina del XIX secolo e ancora oggi così prevalente. Anziché iniziare con una rigida definizione di normalità, da cui far derivare l’anormalità, il metodo di Canguilhem inizia con la fisiologia e, quindi, cerca teorie per spiegare ciò che viene osservato.

Biologia dei sistemi o naturalizzazione
Nell’interpretazione di Sholl, i contributi di Canguilhem hanno prodotto un orientamento nella ricerca che i filosofi della medicina, oggi, chiamano “naturalizzazione”6. In questo paradigma un po’ di chiarezza riguardo la comprensione della salute e della malattia deriva da concetti come robustezza (mantenimento di un sistema nonostante le perturbazioni), plasticità (spostamento tra diversi livelli funzionali), omeodinamica (bilanciamento degli effetti dell’invecchiamento) e fragilità (aumento di sensibilità alle perturbazioni). Questi ed altri concetti correlati dalla biologia dei sistemi – e non l’idea di normalità – catturano ciò che è specifico per la salute e le malattie. In questa prospettiva [alquanto inquietante] potrebbe essere che l’intervento più efficace riguardi il cambiamento nell’ambiente e non nel paziente.
L’approccio della cosiddetta “biologia dei sistemi” o della “naturalizzazione”, come alcuni filosofi della medicina preferiscono chiamarlo, si adatterebbe più precisamente al mondo relativistico in cui le specie cambiano continuamente e organismo e ambiente devono essere sincronizzati [cioè devono raggiungere un nuovo equilibrio]. Secondo questo approccio, i sistemi viventi sono robusti, omeostatici o fragili solo rispetto a specifiche condizioni interne ed esterne. Perciò non si può dire che un sistema immunitario, una rete genetica o un intero organismo sia robusto senza specificare una serie di variabili biologiche e i parametri ambientali da affrontare. Questo porta a concludere che i sistemi viventi sono, esclusivamente, individuali e, veramente, inseparabili dal loro ambiente. E questo, a sua volta, seguendo il ragionamento di Sholl, costringe il mondo medico a chiedersi in relazione a quale ambiente, a quali condizioni, interne e esterne, un individuo possa essere ritenuto sano o malato?
Di conseguenza, l’approccio della “biologia dei sistemi” o della “naturalizzazione” è cruciale per comprendere la salute e curare le malattie. Tale approccio può aiutare a destigmatizzare la malattia, suggerendo che sia la salute che la malattia sono normali, riflettendo solo regolarità e modi di vita distinti. La malattia, precisa Sholl, non è né innaturale né segnala l’assenza di norme: si tratta, semplicemente, di regolarità e modi di vita diversi.
Secondo Sholl e de Block, toglierle lo stigma di innaturale non significa un invito a valorizzare la malattia né significa che si debba vedere la sofferenza come una costruzione benefica o come la modellazione di una personalità o di un carattere, e nemmeno che si debba considerare la malattia un percorso verso l’illuminazione. Invece, come implica l’idea della naturalizzazione, significa solo che dato che salute e malattia sono entrambe condizioni normali dei sistemi viventi, loro sono praticamente uguali o indistinguibili.

Salute Malattia Individuo Ambiente
Vedere la nostra biologia attraverso la lente della naturalizzazione fornisce, anche, secondo i loro sostenitori, una nuova prospettiva sulle preferenze di salute. Mentre la filosofia di Canguilhem implica che spetti all’individuo determinare nella sua relazione con il suo ambiente ciò che è sano, questo non significa che la salute sia semplicemente una questione di scelte soggettive o di concedere agli individui piena autorità, come per esempio, che io preferisco X mentre Lei preferisci Y e, quindi, X è sano per me. Invece, la salute è individuale a causa di come le nostre storie di vita e comportamenti interagiscono con il nostro livello organico, oggi, più documentabile, e quello psichico o mentale, ancora poco conosciuto. La medicina, secondo questa prospettiva, deve quindi sforzarsi di specificare ciò che è oggettivamente preferibile per ogni individuo data la sua biologia, il suo ambiente e modo di vivere.
Preso insieme, quanto detto circa l’approccio della “biologia dei sistemi” o “naturalizzazione” suggerisce che la medicina non può riguardare il ripristino di norme precedenti, che possono non esistere poiché la malattia e il semplice passaggio del tempo modificano irrevocabilmente i sistemi viventi. Né si tratta di cercare di rendere gli individui conformi agli standard e ai trattamenti dettati dalle autorità mediche e dalle linee guida, poiché ciò che è salutare per un individuo o sistema potrebbe danneggiare un altro. Invece, una nuova medicina individualizzata dovrebbe comportare una collaborazione con l’individuo per trovare un nuovo modo di funzionare che sia specifico di quella fisiologia peculiare e dei vincoli e delle possibilità del proprio ambiente. In molti casi, come detto in precedenza, può essere che l’intervento più efficace riguardi il cambiamento dell’ambiente e non del paziente.
Questa nuova prospettiva non può essere stata più critica, date le preoccupazioni che le istituzioni mediche stiano patologizzando la normalità, imponendo, per legge, una forma di trattamento che riflette i valori sociali o politici invece della reale malattia. Questa considerazione ci porta a dire che ciò di cui si ha bisogno è di una filosofia della medicina orientata al paziente e in sintonia con il contesto della storia di vita dell’individuo e l’ambiente in cui vive. Conclusione facile di proclamare, tuttavia lontana a diventare esperienza nella clinica, sia da parte del paziente che del medico stesso.
- Jonathan Sholl. Medicalization. In “50 Key Terms in Contemporary Critical Theory”. pp: 185-190 Editors Joost de Bloois, Stin De Cauwer & Anneleen Masschelein. Publisher Pelckmans Pro, Antwerpen, 2017
- Claude Bernard. PRINCIPES DE MÉDECINE EXPÉRIMENTALE. Ou de l’expérimentation appliquée à la pathologie e à la thérapeutique. 1858-1877
- Jiří Vácha. “Normalcy in biology and medicine”. Monografia molto citata ma solo reperibile in ceco.
- Sholl Jonathan. Contextualizing medical norms: Georges Canguilhem’s surnaturalism. Naturalism in the Philosophy of Health: Issues and Implications. ed. Élodie Giroux. Springer, p. 81-100. 2016
- De Block, Andreas & Sholl Jonathan. Harmless dysfunctions and the problem of normal variation. Defining Mental Disorders: Jerome Wakefield and His Critics. ed. / Luc Faucher; Dennis Forest. The MIT Press, 2016.
- Jonathan Sholl. Escaping the Conceptual Analysis Straightjacket: Pathological Mechanisms and Canguilhem’s Biological Philosophy. In ”Perspectives in Biology and Medicine”, Vol. 58, No. 4, p. 395-418. January 2016