BIO – Medicina Costruzione Sociale nella Post-Modernità – Educational Papers • Anno VIII • Numero 30 • Giugno 2019
Il termine “nazione”
Nel nome di questo trimestrale l’accenno alla postmodernità1 costituisce una modalità di anticipare ai lettori che la sua linea editoriale è quella di decostruire2 l’orizzonte di senso in cui noi popolazioni occidentali siamo state stanziate dal bio-potere della modernità. In quest’orizzonte di senso, difatti, anche realtà sociali che ben potrebbero esprimere il loro carattere di costrutto, quali nazione, medicina, gender, classi sociali e via dicendo, ci vengono presentati come eventi o accadimenti naturali, cioè come dimensioni che sono capitate senza l’intervento della cultura umana. Di conseguenza, trattandosi di un tentativo decostruzionista, molte delle argomentazioni di BIO Educational Papers possono sembrare un modo di problematizzare le nozioni fondamentali con cui interpretiamo ancora le nostre esistenze e ciò che consideriamo sia la realtà.
Nell’orizzonte di senso che ci ha fornito il bio-potere della modernità noi troviamo ogni definizione utile a convogliare le nostre energie, cancellare i nostri dubbi e ad istallarci nelle nostre certezze, cioè le sue certezze. Le sue definizioni hanno come matrice una specifica e paradossale visione del mondo: il continuum creazionismo – scientismo. Questa, cosiddetta, “visione del mondo”, però, non è soltanto scritta nei libri, testimoniata in tutte le manifestazioni artistiche e, anche, alla guida del modo con cui la scienza interroga il mondo, essa costituisce il programma dottrinale, cioè di senso, con cui noi popolazioni umane “vediamo” e “sentiamo” il mondo. Una di queste nozioni, così scontata che ci sembra appartenere ad un ordine naturale piuttosto che sociale delle cose, è quella di nazione.
Nell’uso quotidiano, impropriamente, i termini “nazione”, “stato” e “paese” vengono usati spesso come sinonimi per indicare un territorio controllato da un singolo governo, o gli abitanti di quel territorio o il governo stesso. Questa confusione, però, può rivelarsi molto redditizia nei racconti, quasi mitologici, dei gestori e/o aspiranti gestori della bio-politica. In senso specifico, tuttavia, il costrutto “nazione” dovrebbe indicare le popolazioni, il costrutto paese dovrebbe far riferimento al territorio e il costrutto stato dovrebbe riferirsi alla legittima istituzione amministrativa. Nonostante al giorno d’oggi molte nazioni coincidano con uno stato, le cose non sono sempre andate così in passato e ancora oggi esistono nazioni, cioè insieme di popolazioni, senza stato, come il caso dei curdi, e ci sono, anche, degli stati formati da più nazioni, come la Svizzera. Vi sono anche stati senza nazione, come il Vaticano.
Convenzionalmente, il termine nazione, si riferisce, effettivamente, ad una comunità di popolazioni che condividono alcune caratteristiche quali una lingua, un luogo geografico, racconti sulle origini, tradizioni, cultura, appartenenze etniche, istituzioni ed, eventualmente, un governo. Una differente corrente di pensiero include tra le caratteristiche necessarie di una nazione il concetto di sangue o di «consanguineità», come nel caso dell’appartenenza alla Repubblica Italiana, all’Austria, alla Germania, ad Israele o al Giappone mediante l’istituzione dell’ius sanguinis.
Alcuni pensatori, come Jürgen Habermas, considerando obsoleta la nozione tradizionale di nazione, si riferiscono ad essa come ad un contratto sociale tra popolazioni che si riconoscerebbero in una Costituzione comune. Ciò prevede un profondo senso del “noi”, pace e ordine al suo interno, una serie di simboli e miti comuni, la garanzia di protezione e la consapevolezza della persistenza nel tempo della nazione rispetto ai singoli individui. Questo senso del “noi” si sviluppa nella popolazione spesso grazie al confronto con un “gruppo esterno”, che alle volte assume la forma di un odiato nemico. Gli stati nazionali europei, ad esempio, hanno forgiato le loro identità nell’ostilità rispetto al vicino. Certamente, l’idea di nazione comporta una ricca eredità di ricordi e il consenso riguardo le tradizioni e la visione convenzionale del mondo. Ne consegue che la nazione esiste finché trova posto nella mente e nel cuore delle popolazioni che la compongono. Infatti, l’idea di nazione matura nel tempo.
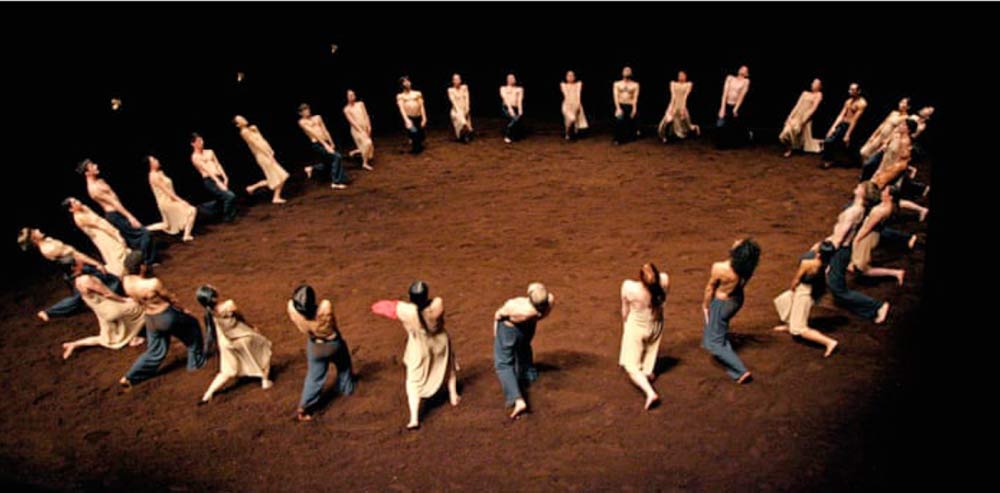
Lo Stato-nazione come modello da seguire non sempre risulta possibile
Al di là di questi crediti circa cosa si intenda con il termine nazione, l’esperienza storica dello stato-nazione, consolidatasi nelle grandi potenze della geopolitica mondiale (USA, Europa, Russia e Cina), rende, per entropia o per calcolo, l’ordinamento dello stato nazione un modello da seguire, pur se la sua replica o costruzione non sempre risulti possibile. Infatti, basterebbe uno sguardo attento per realizzare che alcune nazioni si disgregano, spesso lungo le loro linee etniche, mentre altre reggono insieme per decenni e secoli, nonostante governino una popolazione etnicamente diversificata. Perché, allora, la costruzione della nazione ha avuto successo in alcuni luoghi mentre è fallita in altri?
- L’attuale situazione della Siria illustra le conseguenze della mancata costruzione della nazione. Al di fuori dei riflettori dei media, anche il Sud Sudan e la Repubblica Centrafricana hanno vissuto esperienze simili negli ultimi anni. In alcuni paesi ricchi e democratici dell’Europa occidentale, come Spagna, Belgio e Regno Unito, i movimenti secessionisti di lunga data hanno ripreso vigore. Nei prossimi anni potremmo assistere agli eventi che potrebbero condurre questi movimenti a riuscire a distruggere questi stati. D’altra parte, risulta interessante notare che non c’è movimento secessionista tra i parlanti cantonesi della Cina meridionale o tra i Tamil dell’India. Ugualmente richiama l’attenzione che nessun politico serio abbia mai messo in discussione l’unità nazionale in paesi così diversi come la Svizzera o il Burkina Faso?
- Una spiegazione sociologica, sufficientemente documentata, del perché la costruzione della nazione abbia successo in alcuni luoghi mentre fallisce in altri, è stata proposta di recente da Andreas Wimmer, professore di sociologia e filosofia politica della Columbia University, nella sua opera “Nation Building: Why Some Countries Come Together While Others Fall Apart”3. Dare alcune possibili risposte a questa domanda l’ha portato a cercare di definire, in primis, ciò che si intende per “costruzione della nazione”.
La teoria di Andreas Wimmer circa la tenuta di una nazione
Nella sua interpretazione, la nazione andrebbe oltre la semplice esistenza di un paese indipendente o stato sovrano con una bandiera, un inno ed un esercito. Al riguardo lui ci fa notare che alcuni vecchi paesi, come il Belgio, non si sono mai uniti come nazione, mentre altri stati di più recente fondazione, come l’India, lo hanno fatto. Queste realtà hanno condotto gli studiosi in materia a sostenere che ci sono due aspetti nella costruzione nazionale: l’estensione delle alleanze politiche attraverso il territorio di un paese e l’identificazione e la lealtà con le istituzioni dello stato, indipendentemente da chi governa al momento. Il primo costituirebbe l’aspetto dell’integrazione politica, il secondo l’aspetto politico-identitario. Per favorire entrambi, sostengono gli esperti, i legami politici tra i cittadini e lo stato dovrebbero raggiungere e ridimensionare le divisioni etniche.
In effetti, i legami di alleanza collegano i governi nazionali con i singoli cittadini, a volte attraverso organizzazioni intermediarie non prettamente politiche, come associazioni di volontariato, partiti, ordini professionali, società sportive ecc. Questi legami, idealmente, collegano i cittadini in reti di alleanze in qualche modo incentrate sullo Stato. In tali circostanze, i cittadini si vedono rappresentati al centro del potere, anche se il loro partito preferito o patrono politico non stia, effettivamente, occupando una delle sedi del governo. In quest’interpretazione, intellettuali, élite politiche e individuo medio, alla fine, vengono visti tutti come cittadini, come membri uguali della comunità nazionale, indipendentemente dalla loro appartenenza razziale o etnica.
Organizzazioni non prettamente politiche, come associazioni di volontariato o club sportivi, che attraversano un intero territorio di un paese hanno, in effetti, il potenziale di depoliticizzare eventuali divisioni etniche. La politica, in un tale contesto, non viene percepita come un gioco a somma zero in cui i gruppi etnici lottano per il controllo dello stato. Invece, le questioni politiche più sostanziali riguardo a ciò che lo Stato dovrebbe, effettivamente, fare vengono, in questa interpretazione della costruzione della nazione, in primo piano nel dibattito. È, certamente, abbastanza probabile che coalizioni politiche includenti favoriscano un senso di appartenenza allo Stato e promuovano l’ideale di uno scopo collettivo al di là della propria famiglia, villaggio, clan o professione. Conformemente, si può ipotizzare che i cittadini che si identifichino con la loro nazione sarebbero meno resistenti4 al pagamento delle tasse5, più propensi a sostenere le politiche di welfare e verrebbero governati da Stati più efficienti6. Stando agli esperti della scuola di Wimmer, coalizioni politiche includenti, che comprendono minoranze e maggioranze etniche, riducono, notevolmente, il rischio di guerra civile7 e promuovono la crescita economica8.
Negli Stati Uniti, la maggior parte dei politici coinvolti nella politica estera identifica la costruzione della nazione con la democratizzazione. Credono9 che la democrazia sia lo strumento migliore per raggiungere la coesione politica nel resto del mondo. L’argomentazione alla base di questa posizione sarebbe questa: le elezioni democratiche attirerebbero diversi gruppi etnici verso il centro politico e incoraggerebbero i politici a costruire ampie coalizioni al di là del pool di elettori che condividono il proprio background etnico. È, certamente, evidente che buona parte degli stati governati dalle élite di una piccola minoranza, come l’Alawi del presidente siriano Bashar al-Assad, falliscono nella costruzione della nazione. Ugualmente è evidente che i paesi democratici hanno, in media, più probabilità di includere rappresentanti delle minoranze nelle loro coalizioni di governo.
Tuttavia, le coalizioni di governo non diventano, necessariamente, più includenti nel tempo dopo che un paese è passato alla, cosiddetta, democrazia. In molti paesi recentemente democratizzati, le maggioranze etniche arrivano al potere per vendicarsi sull’élite finora dominanti e sulle loro comunità etniche. L’Iraq dopo la caduta di Saddam Hussein lo ha dimostrato chiaramente: gran parte del sostegno interno di Al-Qaeda e di quello successivo dell’ISIS provenivano dalle ex élite Baath e da tribù sunnite scontente per la loro perdita di potere. Ugualmente, gli Stati Uniti di America mantennero la schiavitù durante i primi 70 anni della sua esistenza democratica e per un altro secolo, dopo l’emancipazione, negarono agli afroamericani qualsiasi forma significativa di rappresentazione politica. L’associazione tra democrazia e inclusione avviene perché i paesi che sono già governati da una coalizione includente si democratizzano prima, e più facilmente, dei regimi di esclusione che spesso combattono la democrazia. In altre parole, il postulato di Wimmer è che la democrazia non costruisce, certamente, le nazioni ma che le nazioni già costruite hanno maggiori probabilità di passare alla democrazia.

I tre fattori fondamentali nella teoria di Wimmer sulla costruzione della nazione
Nella teoria di Andreas Wimmer, riguardo la costruzione della nazione, piuttosto che elezioni libere e competitive, si rende necessario evidenziare altri tre fattori che si svilupperebbero lentamente nel corso di generazioni ma che risulterebbero più efficaci nella costruzione di legami politici attraverso linee etniche diverse.
1. Modo in cui i legami politici vengono organizzati
Il primo fattore ad incidere nella costruzione efficace di una nazione è quello del modo in cui i legami politici vengono organizzati. A questo riguardo, la sua teoria sostiene che sia più facile stabilire alleanze politiche attraverso le divisioni etniche se queste alleanze possono basarsi su organizzazioni di volontariato o associazioni civili già esistenti, come circoli di lettura, circoli sportivi, sindacati e così via. Infatti, spesso le organizzazioni di volontariato stipulano alleanze orizzontali le une con le altre estendendosi in ampi territori. Al contrario, nei sistemi di patrocinio gerarchico, i legami proliferano verticalmente tra clienti e clienti che, a loro volta, diventano i clienti di altri clienti più in basso nella piramide del potere e dell’influenza. Stando al ragionamento di Wimmer, le reti di alleanze costruite su organizzazioni di volontariato possono, quindi, proliferare attraverso il territorio, creare organizzazioni ombrello e raggiungere, più facilmente, le divisioni etniche rispetto ai sistemi di clientelismo.
La documentazione di Wimmer è puntuale nel segnalare il ruolo che tali organizzazioni di volontariato e/o ricreative abbiano giocato, specialmente nei primi anni di esistenza moderna di un paese, ad esempio, in gran parte dell’Europa dopo che una monarchia assolutista veniva rovesciata o dopo che una ex colonia era diventata indipendente, come in gran parte del resto del mondo. Se esiste già una fitta rete di tali organizzazioni, i nuovi detentori del potere possono, secondo Wimmer, fare affidamento su queste reti per mobilitare i sostenitori e reclutare leader politici. In queste circostanze, l’esclusione politica delle minoranze etniche, o anche delle maggioranze, diventa meno probabile poiché le organizzazioni di volontariato in passato hanno sviluppato filiali in diverse parti del paese abitate da diverse comunità etniche. In questa prospettiva, si può sostenere che quando i nuovi leader si affidano a queste organizzazioni civili preesistenti per ottenere il sostegno politico è probabile che questa stessa leadership venga reclutata anche da diverse comunità etniche.
Un confronto tra Svizzera e Belgio, due paesi di dimensioni simili, con una complessità di composizione linguistica della popolazione simile e livelli comparabili di sviluppo economico, fornisce un esempio. In Svizzera, organizzazioni della società civile – come club di tiro, circoli di lettura e società corali – si erano sviluppate, su tutto il territorio, tra la fine del XVIII e la prima metà del XIX secolo. Si diffusero in modo uniforme in tutto il paese, perché le industrie moderne emersero in tutte le principali regioni e perché le città-stato della Svizzera non avevano né la capacità né la motivazione per sopprimerle. In Belgio, al contrario, Napoleone, così come Guglielmo VI d’Orange-Nassau che gli succedette, riconobbe il potenziale rivoluzionario di tali associazioni volontarie e le soppressero. Ancora più importante, le associazioni che esistevano in Belgio erano limitate alle regioni e ai segmenti della popolazione di lingua francese, più economicamente sviluppati e più istruiti.
Nel 1831, quando il Belgio divenne indipendente dal regno dei Paesi Bassi, la maggior parte dei nuovi governanti del paese erano stati a lungo membri di queste reti associative di lingua francese. Senza pensarci troppo, dichiararono il francese lingua ufficiale dell’amministrazione, dell’esercito e della magistratura. Nonostante formassero una leggera maggioranza demografica, quelli che parlavano solo fiammingo non facevano parte di queste reti, ed erano quindi esclusi dal governo centrale. Fino alla fine del XIX secolo, i fiamminghi furono governati come una colonia interna del Belgio francofono. La prima costruzione della nazione fallì, il divario linguistico divenne pesantemente politicizzato nel corso del XX secolo e il paese, senza il ruolo dell’Unione Europea, sembra sempre prossimo alla rottura.
In Svizzera la transizione verso lo stato-nazione avvenne dopo una breve guerra civile nel 1848. Le élite liberali che vinsero la guerra e dominarono il paese si affidarono, per generazioni, alle reti interregionali e multietniche delle organizzazioni della società civile per reclutare seguaci e capi. La struttura di potere emergente includeva, quindi, maggioranze e minoranze. Fin dall’inizio, ogni gruppo linguistico era rappresentato al più alto livello di governo e all’amministrazione federale, approssimativamente secondo le dimensioni della sua popolazione. Di nuovo senza pensarci troppo, francese, tedesco e italiano diventarono lingue ufficiali dello stato. Durante la maggior parte della successiva storia politica della Svizzera, e fino ad oggi, la diversità linguistica rimase un non-problema politico e ci sarebbero poche prove che i burocrati abbiano favorito i parenti etnici quando assegnavano le risorse.

2. Modalità dello scambio di risorse tra cittadini e stato
Il secondo fattore di importanza nella costruzione della nazione riguarda le modalità dello scambio di risorse tra cittadini e stato. Nell’interpretazione di Wimmer, ci sono maggiori probabilità che i cittadini sostengano politicamente un governo che fornisce beni pubblici in cambio di tassazione. Il suo postulato è che se le tasse vengono scambiate per beni pubblici, cambia la natura della relazione tra governo e cittadini. Essa non sarebbe più basata sull’estrazione sotto la minaccia della forza – come avvenne in genere con i regimi più coercitivi che hanno preceduto lo stato nazionale, come un regno assolutista, un governatore imperiale o un’amministrazione coloniale. Da questa prospettiva interpretativa, più un governo è capace di fornire beni pubblici in tutte le regioni di un paese, più sarà attraente come partner di scambio e più cittadini vorranno stabilire un’alleanza con esso. Di conseguenza, la coalizione di governo rifletterà strutture di alleanza comprendenti della diversità etnica della popolazione.
Un confronto tra Somalia e Botswana offre un chiarimento. Sono entrambi paesi aridi con piattaforme economiche simili, basate sull’esportazione di bestiame e storie coloniali comparabili. Quando Botswana divenne un paese indipendente nel 1966, il suo governo creò e gestì, in modo efficiente, opportunità di esportazione per allevatori di bestiame, allargò enormemente infrastrutture di trasporto, scuole e strutture sanitarie e creò programmi di emergenza per i periodi di siccità che ciclicamente devastavano l’economia del bestiame. Di questi beni pubblici hanno beneficiato allo stesso modo tutte le regioni. Esistono poche prove del fatto che i burocrati abbiano favorito i loro parenti etnici quando assegnavano queste risorse a villaggi o distretti. Corrispondentemente, il partito al governo ottenne il sostegno tra regioni e collegi elettorali, che a loro volta si tradusse in un parlamento e un governo in cui le maggioranze e le minoranze etniche erano rappresentate, approssimativamente, in base alla loro popolazione. Questa configurazione di potenza inclusiva avrebbe, quindi, prodotto, nel tempo, una forte identificazione con lo stato e con la maggioranza Tswana, con sempre più cittadini delle minoranze etniche assimilati e identificati con la maggioranza Tswana.
In Somalia, le condizioni per la costruzione della nazione attraverso la fornitura di beni pubblici sono state molto meno favorevoli. Dopo che le ex colonie britanniche e italiane furono unificate in una Somalia indipendente, lo stato aveva pochissima capacità di fornire beni pubblici alla popolazione. Gli aiuti esteri – piuttosto che le tasse o i dazi doganali – alimentarono la burocrazia in rapida espansione. Quando si trattava di distribuire progetti governativi, i burocrati favorirono coloro che potevano permettersi le tangenti più alte o membri del proprio clan e lignaggio. Il colpo di stato militare del 1969 di Mohamed Siad Barre modificò solo temporaneamente questo stato di cose. Data la mancanza di capacità istituzionali, il regime di Barre cercò di fornire beni pubblici attraverso campagne di breve durata, in stile militare, come insegnare alla popolazione nomade a leggere e scrivere o la consegna di aiuti alle vittime della siccità. Nessuna alleanza politica duratura, centrata sul governo centrale, poteva essere costruita in questo modo. Invece, Barre basò sempre più il suo dominio su seguaci fedeli della sua stessa coalizione di clan e su quella di sua madre. Ben presto quelli esclusi dai circoli interni del potere presero le armi. Logoranti alleanze mutevoli di clan, signori della guerra l’uno contro l’altro e decenni di guerra civile hanno caratterizzato la storia recente del paese.

3. Modo in cui le popolazioni comunicano tra loro
Il terzo aspetto delle relazioni di alleanza tra cittadini e stato nella costruzione della nazione si riferisce al modo in cui le popolazioni comunicano tra loro. Stando alla teoria di Wimmer, risulta più facile stabilire legami tra regioni e divisioni etniche se le popolazioni e gli individui possono conversare in una lingua condivisa. Ciò ridurrebbe i “costi di transazione”, vale a dire lo sforzo necessario per comprendere le rispettive intenzioni, per risolvere i disaccordi e per negoziare un compromesso, tutti fattori cruciali per costruire relazioni durature basate sulla fiducia. Pertanto, stando a Wimmer, le divisioni linguistiche rallenterebbero la diffusione delle reti politiche attraverso il territorio di un paese.
Cercando di sostenere la sua teoria, Wimmer segnala che gli ultimi due secoli di storia in Cina e in Russia illustrano come un mezzo di comunicazione condiviso faciliti la costruzione della nazione. All’inizio del XIX secolo sia Cina che Russia si trascinavano generazioni di dominio assolutistico delle dinastie imperiali, includevano popolazioni enormi e diverse e non erano mai state sottoposte a dominazioni straniere. La popolazione cinese parlava molte lingue diverse, il che avrebbe dovuto rendere più difficile la costruzione della nazione. Tuttavia, comunicazioni ufficiali, giornali e libri venivano scritti utilizzando gli stessi logogrammi [caratteri], cioè le unità minime di significato utilizzate nelle lingue della Cina. Questo tipo di “alfabeto” non era più vicino a nessuna delle varie lingue parlate ma consentiva alle popolazioni provenienti da diversi angoli del vasto paese di capirsi senza difficoltà. L’omogeneità scritturale ha anche permesso allo Stato, durante tutto il periodo imperiale, di reclutare burocrati, attraverso un sistema di esami scritti, da tutti gli angoli del paese. Di conseguenza, l’élite burocratica cinese era poliglotta, come la popolazione in generale e quando il totalitarismo imperiale iniziò a sciogliersi, il paese si frantumò lungo linee di frattura linguistiche ma i logogrammi o unità minime di significato erano i medesimi.
Lo stesso può essere detto riguardo le fazioni politiche formatesi tra quest’élite burocratica, uomini che non sarebbero stati in grado di capirsi l’uno con l’altro parlando, potevano, comunque, partecipare per iscritto allo scambio di idee e a formare alleanze politiche. Lo stesso vale per le associazioni repubblicane anti-imperiali emerse nella Cina del tardo XIX secolo. Sono state raggiunte da persone che parlavano lingue diverse e provenivano da tutta la Cina. Nel 1911 questi gruppi salirono al potere sotto il Kuomintang e rovesciarono la dinastia imperiale. La leadership del Kuomintang era, quindi, linguisticamente diversa, come le élite dominanti sotto la dinastia Qing. Il Partito Comunista, che prese il potere nel 1949, aveva anche reclutato dirigenti da tutta Cina che parlavano diverse lingue madri. Data la natura inclusiva e multilingue delle coalizioni di governo, dai Qing al regime del Kuomintang e fino alla Cina comunista contemporanea, le minoranze linguistiche di lingua non mandarina tra i cinesi Han non avevano motivo di separarsi da Cina e creare uno Stato sotto il loro controllo. Generazioni di legami politici attraverso divisioni linguistiche permisero agli intellettuali e ai politici nazionalisti di immaginare la nazione Han come multilingue, ma etnicamente omogenea. Il nazionalismo linguistico, ci segnala Wimmer, non ha mai inveito tra la maggioranza Han [cinese] della Cina.
Nell’impero russo, le differenze linguistiche, stando alle considerazioni di Wimmer, avrebbero giocato un ruolo molto diverso. L’impero si divise due volte lungo linee etno-linguistiche: dopo la rivoluzione bolscevica nell’ottobre 1917 e di nuovo nel disgelo delle riforme del leader dell’Unione Sovietica Mikhail Gorbaciov intorno al 1989. I costruttori delle nazioni russe e sovietiche affrontarono una sfida molto più grande perché le varie lingue – dal finlandese al tedesco, dal russo al turco, dal coreano al rumeno – non erano solo di radici linguistiche completamente diverse, ma erano scritte anche in diversi alfabeti, tra cui il cirillico, il latino, l’arabo e il mongolo. Quando l’era della politica di massa si è insediata nella Russia del XIX secolo, le reti di alleanze si sono raggruppate lungo le divisioni linguistiche. Allora come oggi, raggiungere un pubblico (alfabetizzato) attraverso i media della propaganda richiedeva un alfabeto e un linguaggio comuni. I partiti popolari, emersi durante l’ultimo decennio del XIX e i primi decenni del XX secolo, si rivolgevano, quindi, esclusivamente a specifiche comunità linguistiche (armeni, georgiani, finlandesi, polacchi ed altri). Oppure assomigliavano a un mosaico di reti di alleanze linguisticamente confinate. La coscienza nazionale prese in Russia la forma in dozzine di stampi separati, linguisticamente definiti – piuttosto che in un’identità globale paragonabile a quella dei cinesi Han.
La politica delle nazionalità sovietiche dopo la rivoluzione del 1917 cimentò questo stato di cose insegnando alle minoranze a leggere e scrivere e educandole, fino agli anni ’50, nella loro lingua. Sotto la direzione di Mosca, le élite delle minoranze furono autorizzate a governare le nuove province e distretti dell’Unione Sovietica definiti linguisticamente. Di conseguenza, le reti di alleanza clientelistiche emergenti si sono formate all’interno di compartimenti etnici separati. Le minoranze non russe erano fortemente sottorappresentate nella direzione del partito, i ranghi più alti della burocrazia e dell’esercito, erano tutti dominati dai russi. Non sorprende, quindi, che i leader dell’URSS non siano stati in grado di forgiare un “popolo sovietico” integrato quando, sotto la guida di Nikita Khrushchev circa 40 anni dopo la rivoluzione, hanno cercato di passare a una politica più assimilazionista. Politicamente, l’Unione Sovietica continuò a somigliare a un mosaico di reti di alleanze etniche. Quando il dominio di Mosca iniziò a sciogliersi durante Gorbaciov, il paese si fratturò lungo queste faglie linguistiche negli stati indipendenti di Lettonia, Georgia, Kazakistan e così via.

I retaggi degli stati centralizzati costruiti prima dell’età della politica di massa nella teoria di Wimmer
Guardando indietro nella storia, ci si potrebbe chiedere perché alcuni paesi abbiano sviluppato un linguaggio o una scrittura [o alfabeto] uniforme mentre altri no, e perché alcuni governi siano stati in grado di fornire beni pubblici attraverso il territorio mentre altri no. Stando a Wimmer, sia la capacità di gestione delle diversità linguistiche che la capacità di fornire beni pubblici sono profondamente influenzate dai retaggi degli stati centralizzati già costruiti prima dell’età della politica di massa ambientata alla fine del XIX secolo. Questo periodo si riferisce al lasso di tempo della colonizzazione di questi paesi da parte degli imperi occidentali e giapponese. Laddove nei decenni precedenti si erano sviluppate politiche fortemente centralizzate, emersero amministrazioni burocratiche che avrebbero imparato come integrare organicamente e controllare politicamente le varie regioni dello stato.
I governi, sia quelli degli stati coloniali sia quelli degli stati nazionali di nuova formazione che li succedettero, potevano contare su questo know-how e infrastrutture burocratiche per fornire beni pubblici equamente tra le regioni. Nel lungo periodo, tali stati, altamente centralizzati, avrebbero anche incoraggiato le élite periferiche e i loro seguaci ad adottare la lingua (o nel caso cinese la scrittura) delle élite centrali. Imparare la lingua dei circoli dominanti nella capitale era, in teoria, un modo efficace per promuovere le loro carriere e interessi, e – per il soggetto medio – si sarebbe dimostrato anche vantaggioso parlare la lingua dei burocrati che interferivano, concretamente, nella loro vita quotidiana.
Ad esempio, nel Botswana precoloniale, una serie di regni centralizzati e strettamente integrati erano emersi dal XVII secolo in poi. Erano tutti governati da nobiluomini di lingua tswana. Il governo indipendente, postcoloniale, integrò questi regni nel suo sistema amministrativo riducendo il potere dei re, facendo loro e le loro piccole burocrazie parte della struttura governativa. In questo modo, i regni fornirono al nuovo governo la legittimità di governare. Il nuovo presidente del paese era lui stesso un re10 e incoraggiò i cittadini a rispettare le regole dello stato moderno. Quest’integrazione amministrativa e legittimità di governo avrebbero, nell’interpretazione di Wimmer, facilitato, sensibilmente, la fornitura di beni pubblici da parte dei governi postcoloniali. I regni promossero anche, dal periodo precoloniale fino ai giorni nostri, l’assimilazione delle popolazioni non Tswana, che avevano ancora formato una maggioranza demografica nella maggior parte dei regni nel XIX secolo, nella cultura e nella lingua dominante dei Tswana, che ora rappresenta una solida maggioranza. Dall’esperienza del Botswana si desume che una infrastruttura politica consolidata e un linguaggio uniforme rendono più facile la costruzione della nazione.
Nella storia della Somalia, contrariamente all’esperienza del Botswana, nessuno stato capace di governare la maggioranza nomade del paese è mai emerso. Ciò rappresenta, secondo Wimmer, un notevole ostacolo alla fornitura di beni pubblici post-coloniali. Effettivamente, il governo somalo indipendente ha governato su una popolazione mai abituata allo stato e mai ha contato su una classe dirigente che, piuttosto che servire alle proprie famiglie e ai propri clan, avesse imparato a servire il bene pubblico.
In Cina, un livello straordinariamente elevato di centralizzazione politica nel corso dei millenni fornì lo sfondo per l’emersione e l’adozione, a livello di impero, di un sistema di scrittura condiviso tra tutte le lingue parlate. Tale centralizzazione politica avrebbe anche incoraggiato una vasta gamma di élite politiche, provenienti da tutta la Cina, ad adottare i canoni neo-confuciani dell’impero. Secoli di amministrazione altamente centralizzata e burocratica avevano lasciato, concretamente, un retaggio di infrastrutture organizzative che il governo comunista poté utilizzare per fornire alla popolazione beni pubblici dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Queste esperienze portano Wimmer, Cederman & Min a sostenere che la duplice eredità di un’infrastruttura burocratico – politica stabilita e di una scrittura condivisa, non garantisce di per sé l’integrazione politica attraverso le divisioni etniche ma rende molto più facile il compito dei moderni costruttori di nazioni.

Postille alla teoria di Wimmer sulla costruzione della nazione
Gli esempi individuati da Wimmer, Cederman e Min, non spiegano però come le associazioni volontarie, la fornitura di beni pubblici e la comunicazione interagiscano tra loro o si sostituiscano l’una con l’altra. I somali, per esempio, parlano tutti la stessa lingua, mentre la Svizzera è linguisticamente più varia – eppure le due storie di costruzione della nazione divergono in direzioni opposte. Ci sono anche altri fattori che potrebbero ostacolare o favorire la costruzione di una nazione. Molti storici sostengono che l’esperienza coloniale fa la differenza. Somalia e Botswana hanno entrambi sofferto delle politiche di divisione e di dominio delle potenze coloniali, che avrebbero dovuto rendere più difficile il compito di integrazione politica nazionale una volta che le potenze coloniali se ne andarono ma è stato così solo in Somalia.
Gli economisti potrebbero sostenere che la costruzione della nazione è, principalmente, una questione di sviluppo economico. La Svizzera, assomiglierebbe più alla Somalia se il suo settore di esportazione non avesse avuto successo e se non fosse diventato un centro globale altamente redditizio per le banche e le assicurazioni? Potrebbe anche essere più facile costruire nazioni in paesi come la Svizzera, dove le differenze religiose e i confini linguistici non si sovrappongono ma si rafforzano a vicenda. Nella Russia dei Romanov, al contrario, la maggior parte delle minoranze linguistiche aderì ad una religione diversa dalla maggioranza ortodossa di lingua russa.
Infine, si potrebbe prendere una prospettiva più pragmatica e considerare che la costruzione della nazione avrebbe successo laddove i paesi abbiano combattuto molte guerre con altri paesi, legando le loro popolazioni insieme attraverso sacrifici condivisi. Allo stesso modo, potrebbe essere che i governi europei abbiano costruito le loro nazioni più facilmente perché secoli di aggiustamenti ai confini e pulizie etniche avrebbero portato a popolazioni più omogenee e, dunque, più facili da integrare in una politica nazionale.
Ovviamente, il passato non può essere progettato in modo retrospettivo. Non si può creare uno stato centralizzato, stile XIX – XX secolo, che favorisca la costruzione della “nazione” durante il XXI secolo. Né può la capacità di uno stato di fornire beni pubblici essere migliorata in un paio di anni. Una popolazione ha bisogno di almeno due generazioni per diventare fluente in una nuova lingua di comunicazione. Anche le organizzazioni di volontariato, attorno alle quali le alleanze politiche si possono unite, non mettono radici in una società nel breve periodo. Per questi tre fattori cruciali che, stando alla teoria di Wimmer, facilitano la costruzione della cosiddetta nazione, il tempo si misura in generazioni, non in anni. Ricostruire stati falliti o costruire delle nazioni non può, quindi, essere fatto entro il periodo di tempo di una presidenza statunitense o di due.
Sarebbe, certamente, una contraddizione in termini non aderire all’idea che i beni pubblici siano forniti al meglio dai governi nazionali e locali. Compagnie private, ONG [straniere], eserciti o contractor che intervengono nella fornitura di beni pubblici potrebbero, a volte, essere economicamente più efficienti. Ma la fornitura di beni pubblici da parte di forze esterne non fa molto per rafforzare la legittimità di un governo nazionale. Lo rivela il Survey of the Afghan People, condotto annualmente dalla Asia Foundation dal 2006. I progetti di fornitura di beni pubblici realizzati da stranieri avrebbero reso gli afgani meno soddisfatti del proprio governo nazionale, rispetto ai progetti attuati dalle agenzie governative. Anche i progetti stranieri non sarebbero altrettanto efficaci nel motivare i cittadini a rivolgersi alle istituzioni governative per risolvere le loro dispute locali, piuttosto che alle autorità tradizionali o ai signori della guerra. Ancora più scoraggiante, il sondaggio rivela che gli afghani sono più propensi a giustificare le violenze commesse dai talebani quando vivono in distretti in cui gli stranieri hanno sponsorizzato progetti di fornitura di beni pubblici. In altre parole, i progetti stranieri di fornitura di beni pubblici potrebbero aver perso il “cuore e la mente” degli afghani, piuttosto che guadagnarseli. Interpretando queste informazioni si può asserire che costruire nazioni dall’esterno è quasi impossibile. Il sostegno estero alle organizzazioni della società civile può portare a reazioni contrarie alle influenze straniere con le loro interferenze politiche. Anche il recente giro di vite sulle ONG finanziate da fondi esteri in molti paesi dell’Europa orientale è solo un esempio dei rischi corsi da una strategia di coltivazione delle organizzazioni della società civile dall’esterno.
Pochi osservatori odierni nutrono l’illusione che aiutare la costruzione della nazione in luoghi lontani sia un compito facile. I responsabili politici dovrebbero pertanto respingere l’idea che sia legittimo e fattibile “insegnare ad altre persone a governarsi”, come Francis Fukuyama ha asserito in un articolo per The Atlantic nel gennaio 2004 . Costruire nazioni dall’esterno, cioè esportare orizzonti di senso appartenenti ad una visione moderna della vita e del reale dove insediare nuove popolazioni, risulta, oggi, una formalità non necessaria dinanzi all’avanzata del mercato.
- Nella postmodernità l’interpretazione della realtà percepita è quella di una costruzione e convenzione culturale e sociale. La modernità presupponeva, con il suo rappresentazionalismo, l’accesso diretto della mente umana, nelle sue operazioni cognitive, ad una realtà oggettiva e, dunque, conoscibile e passibile di essere annessa, specularmente, nei compartimenti della conoscenza umana stessa. Praticamente, secondo questa prospettiva, con la quale la maggior parte di noi ancora codifica la propria esperienza esistenziale, malattia, terapia, nazione, famiglia, conoscenza e via dicendo sono ciò che una natura, fuori dalla storia e di carattere universale, rispecchia, direttamente, nella mente umana. Dunque, la postmodernità, piuttosto che ad un insieme di verità decretate da una realtà oggettiva, conoscibile senza interpretazioni da parte di un soggetto, fa riferimento ad un corpus di istituzioni, più o meno formali, che fonda le sue svariate attività in assiomi, teoresi, modelli di realtà, simulazioni, probabilità biostatistiche e pratiche adattive convenzionali.
- La decostruzione nel senso heideggeriano costituisce un’interpretazione degli eventi, mettendo in luce i presupposti impliciti, i pregiudizi nascosti, le contraddizioni latenti della cultura e del linguaggio che non troppo consapevolmente “abitiamo”.
- Andreas Wimmer. Nation Building: Why Some Countries Come Together While Others Fall Apart. Princeton University Press, 2018
- Kai Konrad & Salmai Qari. The Last Refuge of a Scoundrel? Patriotism and Tax Compliance. In “Economica”, vol. 79, Issue 315, pp. 516-533, 2012
- Salmai Qari, Kai Konrad & Benny Geys. Patriotism, taxation and international mobility. In “ Public Choice”, vol. 151, Issue 3-4, pp. 695-717, June 2012
- Pelle Ahlerup & Gustav Hansson. Nationalism and government effectiveness. In “Journal of Comparative Economics”, vol. 39, Issue 3, pp. 431-451, 2011
- Andreas Wimmer, Lars-Erik Cederman & Brian Min. Ethnic Politics and Armed Conflict: A Configurational Analysis of a New Global Data Set. In “American Sociological Review”, Vol. 74, Issue 2, pp. 316-337, April 2009
- Alberto Alesina, Stelios Michalopoulos & Elias Papaioannou. Ethnic Inequality. In “Journal of Political Economy”, Vol. 104, Num. 2, April 2016
- James Dobbins, John G. McGinn, Keith Crane, Seth G. Jones, Rollie Lal, Andrew Rathmell, Rachel Swanger and Anga Timilsina. America’s role in nation-building from Germany to Iraq. RAND, 2003
- Sir Seretse Khama, già re della tribù tswana dei Bangwato e capo del Partito Democratico del Botswana, la cui moglie Ruth Williams era una bianca di origine anglosassone nata a Londra.








