BIO – Medicina Costruzione Sociale nella Post-Modernità – Educational Papers • Anno XIV • Numero 53 • Marzo 2025
Editoriale
Care lettrici, cari lettori,
Viviamo in tempi a brevissimi termini. Le nostre società sono dominate da un continuum di politica, affari e media, tutti concentrati, nei loro conflitti d’interessi, ad offrirci la loro opinione sulla rilevanza del momento presente, piuttosto che ad argomentazioni articolate sulle tendenze e sui paradigmi a lungo termine che stando modellando, veramente, il nostro mondo.
In BIO Educational Papers Medicina Costruzione Sociale nella Post-Modernità Retroscena confidiamo nell’avere una visione a lungo termine. Ciò significa che ci dedichiamo all’esplorazione di idee perenni, spiegate da esperti: non alle notizie del momento, ma alle correnti e le domande più profonde che animano i nostri tempi.
I media moderni riportano piuttosto ciò che accade nel presente, ma ignorano le lezioni della storia e trascurano le conseguenze future. Il nostro obiettivo è esplorare le idee che contano: non solo oggi, ma a lungo termine. Ci piace dilatare il tempo come lo fa il paleontologo, il geologo. Siamo convinti di dover autointerpretarci e reinterpretare la vita e il mondo con valori, radicalmente, secolarizzanti e senza crudeli ottimismi.
In questo senso vi sto chiedendo, anche, di realizzare l’importanza che per noi riveste la vostra fiducia in BIO Educational Papers. Come sapete BIO affronta questioni senza tempo, eppure urgentemente rilevanti oggi: le radici storiche della geopolitica odierna, l’etica mutevole della medicina, le sfide esistenziali più profonde dell’intelligenza artificiale, il significato della salute mentale e il futuro del mondo naturale.
Ma può essere difficile sostenere questo lavoro di fronte a sfide fuori dal nostro controllo. Le principali piattaforme di social media sono diventate attivamente ostili alla pubblicazione ponderata e indipendente. Il ricambio e il teatro del ciclo delle notizie di ogni genere, e non solo politiche, sono progettati per assorbire l’attenzione di tutti con poco spazio per la riflessione e l’analisi.
Quelli che ci leggono regolarmente ci esortano a restare fedeli al nostro lavoro e ci dicono che apprezzano intimamente il senso di orizzonti espansivi che forniamo, che dà loro suggerimenti su come proseguire nella quotidianità, formandoci, simultaneamente, per affrontare i grandi mutamenti in atto. Siamo un progetto editoriale senza scopo di lucro, senza pubblicità e aperti alla complessità dei tempi evolutivi.
Il motivo per cui possiamo avere una visione a lungo termine è dovuto al sostegno economico filantropico di questo progetto editoriale da parte del gruppo CeMON Generiamo Salute e, certamente, ai lettori che ci ringraziamo per sostenere moralmente il nostro lavoro. Crediamo che una visione a breve termine offuschi la conoscenza e scoraggi la sua complessità.
Guardando oltre il presente, possiamo comprendere meglio noi stessi e il mondo in cui viviamo.
Rinaldo Octavio Vargas, direttore.
L’amore nel tempo della fama narcisistica di YouTube & TikTok
Guidando su una delle strade trafficate e mal tenute di Livorno, mi sono trovato in una situazione che si potrebbe osservare, più tranquillamente, attraverso numerosi video di cattivi conducenti su YouTube: un conducente, per il quale tutto il resto del traffico, apparentemente, aveva cessato di esistere, si è infilato con sicurezza in una corsia che occupavo già. Dopo una rapida manovra, che probabilmente mi ha risparmiato di recitare una parte in uno dei video sopra menzionati, ho detto, forse più forte del necessario, a nessuno in particolare: “Questo testa di … è consapevole di qualcosa che non sia la sua testa di …?”
Poiché il mio carattere pende verso all’atteggiamento filosofico tendo a essere piuttosto scarso nel lasciar andare le idee, in particolare quelle senza buone risposte, ma il mio incontro ravvicinato con la fama di YouTube mi ha portato a rendermi conto del fenomeno sociale e a considerare altri casi di quella che è stata definita sindrome del personaggio principale (SPP)1 o, forse, più fastidiosamente, energia del protagonista. Non si tratta di una diagnosi clinica, piuttosto di una denominazione coniata nell’ambito dell’antropologia, della psicologia, della filosofia e della sociologia. Si tratta di un modo di collocarsi in relazione agli altri, e reso popolare da numerose piattaforme di social media, come ho imparato dalla filosofa Anna Gotlib. Un altro modo di comprendere la nozione sarebbe, naturalmente, immaginare la sindrome del personaggio principale come una tendenza a vedere la propria vita come una storia in cui uno è protagonista nel ruolo centrale, con tutti gli altri attorno che sarebbero personaggi secondari nella migliore delle ipotesi.
In un tale modo di collocarsi nel mondo, solo le prospettive, i desideri, gli amori, gli odi e le opinioni della star contano, mentre quelli degli altri, nei ruoli di supporto, sarebbero relegati alla periferia della consapevolezza, come direbbe la Gotlib. I personaggi principali agiscono mentre tutti gli altri reagiscono. I personaggi principali richiedono attenzione e il resto di noi farebbe meglio a obbedire.
Probabilmente avete già sentito del comportamento del Personaggio Principale [Main Character], o forse ne siete stati testimoni online o di persona. Ragionevolmente, riuscite a ricostruire nella vostra memoria scene come questa: una Tiktoker e i suoi follower mettono da parte, fisicamente, quegli scomodi extra che rovinano i loro selfie, e poi pubblicano le loro lamentele sui social media.
Un uomo nella metropolitana affollata di Milano guarda una trasmissione sportiva ad alto volume senza cuffie, ignorando le richieste degli altri pendolari di abbassare il volume. Questa non è una semplice maleducazione: nel mondo strettamente circoscritto dei personaggi principali, il resto di noi sarebbe soltanto degli insignificanti fantasmi che si intromettono nei loro spazi. Simili ai pezzi degli scacchi, o forse alle figure animatroniche, abbiamo una prerogativa solo nello sviluppo della storia del Personaggio Principale (PP). Nel linguaggio corrente, siamo personaggi non giocanti (PNG), un termine che ha avuto origine nei tradizionali giochi da tavolo per descrivere personaggi non controllati da un giocatore, ma piuttosto dal dungeon master, come sostiene Anna Gotlib2.
Nei videogiochi, i personaggi non giocatori (PNG) sono i personaggi con un insieme di comportamenti predeterminati, o determinati algoritmicamente, controllati dal computer. Piuttosto che soggetti con una volontà e un intento, i PNG sono lì per aiutare il PP nella sua ricerca, per intersecarsi con il Personaggio Principale in modi preimpostati o, semplicemente, per rimanere in silenzio: una specie di oggetto di scena, o forse mobili a forma umana, una parte dello scenario, come sostengono Susanna Flock, Robin Klengel, Leonhard Müllner, Michael Stumpf nel loro pungente saggio Does capitalism make ‘non-playable characters’ of us all? An uncanny exploration3. Un altro modo di vedere i Personaggi Non Giocatori potrebbe essere quello di immaginare ciò che il filosofo David Chalmers, nel suo saggio The philosophy of virtual reality4, chiama uno zombie filosofico, o p-zombie, un essere che, sebbene fisicamente identico ad un normale essere umano, non avrebbe esperienza cosciente. Se un p-zombie ride, non è perché trova qualcosa di divertente: il suo comportamento è puramente imitativo del vero individuo (personaggio principale!). Per qualcuno convinto della propria identità di Personaggio Principale o Main Character, come vengono chiamati nel vernacolo di coloro che contano, il resto di noi sarebbe, forse, solo tanti zombie.
Mentre il p-zombie di Chalmers fa parte di un’ipotesi filosofica interessata alla natura della mente e della coscienza, l’interpretazione non filosofica delle persone come PNG (Personaggi Non Giocatori) sarebbe profondamente preoccupante dal punto di vista morale. In effetti, si consideri che negli ambiti dell’etica e della psicologia morale, una delle idee centrali che gli studiosi hanno cercato di spiegare e rendere più vivide è che la moralità sia qualcosa che facciamo insieme e che le nostre idee su chi siamo richiedano la partecipazione impegnata reciproca e un’apertura empatica, non solo sull’agire morale reciproco, ma, altresì, ai vicendevoli stati emotivi. Questi assiomi, stando a Chalmers, sono vincoli fondamentali per il nostro mondo di vita condiviso. Da questa prospettiva della filosofia morale, dovremmo vedere gli altri come pienamente umani ed essere impegnati gli uni con gli altri come esseri morali per comprendere chi siamo e chi siamo in relazione agli altri e al mondo.
Ma la narrazione del personaggio principale nega tutte queste possibilità. È distruttiva per la visione di noi umani come, essenzialmente, relazionali e interdipendenti e rappresenta una minaccia per due fondamentali esperienze dell’essere umano: la prima è la connessione con gli altri; la seconda è l’amore.
Per contrastare le obiezioni secondo cui le mie preoccupazioni potrebbero essere soltanto un semplice caso di disallineamento generazionale (un pre-Gen X confuso che fraintende le prospettive della Gen Z), suggerisco di considerare che la Sindrome del Personaggio Principale sia pensata come rischiosa proprio perché non sembra essere una moda passeggera e non è, in effetti, una questione limitata alla prospettiva politica o al gruppo sociale di una generazione: anzi, la sua influenza si estende ben oltre TikTok e si trova nel mondo degli affari, nel mondo accademico e nelle sale del potere.
Buona parte degli studiosi di filosofia morale, sono convinti sostenitori della visione secondo cui i sé siano qualcosa che creiamo insieme, attraverso storie condivise. Ma cosa sono, queste storie condivise, queste narrazioni di noi come persone? In breve, tutto ciò che può essere letto, detto, ascoltato, scritto, visto o altrimenti espresso, e questo include sicuramente i social media. Nel raccontare storie, creiamo e riveliamo chi pensiamo di essere; nell’ascoltare le storie degli altri, aiutiamo a plasmarli e sostenerli come persone. Le storie sono, quindi, fondamentali per il modo in cui vediamo il mondo e il nostro posto in esso, e attraverso di esse possiamo renderci moralmente intelligibili a noi stessi e agli altri.
Ed è anche qui che ci imbattiamo in un altro problema. Mettendo da parte le critiche all’interno della filosofia stessa di una visione narrativa della moralità come epistemicamente inaffidabile e, complessivamente, priva di principi fondanti ontologici, ci sono anche preoccupazioni che riguardano più direttamente il nostro argomento. In effetti, si rende pienamente plausibile domandarci, se i social media sono una sorta di narrazione, a questo punto onnipresente, i narrativisti dei social media, possono difenderla sulle stesse basi di altri modi narrativi di comprendere noi stessi e il mondo? Se la risposta della società a questa domanda è “sì“, allora perché passare tutto questo tempo a preoccuparci della sindrome del personaggio principale e delle sue numerose storie?
La risposta ha a che fare, stando a Gotlib, con i tipi di storie che offre la sindrome del personaggio principale. Da un lato, gli approcci narrativi alla moralità e all’identità si concentrano sia sul parlare che sull’ascoltare, sulla condivisione e sull’assorbimento, sottolineando l’importanza della multivocalità, del discorso condiviso, dell’intelligibilità reciproca. Puntano, presumibilmente, verso il significato morale, non solo delle proprie storie ma, anche, delle narrazioni degli altri come guide per comprendere l’interdipendenza fondamentale delle identità umane.
D’altro canto, in realtà, le narrazioni narrate dal personaggio principale hanno scarso interesse o pazienza per le storie degli altri e, effettivamente, sarebbero tutt’altro che interdipendenti. Non si preoccupano della reciproca intelligibilità. Solo il personaggio principale, la sua prospettiva, la sua storia e il suo sé solitario contano. In questa versione dell’individualità narrativa, c’è spazio solo per il singolo parlante e per la sua cronaca, singolarmente importante.

Fermatevi e guardatemi! Il monomito della vita trionfante!
In effetti, come sostiene la filosofa bioeticista Hilde Lindemann nel suo saggio Damaged identities, narrative repair5, alcune narrazioni possono creare spazi di danno morale che sarebbero proprio nocivi per l’identità sia dell’oratore che del suo pubblico, e distruttivi per la possibilità di un universo morale condiviso. Sia Gotlib che Lindemann affermano che le narrazioni che emergono dal fenomeno della sindrome del personaggio protagonista siano proprio di questo tipo pernicioso.
La sindrome del personaggio principale offre, secondo loro, il tipo sbagliato di storie: dannose, isolanti, solipsistiche, amorali. È una narrazione che inizia, in gran parte, con la presunta superiorità dell’auto celebrazione del personaggio principale. Mentre i personaggi protagonisti sono esseri singolarmente importanti nella loro mente, questa rilevanza si presenta in molti modi. Cominciamo con il solito colpevole, l’intrattenimento e i social media, dove possono essere spesso trovati nel loro ambiente nativo. L’hashtag personaggio principale è stato visualizzato, per lo più con approvazione, milioni di volte su TikTok e su Instagram, e #maincharacter (protagonista) accompagna decine di migliaia di post. Ogni giorno, agli abitanti dei social media viene venduta l’idea che diventare gli eroi delle loro vite sia l’unica cosa che conta. Pretendiamo dagli altri, sia direttamente che indirettamente: “Fermatevi e guardatemi!”
Ma non si tratta solo dei social media: molti dei nostri film, in particolare quelli rivolti a un pubblico più giovane, si concentrano sulla ricerca centrale dell’eroe, che deve superare, essere più furbo, più veloce, più performante e, alla fine, gloriarsi della sua vittoria. Il viaggio di questo eroe, questo monomito, è in piena mostra nei film di Hunger Games (2012-2023)6, nella serie di film di Neil Burger, Divergent (2014-16)7, nell’universo di Spider-Man (2018-24) e nei film di The Maze Runner (2014-18), che sono solo una manciata di esempi relativamente recenti ma dove ce ne può essere solo uno: il personaggio protagonista.
Assorbendo questi messaggi e imitando le voci fuori campo dei personaggi principali nei film e in altri media, noi cerchiamo anche di narrare le nostre vite, spesso direttamente nei nostri smartphone, e di condividere con il mondo tutti i modi in cui i nostri percorsi, le nostre trame, le nostre prospettive sono quelle che contano, quelli a cui vale la pena prestare attenzione; le nostre voci sono le voci che vale la pena ascoltare. Pretendiamo dagli altri, sia direttamente che indirettamente: “Fermatevi e guardate me, l’eroe!”
Ma non è un po’ troppo semplicistico attribuire tutta la colpa ai media per la nostra crescente ossessione per la nostra importanza? Molto prima di Internet, per non parlare dei social media, le persone hanno condiviso le loro narrazioni in diari, autobiografie, poesie e così via, portando le loro vite al centro della scena. Generazioni di occidentali sono state istruite a perseguire la felicità, individuale, personale, prima di tutto. Ci sono sempre stati solipsisti, narcisisti, sociopatici e semplici cercatori di attenzione: i social media non hanno inventato la tipologia io-prima.
E tuttavia, possiamo aiutarci in quest’epoca di accesso globale agli altri e a noi stessi? Possiamo noi, beh, alcuni di noi, comunque, resistere alla tentazione di chiedere un pubblico quando ce n’è sempre uno lì, pronto a essere coinvolto? Forse no. Come ha affermato lo psicologo clinico Michael G Wetter in un’intervista a Newsweek nel 2021, la sindrome del personaggio principale sarebbe:
l’inevitabile conseguenza del naturale desiderio umano di essere riconosciuti e convalidati che si fonde con la tecnologia, in rapida evoluzione, che consente un’autopromozione immediata e diffusa… Coloro che mostrano caratteristiche coerenti con l’esperienza della sindrome del personaggio principale tendono a voler creare una narrazione che dipende da un pubblico per convalidare la loro storia. A cosa serve una storia o un film se non c’è un pubblico?
I media, social e non, avrebbero reso più facile, più economico e, soprattutto, più socialmente accettabile recitare i nostri monomiti di protagonisti. Possiamo caricare foto, video, interi film su noi stessi e possiamo scegliere come essere percepiti attraverso ingegnosi trucchi di luce e angolazioni, app e filtri che raccontano esattamente le storie che vogliamo raccontare. Tutto questo perché vogliamo essere notati, vogliamo essere visti e visti come qualcuno che conta, come la persona principale che conta. Come ha osservato l’influencer Ashley Ward su TikTok nel 2020:
Devi iniziare a romanticizzare la tua vita. Devi iniziare a pensare a te stesso come al personaggio principale, perché altrimenti la vita continuerà a scorrerti accanto e tutte le piccole cose che la rendono così bella continueranno a passare inosservate.
Non essere visti, non essere notati come qualcuno che conta significa relegare sé stessi al dominio dei Personaggi Non Giocanti: un nessuno, un nulla, un manichino senza una storia personale o un’autodeterminazione, che attraversa un copione pre-scritto di una vita grigia e insignificante. Essere visti, d’altra parte, significherebbe pure essere felici. Questa felicità richiede di assicurarsi che gli altri sappiano che si è felici, di successo, migliori di quei Personaggi Non Giocanti, in altre parole, richiede una cura costante della propria immagine, della propria narrazione, di sé stessi. Se uno non è il main character o protagonista, qualcun altro sicuramente lo sarà. Questo sarebbe, per molti, semplicemente un destino intollerabile.
Naturalmente, dare la colpa a tutti i media, o solo ai social media, per la diffusione della sindrome del protagonista sarebbe inesatto. Forse non sorprende che i personaggi principali siano emersi in luoghi in cui la psicopatia e il narcisismo avrebbero sempre regnato: in politica, nel mondo accademico e in altre istituzioni pubbliche. Da un presidente che afferma che solo io posso risolvere le numerose crisi della nazione, a personaggi dei media manipolatori e delle notizie che insistono sul fatto che loro e solo loro starebbero dicendo la verità, a politici che non riescono – o non vogliono – distinguere tra essere famosi ed essere efficaci, la sindrome del protagonista sta diventando la norma.

Il lungo terminismo o la sindrome di Elon Musk
Ci sarebbero comportamenti ancora peggiori, sostiene Anna Gotlib, in particolare all’interno del mondo accademico, oppure quelli abbastanza solipsistici da definirsi leader sociali o, peggio ancora, leader di pensiero /thought leader.8. In modo caratteristico, stando a lei, l’energia del personaggio principale sembra essere particolarmente forte in un sottogruppo di accademici e nei filantropi che li finanziano, che amano definirsi longtermists9 o altruisti efficaci.
Spinti all’azione in gran parte dal saggio del filosofo Peter Singer Famine, Affluence, and Morality (1972)10, che sostiene che siamo moralmente obbligati a massimizzare il nostro impatto, concentrandoci sulle cause che determinano i maggiori miglioramenti della qualità della vita, gli altruisti efficaci attestano che tutti noi abbiamo la responsabilità morale di fare del bene nel modo più efficace possibile. In altre parole, dovremmo fornire il massimo beneficio al maggior numero di persone possibile, indipendentemente da dove si trovino.
I sostenitori del lungo termine, puntualizza Anna Gotlib, si considererebbero giustificati nel manipolarci affinché facciamo la cosa giusta.
Il sostenitore del lungo termine porta questo ethos utilitaristico molti passi avanti, sostenendo, come un Elon Musk, che il suo obiettivo sia quello di ridurre la minaccia dei rischi esistenziali per l’umanità: cambiamenti climatici, guerra nucleare, asteroidi distruttivi e altre catastrofi dallo spazio, gli effetti di vendetta dell’intelligenza artificiale e così via. I sostenitori del lungo termine estenderebbero questa responsabilità alle persone future come principale priorità etica dell’umanità.
Uno dei leader del movimento del lungo-termismo, il filosofo morale William MacAskill, sostiene proprio questo nel suo libro What We Owe the Future: A Million-Year View (2022), e viene ripreso dai ricercatori del Future of Humanity Institute (FHI) presso l’Università di Oxford. Ora defunto, l’istituzione è stata fondata da un altro filosofo longtermist, Nick Bostrom. Il messaggio è generalmente questo: potremmo riconoscere la tragedia del razionamento di risorse scarse per la popolazione attuale, tuttavia, se farlo significa migliorare le possibilità, sia di sopravvivenza che di benessere, delle generazioni future, che saranno innumerevoli più di oggi, allora non farlo costituisce un crimine morale.
Quindi, qual è il problema, e come questi benefattori accademici e i loro finanziatori possono rientrare nei criteri della sindrome del personaggio protagonista? La risposta, stando a Gotlib, starebbe in due presupposti necessari, enunciati da Émile P Torres, uno dei loro teorici fondatori ( ), che gli altruisti efficaci e i sostenitori del lungo termine [longtermists] assumerebbero come assiomi.
In primo luogo, a causa del calcolo utilitaristico che congiunge entrambe queste due visioni del mondo, la possibilità di una popolazione umana molto più grande in futuro giustificherebbe un processo di trasformazione in Personaggio Non Giocante di qualsiasi essere umano vivo al momento. In effetti, ci dicono che la nostra sofferenza potrebbe essere l’unica cosa che salverà il futuro!
In secondo luogo, poiché il benessere delle piccole generazioni attuali conta così relativamente poco, i sostenitori del lungo termine si considererebbero giustificati nel manipolarci affinché facciamo la cosa giusta, scegliamo le professioni giuste, contribuiamo alle cause giuste, soffriamo le giuste privazioni e così via.
Poiché tale manipolazione è ideologicamente consentita, anzi, stando al lungo terminismo, moralmente richiesta, l’autodeterminazione e il valore intrinseco degli attuali abitanti della Terra, ci segnala Gotlib, non verrebbero semplicemente ignorati, ma screditati, come un imperativo moralmente rilevante. E, in cima a tutto lo schema, c’è il personaggio principale il cui monomito non solo gli garantisce la percezione morale per capire cosa conta davvero, ma (apparentemente) anche i mezzi per portare a compimento la sua visione, al diavolo tutti i personaggi comparsa. Al centro dello schermo può essercene solo uno, puntualizza Gotlib.
Ma, nonostante la visione distopica del lungo terminismo, essere importanti gli uni per gli altri è ancora centrale nel dibattito filosofico e politico. L’epigrafe nel romanzo Howards End (1910) di E. M. Forster è “Solo connettetevi!” In un mondo moderno emergente, apparentemente intenzionato a distruggere qualsiasi traccia di umanità e interconnessione residua, siamo spinti a connettere le parti disparate della nostra psiche e, cosa più importante, a connetterci gli uni con gli altri, sostiene Anna Gotlib. Eppure, sembriamo essere alla deriva in un mondo che sta diventando un palcoscenico su cui un numero sempre maggiore di noi sceglie di pavoneggiarsi, sì, pavoneggiarsi e non solo dichiarare il nostro bisogno di essere visti e ammirati, ma anche insistere affinché gli altri si subordinino alle nostre personalità.
Ma noi umani che intendiamo la specie e l’umanità in altri termini, abbiamo delle ragioni per disperare? In effetti, le abbiamo sempre avute! La rivoluzione dei social media, con la sua vasta portata e i canti delle sirene del viaggio dell’eroe o con le sue versioni più crude che richiedono apertamente un’attenzione costante, è semplicemente, l’attuale incarnazione di una preoccupazione, di lunga data, per sé stessi, per la propria identità, per la propria importanza. Ma questo è il nostro tempo, il nostro momento davanti ad un progetto di migrazione verso il post-umano, e sembra che sia legittimo, come ci propone direttamente, Gotlib, che rispondiamo nel modo migliore che conosciamo. Ed io personalmente aggiungerei che dobbiamo rispondere non perché abbiamo una verità metafisica da opporre ma perché siamo le ultime generazioni dell’umanesimo e i nostri orizzonti di senso esistenziale derivano dei suoi valori. Quindi, anche se non pretendo di avere la risposta, forse nemmeno una risposta, per affrontare i danni morali del fenomeno della sindrome del protagonista, penso che possiamo iniziare chiedendoci: – cosa stiamo perdendo e perché ci sarebbero ragioni per cercare di salvarlo?
Sotto quest’aspetto, Gotlib ritiene che le narrazioni auto-creative siano fondamentali per aiutarci a ridefinire ciò che siamo in quanto identità reciprocamente costruite. Raccontando e ascoltando storie su noi stessi, sugli altri e sul mondo, arriviamo a intuire chi, perché e come potremmo essere. Tuttavia, il tipo di narrazione del personaggio principale che è attualmente in ascesa fa molto poco per formare identità reciprocamente costruite e, invece, riduce la complessità delle relazioni umane a semplicistici binari di “io” e “non-io”, “loro” e “noi”, “eroe” e “non-eroe”. Invece di co-creatori e co-autori del sé dell’altro, ciò che rimane è una competizione ansiogena, superficiale e consumistica per l’anello dell’unico vero sé, l’unico vero personaggio principale. Diventiamo così rivali, concorrenti e giocatori in quello che sembra un gioco a somma zero di vincitori e vinti. Man mano che la possibilità di identità create in modo interdipendente scompare, ci sentiamo più soli, inascoltati, invisibili, forse senza persona.
Le narrazioni della sindrome del personaggio principale mancano di quella che psicologi e filosofi chiamano una “teoria della mente”, ovvero il riconoscimento della nozione che postula che noi percepiamo le altre persone come se avessero lo stesso tipo di stati mentali che abbiamo noi, anziché come zombie che svolgono piccole parti nel monomito delle nostre vite. Questa mancanza di sintonia con gli altri come persone morali uguali a sé stessi avrebbe una somiglianza famigliare con il narcisismo. Questo senso di “somiglianza famigliare”, un’idea avanzata da Ludwig Wittgenstein, sostiene che varie pratiche e idee possano essere collegate da una serie di somiglianze sovrapposte. Nell’identità narcisistica della persona affetta dalla sindrome del protagonista, motivate dal desiderio di essere adorate, tali pratiche mettono a dura prova le possibilità dell’amore.
La somiglianza tra la sindrome del personaggio protagonista e narcisismo risiede in quella che il filosofo Aleksandar Fatic11 nel 2023 ha definito una sorta di “incompetenza morale“, “l’incompetenza di provare emozioni morali, come empatia, solidarietà, lealtà o amore“. La sindrome del personaggio protagonista e narcisismo si collegano nel loro rifiuto della nostra interdipendenza. Non solo deriderebbero le connessioni significative con gli altri, ma trasformerebbero tale derisione in una virtù. Poiché l’incompetenza morale inibisce la connessione, la sindrome del personaggio protagonista e il suo cugino stretto, il narcisismo, sarebbero indicativi del fallimento morale contro cui l’epigrafe di Forster metteva in guardia.
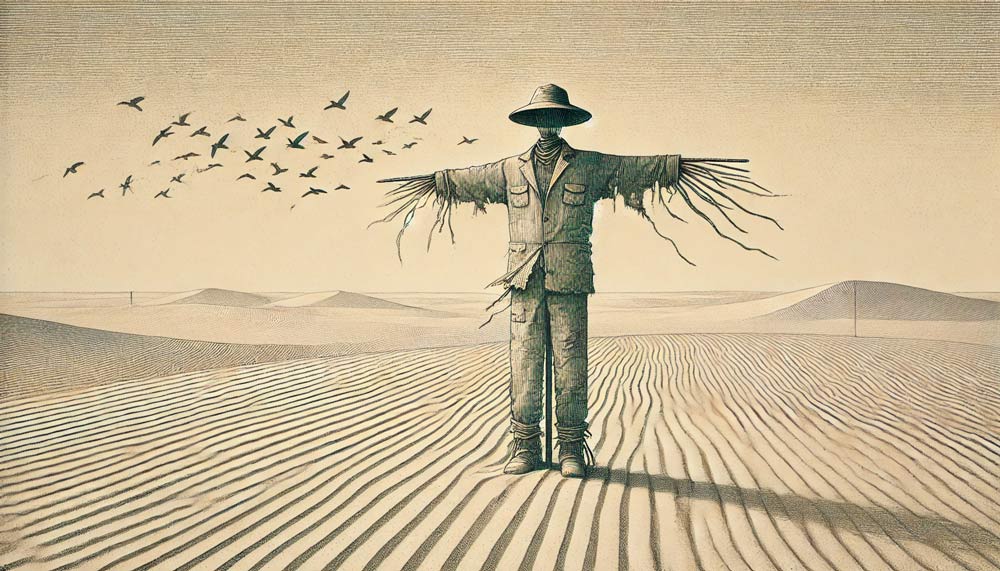
L’amore è più di una posizione affettiva
Per concludere quest’argomentazione dobbiamo tornare ad un’altra parola apparsa nel titolo del paragrafo prima. Ed essa è la parola amore. Albert Camus, nei suoi Quaderni (1935-42), confessa che:
Se dovessi scrivere un libro sulla moralità, avrebbe cento pagine e novantanove sarebbero vuote. Sull’ultima pagina dovrei scrivere: “Riconosco un solo dovere, ed è quello di amare”.
Più di recente, il filosofo Harry Frankfurt, in The Reasons of Love (2004)12, sostiene che l’amore è, sia necessario che pericoloso, rendendoci infinitamente vulnerabili gli uni agli altri.
Sebbene molti di coloro che sono sotto l’incantesimo della sindrome del protagonista siano motivati dal desiderio di essere adorati, le loro stesse pratiche, stando a H. Frankfurt, metterebbero a dura prova le possibilità dell’amore. Con amore, nella sua prospettiva, non si intende solo l’amore romantico, ma il tipo di teneri sentimenti che sono presenti tra amici, familiari e talvolta anche tra persone più distanti. Questo tipo di amore, rivolto agli altri, richiede, stando a Frankfurt, Fatic, Lindemann e Gotlib, per accennare alcuni degli studiosi considerati in quest’argomentazione, un’apertura alle reciproche vulnerabilità, differenze e una concezione non strumentale dell’amato. Tuttavia, la sindrome del personaggio protagonista promuove l’opposto: una sorta di alterizzazione, una trasformazione di noi umani in entità astratte, in manichini strumentalmente utili – o non così utili.
Allora, dopo questi ragionamenti etici possiamo chiederci: c’è un dovere di amare che la sindrome del personaggio principale tradisce? Potremmo ancora, in questo processo di trasformazione di noi umani in manichini strumentalmente utili, pensare di schierarci con Immanuel Kant e dire che, come minimo, non dobbiamo mai trattare le persone come un mero mezzo per i nostri fini?
Questo, a mio avviso, sembra insufficiente se si considera la dichiarazione di Camus. Amare è, in un certo senso, entrare in un arcano, una sorta di connessione con l’altro che non offre garanzie, nessuna gloria personale, nessun risultato sicuro e certamente nessun vincitore o perdente. Amare è affrontare l’incertezza su chi siamo e su chi potrebbe essere l’altro.
Emmanuel Levinas13 sosteneva che “l’alterità“, l’incertezza nata dall’alterità degli altri, è l’inizio di ogni moralità. Da una prospettiva di filosofia morale e di etica si potrebbe postulare che l’incertezza nata dell’alterità sia anche l’inizio di ogni amore. L’altro ci sfida, ci fa delle richieste e ci ritiene responsabili. L’altro ci costringe a uscire dal nostro solipsismo autoreferenziale e a entrare nello stupore della connessione. Guarda il volto dell’altro, ci dice Levinas. Nel vedere il volto di un altro, iniziamo a comprendere cosa potrebbe significare essere vulnerabili, essere responsabili. Questo è a un milione di miglia da “Mi piace” senza volto, degli abbonati o dei fan.
Molti di coloro che sono attratti dalla vita come personaggi principali (come i narcisistici) cercano un qualche tipo di amore, o approvazione, o rassicurazione sul fatto che contino. Cercano un sentimento, una vibrazione. Ma l’amore è più di una posizione affettiva. Erich Fromm, in The Art of Loving (1956), definisce l’amore come una pratica artistica, osservando che “l’amore individuale non può essere raggiunto senza la capacità di amare il prossimo, senza vera umiltà, coraggio, fede e disciplina“. Per Fromm, l’amore è “un’attività, non un affetto passivo“: per amare veramente, non sarebbe sufficiente semplicemente provare qualcosa; ciò che è richiesto è la responsabilità per la cura dell’amato. Eppure la sindrome del personaggio principale, diffusa nella nostra cultura YouTube e TikTok, ci nega la capacità di fare esattamente questo: amare genuinamente e umilmente chiunque o qualsiasi cosa. Per l’eroe conquistatore, tutte le interazioni sono transazionali, tutto lo stupore è autodiretto o autoreferenziale.
Dove ci porta tutto questo? La Sindrome del Personaggio Protagonista non è un puzzle da risolvere tramite un elenco di cose da fare e da non fare. Non è un problema sociale contro cui si possono emanare leggi. Invece, sono convinto che questa nascente civiltà di trasformazione postumana ci invita a impegnarci in quella che Joseph Campbell, tra gli altri, aveva chiamato già nel 1949 nella sua opera The Hero with a Thousand Faces una “notte oscura dell’anima“.
Ciò potrebbe significare sedersi con il nostro anonimato, solitudine, noia e smarrimento; respingere l’equivoco tra performance e connessioni autentiche; renderci vulnerabili agli altri e quindi al fallimento. Potrebbe significare vederci sempre incompleti e riconoscere che la realizzazione potrebbe non essere nelle carte, che la vita non è un monomito trionfante e che gli altri non sono qui per essere scelti in ruoli di supporto. Io stesso, quando la presunzione mi prende la testa, tendo a rivolgermi all’opera teatrale di Samuel Beckett, Endgame (1957), dove un personaggio ci ricorda: “Sei sulla terra, non c’è cura per questo!” Questo richiamo mi sembra così ridimensionante e di giusto conforto che ricomincio da lì.
- Anna Gotlib. Main character syndrome. AEON 27 September 2024 Anna Gotlib è professore associato di filosofia al Brooklyn College di New York. Insegna e scrive nei settori della bioetica femminista, della neuroetica, della filosofia sociale e politica e della psicologia morale.
- Nel gioco di ruolo Dungeons & Dragons, il Dungeon Master è l’organizzatore del gioco e il partecipante incaricato di creare i dettagli e le sfide di una determinata avventura, pur mantenendo una continuità realistica degli eventi.
- Susanna Flock, Robin Klengel, Leonhard Müllner, Michael Stumpf. Does capitalism make ‘non-playable characters’ of us all? An uncanny exploration. AEON, 12 February 2024
- David Chalmers. The philosophy of virtual reality. In AEON, 23 May 2016
- Lindemann, Hilde. Damaged identities, narrative repair. Ithaca: Cornell University Press, 2001
- La storia è ambientata nella nazione di Panem (un’America post apocalittica) costituita dalla ricca Capitol City e da tredici grandi distretti circostanti, di cui dodici ancora abitati e uno, il tredicesimo, distrutto in tempi remoti ad opera della capitale per via di un tentativo di ribellione che ha coinvolto tutti i distretti. Ogni anno, come punizione per aver scatenato la rivolta, in ogni distretto vengono prelevati un ragazzo e una ragazza, di età compresa tra i dodici e i diciotto anni, per partecipare agli Hunger Games, una competizione nella quale i concorrenti (detti “tributi”) combattono fino all’ultimo sangue all’interno di un perimetro molto ampio chiamato “arena”. Il controllo totale di questo ambiente viene affidato agli strateghi tramite tecnologie altamente sofisticate, ostacolando i partecipanti e spingendoli a scontrarsi anche grazie ad ibridi o eventi naturali. Al termine dell’evento rimane un solo sopravvissuto, che viene proclamato vincitore. I tributi coinvolti nella manifestazione sono selezionati durante una cerimonia chiamata “Mietitura”, che consiste nell’estrazione di due nomi (una femmina e un maschio) fra tutti quelli degli adolescenti residenti in ciascun distretto (età compresa tra i 12 e i 18 anni).
- In un imprecisato futuro post apocalittico, per mantenere la pace, le persone della città di Chicago (che ora è delimitata da alte mura per difendersi da una non definita minaccia esterna), a seconda del proprio carattere, vengono inquadrate in cinque diverse fazioni: Eruditi (perseguono la logica e la conoscenza, sono insegnanti, scienziati e dottori, si dedicano alla ricerca e alla cultura); Pacifici (perseguono la gentilezza e l’armonia, si occupano di coltivare la terra e di produrre cibo per la popolazione); Candidi (perseguono onestà e verità e per questo motivo vengono loro affidati i tribunali e la legge); Intrepidi (perseguono coraggio e spericolatezza, sono le forze dell’ordine della città); Abneganti (perseguono altruismo e generosità, conducono una vita semplice e, per questo loro comportamento, sono al comando del governo). Ogni abitante di Chicago nasce nella fazione dei genitori, ma all’età di sedici anni viene chiamato a scegliere la fazione a cui appartenere in base alle proprie preferenze. I giovani vengono aiutati in questa scelta da un test attitudinale che si svolge il giorno prima della Cerimonia della Scelta. Nonostante questo, i sedicenni hanno la possibilità di scegliere liberamente la propria fazione, indipendentemente dal risultato del test ma, una volta fatta la scelta, questa è definitiva. Chi poi viene espulso dalla fazione scelta perché considerato non idoneo, entra a far parte degli Esclusi, una classe di poveri emarginati.
- Un leader di pensiero è stato descritto come un individuo o un’azienda riconosciuta come un’autorità in un campo specifico. Un leader di pensiero è una persona specializzata in una determinata area e alla quale altri in quel settore si rivolgono per ricevere assistenza.
- Il lungo terminismo è una corrente di pensiero che considera eticamente prioritario influenzare positivamente il futuro dell’umanità «a lungo termine». Il lungo terminismo è una parte importante del cosiddetto altruismo efficace. Il concetto di lungo terminismo è stato divulgato in anni recenti dal filosofo William MacAskill e ripreso dal filosofo Toby Ord.
- Singer, Peter. “Famine, Affluence, and Morality.” Philosophy & Public Affairs 1, no. 3: 229-43, 1972
- Fatic, Aleksandar. “Narcissism as a Moral Incompetence.” Philosophy, Psychiatry, & Psychology 30, no. 2 (2023): 159-167.
- Frankfurt, Harry G. The Reasons of Love. Princeton University Press, 2004.
- Emmanuel Levinas. Le Visage de l’autre. Seuil, 2001








