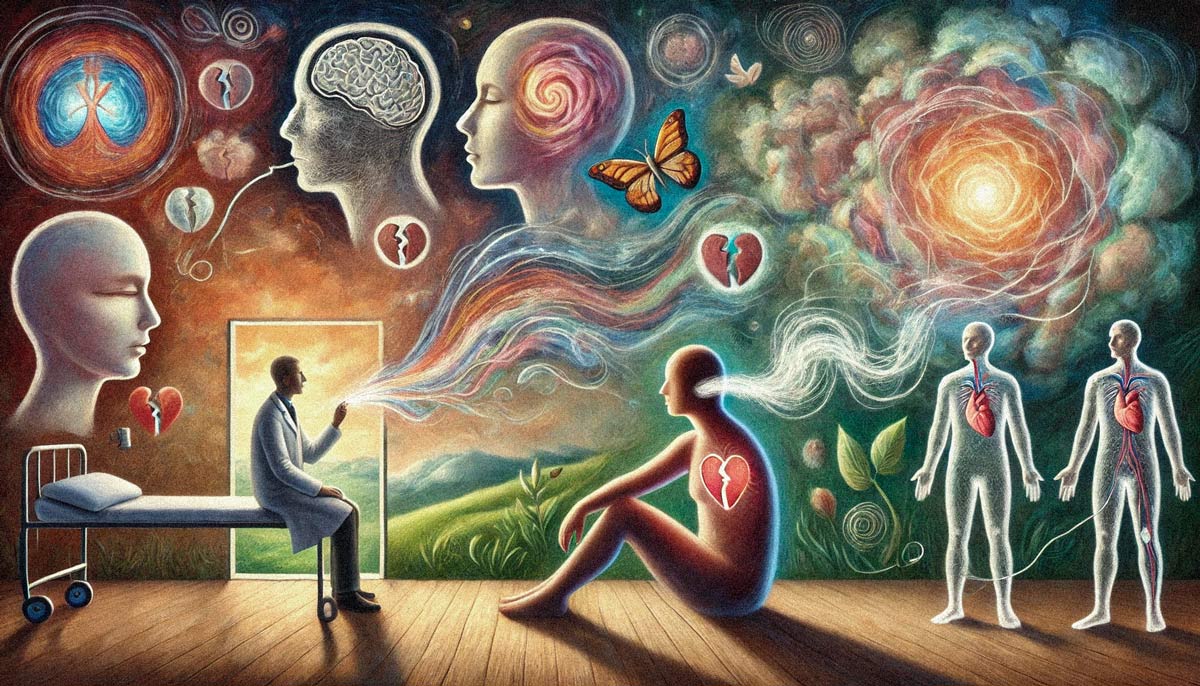“Non si guarirà mai, dunque, in modo conforme alla natura cioè in modo omeopatico, se per ogni caso individuale di malattia, anche acuta, non si presterà simultaneamente la dovuta attenzione anche alle modificazioni dello stato psichico e mentale del malato” (Hahnemann, 1921: § 213)
È incontrovertibilmente dimostrato che una prescrizione medica incontra una compliance crescente quanto più essa è percepita come personalizzata e non come mera ripetizione di un protocollo standardizzato. La terapia omeopatica si muove per sua natura in questa direzione: il medico omeopata, difatti, pone le sue domande e applica la sua semeiotica alla ricerca di un trattamento individualizzato.
Nell’anamnesi omeopatica, come sappiamo, una parte di rilievo è occupata dall’indagine sul carattere del paziente e sugli eventuali sintomi psichici concomitanti. Il tenore stesso delle domande, volte a far luce su di un’area comunemente ignorata dal medico pratico che non sia specialista in psichiatria, contribuisce a creare una salda relazione medico-paziente e qualcosa che somiglia a un clima psicoterapeutico. Qui, dopo tutto, risiede l’origine di quell’effetto placebo che il trattamento omeopatico sembra in effetti possedere in misura maggiore rispetto alle terapie convenzionali e che, se diventa lo strale preferito dai detrattori, può legittimamente costituire motivo di vanto per gli omeopati: perché possedere una tecnica anamnestica dotata per così dire di azione terapeutica non è cosa di poco conto.
Il fatto che l’anamnesi omeopatica lasci emergere contenuti psichici ha una duplice conseguenza: da un lato contribuisce a rinsaldare il rapporto tra medico e paziente, con ovvie implicazioni positive, anche sotto il profilo della compliance; dall’altro, però, sollecita questioni che, nel caso di pazienti nevrotici, necessiterebbero di un intervento psicoterapeutico: in questi casi occorre molto buon senso, perché omeopatia e psicologia, pur essendo interfacciate, non sono intercambiabili.
Questo è un punto delicato. Se infatti la conoscenza del carattere del paziente con una malattia organica ne facilita la comprensione e orienta la scelta del rimedio di fondo, le cose si complicano nel caso di un sintomo di conversione. Il sintomo somatico di una nevrosi di conversione, infatti, pur essendo molesto porta con sé un vantaggio secondario per il paziente, che pertanto sarà poco disposto a rinunciarvi; il tutto avviene beninteso a livello inconscio, il che comporta una difficoltà ancora maggiore. Questo tipo di paziente, d’altra parte, è portato a rivolgersi al medico omeopatico piuttosto che allo psicoterapeuta perché oscuramente intuisce il potenziale psicoterapeutico nascosto nell’ascolto da parte dell’omeopata; e al tempo stesso non è costretto a confessarsi la natura nevrotica del suo disturbo e dunque l’opportunità di portarlo nella sede ad esso più consona.
Questo per quanto riguarda il paziente. Dal lato del medico si nasconde un’altra insidia, complementare alla prima: ovvero la tentazione, anche questa nevrotica, di sedurre pedagogicamente il paziente, ciò che potremmo chiamare complesso di Pigmalione. In questo caso si può verificare una collusione tra le due nevrosi, testimoniata dalla resistenza manifestata da alcuni omeopati nei confronti dell’ipotesi che il paziente vada in analisi. Il rischio è quello di scivolare inconsapevolmente nelle sabbie mobili di una psicoterapia selvaggia, sostenuta da un furor curandi di cui, a diverso titolo, fanno le spese sia il medico sia il paziente.
È facile comprendere come un omeopata che abbia effettuato un lavoro psicologico su di sé – meglio ancora un’analisi personale – sia enormemente facilitato nell’affrontare le questioni sollevate: non perché autorizzato a praticare la psicoterapia (per far ciò occorre infatti una preparazione lunga e specifica), ma in quanto capace di capire quando i sintomi del paziente costituiscono un’inconscia richiesta di psicoterapia, e soprattutto se e quando il rapporto terapeutico prende le forme destinate a un’altra liturgia. In questi casi, infatti, un trattamento combinato sarebbe la strategia più efficace, come ben sottolinea Owen: “Un omeopata è più di un semplice prescrittore di medicine omeopatiche – egli è anche consapevole dell’importanza del supporto di altre terapie e consigli che facilitano questo processo di guarigione” (Owen, 2007: 77).
Tornando alla resistenza nei confronti della psicoanalisi da parte di alcuni colleghi, essa è incoraggiata dagli insegnamenti di scuole per le quali il sintomo mentale, invece che limitarsi a rappresentare un prezioso indicatore, assurge al rango di indicazione. Si tratta di una confusione presente anche in certe Materie Mediche, nelle quali a proposito dello psichismo non viene posta alcuna diversificazione tra sintomo psichico patogenetico– apparso nel corso dei provings e di conseguenza possibile e plausibile indicazione clinica – e tratto caratteriale.
La collusione tra le resistenze del medico e quelle del paziente complica la relazione terapeutica. Il frequente compiacersi del transfert del paziente – tentazione a cui ogni terapeuta è soggetto – può bloccare la relazione in un groviglio di dinamiche transferali e controtransferali che rendono arduo avere una visione obiettiva delle cose.
Nell’affrontare sintomi psichici, l’omeopata si trova di fronte a una questione tecnica. Se si tratta difatti di un sintomo apparso ex novo, isolato o nel contesto di altri disturbi somatici, ci può essere una ragionevole aspettativa di buon fine da parte di una terapia omeopatica. È il caso, ad esempio, di una depressione reattiva o di un’ansia acuta. Nel caso invece di una connotazione caratteriale che si configura come elemento psicologico di una tipologia sensibile, la modificabilità del sintomo psichico è di gran lunga inferiore. Nel secondo caso, infatti, si tratta di un elemento che entra nel criterio di scelta di quel rimedio, piuttosto che di un obiettivo terapeutico.
Esempio didattico è quello di un tipo sensibile Sepia (depresso, apatico, isolato) che giunge alla consultazione per un’acne volgare apparsa nella zona del mento, indicazione netta del rimedio Sepia: dalla prescrizione ci si potrà attendere una guarigione dell’acne, mentre l’atteggiamento depressivo risulterà praticamente immodificato, a meno che non si metta in discussione l’intero contesto nevrotico, cosa che non è pensabile si realizzi con la mera prescrizione di un farmaco omeopatico: diversamente rientrerebbe dalla finestra quella logica psicofarmacologica giustamente stigmatizzata dalla maggior parte degli omeopati, con la differenza non trascurabile che sul piano puramente sintomatico gli psicofarmaci convenzionali sono indubbiamente più efficaci. Una condizione depressiva che presenti le modalità di Sepia ma che sia apparsa in un determinato momento del tempo e dello spazio, pensiamo ad esempio a una depressione post-partum, potrà invece giovarsi certamente, e in tempi relativamente rapidi, della prescrizione di Sepia.
Su questa linea, che potremmo definire somato-psichica, l’Organon è molto chiaro: “Posso affermare, sulla base di una lunga esperienza, che l’incomparabile superiorità dell’Omeopatia […] non si dimostra in nessun altro campo, con altrettanta evidenza, come in quello delle malattie mentali e delle affezioni psichiche croniche che devono la loro origine ad affezioni somatiche, o che si sono sviluppate contemporaneamente ad esse” (Hahnemann, 1921: § 230).
Rispetto alla psicosomatica di orientamento psicoanalitico, la medicina omeopatica riconosce sempre un ruolo ai fattori psicologici, non limitandosi a individuare i sintomi di conversione. Hahnemann scopre – con largo anticipo sulla PNEI – che la forza perturbatrice della malattia esercita la sua azione su tutta l’economia dell’organismo. E lo scopre mercé la geniale intermediazione della sperimentazione patogenetica sul soggetto sano.
“Tra i farmaci in grado di indurre modificazioni sullo stato di salute dell’uomo, tramite la sperimentazione, quello che possiede la maggiore similitudine con la totalità dei sintomi di una malattia naturale data, sarà e dovrà essere quello più omeopaticamente adatto; in tal farmaco sarà trovato lo specifico di quel caso patologico” (Hahnemann, 1921: § 147).
Gli esempi sono molteplici. Basti pensare al ruolo della rimozione nel determinare il nucleo patologico di Staphysagria; al rapporto tra Ignatia e la paura; alla contiguità di Nux vomica con la collera; all’ansia di anticipazione di Gelsemium e, con modalità diverse, di Argentum nitricum.
L’Organon si sofferma sulla varietà dei temperamenti, concludendo con grande finezza: “Per formarsi un’immagine reale e particolareggiata di qualsiasi malattia, ma specialmente di quelle a carattere cronico, il medico ha bisogno di possedere […] pazienza, una buona conoscenza dell’animo umano, psicologia, per potere condurre bene l’interrogatorio, qualità di tatto e circospezione” (Hahnemann, 1921: § 98).
“L’improvvisa perdita del figlio può causare nella madre già in precaria salute uno stato infiammatorio dei polmoni o un cancro al seno. Una giovane sensibile, già isterica, sprofonda nella malinconia a causa di una delusione d’amore” (Hahnemann, 1828: § 196). “[…] il dolore e le sofferenze psichiche sono i fattori che maggiormente scatenano […] o fanno aggravare i disturbi cronici […] le sofferenze psichiche infatti hanno sulla malattia effetti negativi molto più forti di qualunque altra sofferenza di altro genere” (Hahnemann, 1828: § 197).
All’origine dell’importanza che l’Omeopatia conferisce alla valutazione dell’area psicologica concorre più di un motivo. Vi è innanzitutto un motivo tecnico, ovvero la necessità di porre al vaglio della similitudine il maggior numero di elementi gerarchicamente significativi: e l’area psicologica certamente lo è.
“L’impiego omeopatico dei medicinali è più indicato quando non solo i sintomi somatici del rimedio sono simili a quelli della malattia, ma anche quando le alterazioni mentali ed emozionali provocate dalla droga incontrano stati simili nel quadro morboso da curare”(Hahnemann, 1811-1821: 345; traduzione nostra).
Oltre al motivo tecnico testé richiamato, vi è un evento biografico assai significativo, che rivela la disposizione naturale del fondatore all’ascolto e alla comprensione del paziente. Come è noto, Hahnemann si astiene dall’attività clinica a partire dal 1789 per dedicarsi, a partire dall’anno seguente, alla ricerca di un principio affidabile che informi un intervento clinico razionale. Questo principio, noto come principio di similitudine, troverà una prima enunciazione nel 1796, con la pubblicazione del “Saggio su un nuovo principio per scoprire le virtù curative delle sostanze medicinali, seguito da qualche considerazione sui principî accettati fino ai nostri giorni”, nel quale Hahnemann trae le prime conclusioni di sei anni di sperimentazioni di sostanze medicinali sull’uomo sano. Il Saggio costituisce in un certo senso l’atto di nascita dell’Omeopatia; e insieme il colpo d’ala con il quale Hahnemann si solleva da una posizione di mera contestazione della medicina del suo tempo a un livello propositivo e originale.
Dunque gli anni dal 1790 al 1796 sono anni di studio e di ricerca, con l’obiettivo di trovare una solida base teorico-pratica sulla quale rifondare l’attività clinica, temporaneamente sospesa. All’incirca a metà di tale percorso, tuttavia, si situa un episodio clinico, isolato ma carico di implicazioni epistemologiche. Siamo nel 1792. L’editore Becker, confratello massone, procura ad Hahnemann l’incarico di direttore del manicomio di Georgenthal, in Turingia. Si tratta di uno spazio ricavato dal riadattamento del castello di caccia di Ernst, duca di Gotha, e ospiterà un solo paziente: Friedrich Klockenbring, alto funzionario della cancelleria di Hannover e ministro di polizia, curato senza risultati, tra gli altri, dal dottor Wichmann, medico di corte di Hannover. La moglie, avendo letto su una rivista di divulgazione medica la notizia della prossima apertura dell’ospedale psichiatrico di Georgenthal, decide di tentare quest’ultima carta.
È l’inizio dell’estate del 1792 e un uomo malinconico, sporco, col viso pieno di macchie e l’espressione idiota viene condotto dalla moglie nel castello adibito ad ospedale. Nell’attuale linguaggio psichiatrico lo si definirebbe affetto da psicosi maniaco-depressiva con elementi deliranti. È altresì possibile che il grave quadro clinico si configuri come una psicosi organica, in quanto espressione di una sifilide secondaria. Come che sia, il paziente alterna lunghi periodi di taciturna malinconia e fasi eccitatorie in cui, guidato da un’energia allucinata e febbrile, declama brani dell’Iliade in greco e testi in ebraico, canta arie dallo Stabat Mater di Pergolesi, recita a memoria passaggi dell’Inferno di Dante o del Paradiso perduto di Milton, elenca lunghe formule algebriche. Spinto dall’ansia di conoscere i misteri dell’armonia, arriva a fare a pezzi un pianoforte.
Hahnemann trasferisce l’intera famiglia a Georgenthal; per nove mesi osserva il malato, rimane lunghe ore con lui, lo ascolta. Soprattutto, non usa i mezzi di coercizione in uso all’epoca. Nel febbraio 1796, pubblicando il caso clinico in questione, scriverà: “Non faccio mai punire gli alienati con percosse o con altre pene corporali, perché ritengo che non si possa punire la ‘follia’ involontaria; sono convinto che questi malati abbiano diritto alla nostra pietà e che la loro condizione si aggravi quanto più essi vengono maltrattati, senza poter riporre alcuna speranza in un miglioramento: lui mi mostrava spesso i segni delle percosse che i guardiani precedenti gli avevano inflitto durante il ricovero. Il medico di questi infelici deve potersi far rispettare da loro, ma deve anche ispirare loro fiducia; non si ritiene mai offeso da quanto essi possano dire o fare, perché agli alienati è impossibile offendere qualcuno. I loro irragionevoli accessi di collera suscitano la sua comprensione per uno stato tanto meritevole di pietà e suscitano in lui quell’amore per il prossimo che lo induce ad aiutarli” (in Tétau, 1997: 42).
Hahnemann, sempre immerso nello spirito del suo tempo, è probabilmente a conoscenza di ciò che sta accadendo in quegli stessi anni a Parigi, dove Philippe Pinel (1745-1826), proprio nei mesi in cui Hahnemann e Klockenbring si fronteggiano nel manicomio di Georgenthal, libera dalle catene i pazzi dell’ospedale Bicêtre, una struttura trasformata via via in ospedale militare, orfanotrofio, prigione e il cui ospite più illustre era stato Donatien Alphonse François de Sade (1740-1814). Pinel, e successivamente Jean-Étienne-Dominique Esquirol (1772-1840), realizzano una vera e propria riforma dell’orizzonte psichiatrico, che oltre ai metodi rivoluzionerà il punto di vista sulla follia.
Come dirà Hegel, attento lettore di Pinel, nel folle rimane sempre un residuo di ragione, alla quale bisognerà guardare per comprendere e curare la malattia mentale. “Più o meno, i folli ragionano tutti”, scriverà Esquirol nella sua tesi di dottorato del 1805. Il trattamento di Hahnemann – in pratica una rieducazione all’umanità attraverso una umana partecipazione – nel febbraio del 1793 restituisce Klockenbring alla famiglia e al mondo del lavoro. Fiaccato nel corpo sebbene curato nell’anima, egli morirà nel giugno del 1795.
Accostandosi alle malattie mentali propriamente dette, Hahnemann fa un’affermazione cruciale: “[…] non si tratta, però, di una classe di malattie distinta nettamente dalle altre, dato che anche nelle rimanenti malattie fisiche lo stato mentale e quello psichico sono quasi sempre modificati. In tutti i casi di malattia occorre comprendere lo stato d’animo del malato nella totalità dei sintomi, considerandolo uno dei sintomi preferenziali, se si vuole delineare un quadro patologico fedele e poterlo quindi curare omeopaticamente con successo” (Hahnemann, 1921: § 209).
Se consideriamo che tali parole sono del 1842, le teorie psicoanalitiche sulle nevrosi di conversione, posteriori di molti decenni, fanno la figura di una pallida parodia. Allo stesso modo, gli studiosi di neuroscienze dovrebbero annoverare Hahnemann tra i loro precursori, se soltanto leggessero parole come queste: “Quasi tutte le cosiddette malattie mentali e psichiche non sono altro che malattie del corpo, nelle quali ogni sintomo peculiare […] si accresce con la diminuzione dei sintomi fisici” (Hahnemann, 1921: § 215).
————–
Bibliografia
Bailey, P. M. (1995): Psicologia omeopatica. Profili di personalità dei maggiori rimedi costituzionali, Salus Infirmorum, Padova 2000.
Barbancey, J. (1981): Pratique homéopathique en psycho-pathologie, Ediprim, Lyon.
Barbancey, J. (1987): Pratique homéopathique en psycho-pathologie, EditionsSimilia, Le Poiré-sur-Vie.
De Torrebruna, R. – Turinese, L.: Hahnemann. Vita del padre dell’Omeopatia. Sonata in cinque movimenti, Edizioni Efesto, Roma 2020.
Dufilho, R. (1986): Le symptômes mentaux en homéopathie, Imprimerie Graphique Marrimpouey Successeurs, Pau.
Haehl, R. (1922): Samuel Hahnemann. His life and work, B. Jain Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, 1985.
Hahnemann, S. (1796): Saggio su un nuovo principio…, Guna Editore, Milano, 1994.
Hahnemann, S. (1921): Organon dell’arte di guarire (Sesta edizione), Edi-Lombrado, Roma 2004.
Hahnemann, S (1881): Materia Medica Pura, 2 voll., Jain Publishing Co., New Delhi 1980.
Hahnemann, S. (1828): Le malattie croniche, EDIUM, Milano 1980.
Owen, D. (2007): Principi e pratica di omeopatia, Elsevier Masson, Milano 2008.
Tétau, M. (1997): “Hahnemann. Intuizione e genialità”, Tecniche Nuove, Milano, 2003.
Turinese, L.: Biotipologia. L’analisi del tipo nella pratica medica (Seconda edizione), Tecniche Nuove, Milano 2006.
Turinese, L.: Modelli psicosomatici. Un approccio categoriale alla clinica, Elsevier-Masson, Milano 2009.