BIO – Medicina Costruzione Sociale nella Post-Modernità – Educational Papers • Anno VIII • Numero 29 • Marzo 2019
L’esistenza umana come realtà invece dell’economia come realtà!
Poche persone accettano, pacatamente, che il panico umano della morte venga interpretato come la base del nostro comportamento economico e delle nostre opinioni politiche. Questa proposizione, nonostante sia socialmente disturbante, si trova alla base di una corrente di pensiero, sviluppatasi nell’ultima decade, concernente l’economia e denominata economia esistenziale. Infatti, per questo orientamento, vita sociale e vita economica sono intese come dispositivi per la rimozione della paura della morte. Tale approccio, per di più, propone di scegliere come realtà prioritaria l’esistenza umana piuttosto che il predominio dell’economia. Al riguardo, Franco Crespi1 sosteneva che la realtà non sarebbe solo qualcosa che sta fuori di noi, imponendo dall’esterno le sue leggi e le sue sanzioni, ma sarebbe, anche, per buona parte, il prodotto delle nostre immagini e rappresentazioni, il risultato di ciò in cui crediamo2. Nei secoli passati, ad esempio, noi umani abbiamo costruito la nostra realtà fondandola, prima, sull’idea di Dio, poi, sul Potere Politico e, infine, sul Denaro, sulla Finanza e sulla IT e AI: tutte entità astratte, al di sopra dell’individuo e, di fatto, inverificabili.
Al presente, un’élite3, che si identifica con dei valori umanistici evoluzionistici e con la critica sociale al capitalismo, ci propone, come in una specie di manifesto politico del lontano 1968, che sia venuto il momento di assumere, responsabilmente e attivamente, la costruzione della realtà sociale a partire dalla nostra concreta esperienza di vita, cioè dalla nostra esistenza. Questa corrente di pensiero suggerisce che l’importanza che per noi, umani, hanno assunto valori quali qualità della vita quotidiana, libertà, felicità e amore, trova la sua migliore espressione nell’idea di esistenza, cioè quella condizione comune a tutti noi, umani della specie, dalla quale trarre i criteri per la solidarietà sociale, i princìpi della politica e per le scelte sull’economia. Questa tendenza consiglia che, se si vuole andare verso una realtà dal volto umano è imprescindibile un cambiamento che rovesci quel predominio che l’economia è venuta ad occupare nella nostra idea di realtà.

Economia esistenziale e responsabilità individuale nell’assistenza sanitaria
Negli ultimi anni, il matematico Christian Léonard e l’economista Christian Arnsperger hanno utilizzato l’approccio dell’economia esistenziale4 per occuparsi di questioni quali la distribuzione collettiva dell’assistenza sanitaria e la responsabilità individuale nei sistemi contemporanei di assistenza sanitaria. La loro prospettiva esistenziale sulla vita economica postula, in modo inedito e alquanto inquietante, che la nostra idea di una razionalità economica sia sostenuta da una nostra fondamentale ricerca e richiesta di immortalità, radicata in una nostra umana profonda negazione della morte. Per Léonard e Arnsperger, un’analisi critica della logica del capitalismo contemporaneo mostra che la nostra negazione della morte costituisce le fondamenta della nostra attuale idea di economia.
Nel contesto delle crescenti disuguaglianze, generate da un sistema economico di massimo profilo guidata da un’ansia esistenziale diffusa, Léonard e Arnsperger hanno sostenuto che l’idea liberista della responsabilità individuale, attraverso incentivi finanziari derivati, nell’ambito dell’assistenza sanitaria, sia da ritenersi estremamente ingiusta: le stesse paure esistenziali di base, cioè la malattia, la sofferenza e la morte, che rendono tutti noi umani o tossicodipendenti e incuranti o ipocondriaci o ossessivamente attenti, si traducono in situazioni economiche molto diverse, a seconda della propria personale resilienza5 pro-sistemica alla paura della morte.
In altre parole, Léonard e Arnsperger, hanno considerato e proposto che tutti noi umani condividessimo la stessa condizione umana e nutrissimo lo stesso terrore, più o meno istintivo, di fragilità, sofferenza e morte, ma all’interno del sistema economico questa condizione condivisa può andare di pari passo con situazioni socioeconomiche molto disparate. Infatti, le ripercussioni della paura della malattia, della sofferenza e della morte all’interno del sistema non sono distribuite nello stesso modo tra tutti i membri di una comunità o collettivo.
In realtà, l’attuale ideologia liberista degli incentivi e delle responsabilità dei pazienti equivarrebbe a stigmatizzare una particolare categoria della popolazione per gli effetti, fin troppo visibili, della sua angoscia esistenziale, mentre trascurerebbe e conterebbe persino l’angoscia di altre categorie che partecipano, ugualmente, all’intero sistema sanitario. Léonard e Arnsperger, nell’occuparsi della questione della distribuzione collettiva dell’assistenza sanitaria e della responsabilità individuale nei sistemi contemporanei di assistenza sanitaria, avrebbero cercato di ripensare la nozione di responsabilità, sulla falsariga di Foucault ed Ivan Illich, sottolineano le idee chiave del proprio paradigma, che potrebbe essere denominato di autonomia e lucidità esistenziale6.

Perché l’economia esistenziale?
Secondo Léonard e Arnsperger, applicando l’approccio dell’economia esistenziale alle questioni della distribuzione collettiva dell’assistenza sanitaria e della responsabilità personale nelle politiche sanitarie, si dimostra che questo approccio offre nuovi strumenti per l’analisi critica della nozione di responsabilità nell’assistenza sanitaria e apre nuovi orizzonti normativi per una società strutturata in funzione di un’idea di cura esistenziale, lucida, dinnanzi alla paura della sofferenza, della malattia e della morte, piuttosto che predisposta in funzione di un’ideazione, incentivante e meccanicistica, che ci propone l’illusione dell’evasione dal dolore e perfino l’immortalità.
I sostenitori di questo approccio critico confidano che l’economia esistenziale abbia un’importanza significativa per l’economia della salute, non ultimo perché la salute è intimamente connessa con i principali problemi che, secondo la psicologia esistenziale, ognuno di noi affronta nella propria vita: isolamento, mancanza di significato e morte, così come l’ardua conquista della libertà nell’ambito della finitudine fisica e psicologica, come ci ricorda Irvin Yalom7 nelle sue argomentazioni sulla psicoterapia esistenziale. L’economia della salute si occupa, in effetti, continuamente di tali questioni, ad esempio, attraverso le sue domande sulla relativa allocazione del budget per patologie o sulla presunta responsabilità dei pazienti nei costi delle proprie malattie. Oppure con domande del tipo – Qual è il “valore” di una vita umana? – Come prendere in considerazione gli aspetti dannosi del modo di agire delle tante persone, come ad esempio, la dipendenza, comportamenti più o meno consapevolmente imprudenti o stili di vita malsani?
In un contesto di restrizioni della spesa pubblica (largamente guidato dall’ideologia neoliberista, come ci ricorda Julien Duval8 nella sua demistificante analisi della previdenza sociale) e dall’esplosione dei costi della sanità (in gran parte guidata dall’idea della crescita e dal progresso tecnologico dell’ideologia capitalista, come ci segnala Christian Léonard)9, lo stretto comportamentismo10, prevalente, ci ha portato a una semplificazione eccessiva della discussione sull’assistenza sanitaria. In un tale riduzionismo, non c’è spazio per un approccio articolato e umanistico che tenga conto della finitezza umana e dell’angoscia esistenziale, come sostiene Christian Arnsperger 11 nella sua critica all’idea capitalista dell’esistenza. E ciò desta preoccupazione perché l’attenzione esclusiva sulla gestione tecnica dell’esistenza umana implica che i dibattiti sull’assistenza sanitaria dovrebbero svolgersi principalmente tra esperti e responsabili delle politiche. Pazienti, fornitori di assistenza sanitaria e gli attori industriali sono visti principalmente come i denti degli ingranaggi all’interno dei meccanismi che devono essere gestiti dai responsabili delle politiche con l’aiuto di esperti. Nozioni tecnocratiche ed esterne di “responsabilità” e “incentivi” emarginano e rendono irrilevanti concetti più fenomenologici come l’angoscia, il desiderio o la negazione della morte che hanno a che fare con la dimensione soggettiva degli individui, con la loro relazione intima con la propria vita e la propria morte.
L’economia esistenziale, precisamente, intende superare questa rigida compartimentalizzazione tra concetti tecnocratici e fenomenologici. Questo approccio non nega il fatto che le competenze tecnocratiche siano necessarie in società grandi e complesse. Tuttavia, non accetta che tali competenze tecnocratiche diventino l’alibi per trascurare altri dati, apparentemente meno “oggettivi”, della natura umana che, piaccia o no, spiegano molti fenomeni all’interno dell’economia. In effetti, ignorare questi dati – definiti esistenziali per distinguerli dai soliti dati tecnici usati dagli economisti della salute – può a volte portare all’adozione di politiche fredde e sordide, come la promozione della “responsabilità” nelle aree in cui ciò che guida il comportamento di ognuno è, principalmente, l’angoscia esistenziale e la negazione della morte. Dal punto di vista della gestione tecnica, ovviamente, gli stati soggettivi della coscienza delle persone, il loro grado di lucidità esistenziale e la loro capacità di comprendere le esigenze della responsabilità non hanno importanza fondamentale. Ciò che conta è o sarebbe una linea di bilancio e una serie di obiettivi politici spesso colorati da interessi industriali privati. Ma gli individui che modellano ed eseguono la gestione tecnica sono, loro stessi, esseri umani con paure e negazioni, cosicché trascurare gli aspetti esistenziali può, addirittura, portare, a una cattiva gestione tecnica – come quando gli economisti della salute, i responsabili del budget e i funzionari politici rimangono ciechi al fatto che loro tendono ad approvare i valori capitalisti a causa delle proprie angoscianti prospettive sulla vita. L’economia esistenziale cerca di far entrare nella nostra mente queste questioni difficili, come l’angoscia esistenziale e la negazione della morte, e, presumibilmente, non scientifiche.

Una prospettiva esistenziale sulla vita economica
L’economia esistenziale cerca di capire il ruolo giocato dai fattori esistenziali nei fenomeni economici. In questa prospettiva, i fattori dell’esistenzasono quelli che svolgono un ruolo chiave nelle aspirazioni delle collettività umane di fornirsi di un significato per interpretare le loro vite. Lo scopo dell’economia esistenziale è cercare di coprire ciò che è solitamente noto con l’espressione “condizione umana”. Quindi, la domanda, fondamentale, posta nell’economia esistenziale è quale ruolo giocano gli aspetti chiave della nostra condizione umana (quali fragilità, mortalità) nei fenomeni economici.
Tra le risposte a questa domanda, una corrente influente sarebbe quella scaturita dal lavoro degli psicologi esistenzialisti Otto Rank, Norman Brown e Ernest Becker12. Questi pensatori difendono due idee chiave. Prima, che una caratteristica fondamentale della condizione umana è la paura onnipervadente della morte e della finitudine più in generale. Ciò implica che quasi tutta l’azione umana nella società sia, inconsapevolmente, condizionata dal terrore della morte – sia per coloro che sono fragili e precari sia per quelli che sembrano efficaci e solidi. La seconda loro idea è che l’altra caratteristica basilare della vita culturale e sociale sia la negazione pervasiva della morte. Ciò implica che la vita sociale e, quindi, anche la vita economica, devano essere intese come un dispositivo, più o meno sofisticato, per la repressione del terrore della morte – più precisamente, un dispositivo collettivo in cui ogni individuo viene reso più o meno capace di gestire la sua paura subliminale della morte. Becker chiama questo dispositivo collettivo “sistema degli eroi”. Al riguardo, Becker ha sostenuto che tutte le culture, soprattutto quelle cosiddette primitive, mirano a offrire e imporre, nella socializzazione dei bambini e degli adolescenti, certi modelli di esistenza eroica con cui l’individuo può rassicurarsi o procurarsi un suo “significato cosmico”. Queste due caratteristiche chiave hanno, indubbiamente, implicazioni determinanti per il comportamento osservabile negli individui e, ugualmente, nelle entità aziendali, comprese le corporazioni, all’interno dell’economia.
L’economia esistenziale trova combustibile per le sue analisi inquietanti nel recente sviluppo, nell’ambito della psicologia sperimentale, dalla cosiddetta teoria della gestione del terrore13. Secondo questo approccio, che trae ispirazione da Brown e Becker, noi umani siamo – il più delle volte senza nemmeno esserne consapevoli – abitati da un costante terrore della morte che condizionerebbe tutte le nostre azioni. Ciò ci conduce, anzitutto, attraverso un’azione collettiva, a lungo termine, ad elaborare dispositivi culturali che ci consentano di gestire questo terrore. Così le nostre religioni, le nostre ideologie politiche, i nostri obiettivi economici e i nostri valori morali partecipano, a vari livelli, e a volte con forza, in uno sforzo costante, ma inconsapevole, dell’umanità per costruire risorse esistenziali di significato che ci permettano di sopportare la nostra condizione mortale. La teoria della gestione del terrore, riprende l’idea di Becker del sistema degli eroi e ritiene che una sorta di consapevolezza subliminale della fragilità e della mortalità ci spinga a costruire obiettivi, così come i valori che giustificano questi obiettivi, così da reprimere l’angoscia esistenziale.
Le implicazioni per l’economia di questa fragilità e del terrore della nostra condizione mortale non sono banali. In particolare, è stato documentato da Eva Jonas (Department of Psychology, University of Salzburg.), Immo Fritsche (Institute of Psychology, University of Leipzig) e Jeff Greenberg (University of Arizona) che il leggero rialzo della mortalità giocò un ruolo significativo nelle reazioni caute e, addirittura, apertamente ostili, della popolazione tedesca all’introduzione dell’euro14. Gli psicologi sociali Sheldon Solomon, Jeff Greenberg e Thom Pyszynski affermano che la documentazione storica e la ricerca empirica forniscono un sostegno convergente alla proposizione secondo cui la negazione della nostra mortalità è alla base della febbrile ricerca della ricchezza.
Ma, con una premessa che sembra così complessa e controversa per il creazionismo e l’economia mainstream, come sarebbe o ci sembrerebbe un’analisi economico-esistenziale dell’attuale situazione economica e sociale globale? Semplificando il quadro il più possibile e limitando la questione ad un pragmatico secolarismo, nella visione di Christian Léonard e Christian Arnsperger15, la popolazione può essere divisa in tre categorie: consumatori, imprese/corporazioni e governo/agenzie.
Stando alla visione di Léonard e Arnsperger, i consumatori tradurcono, naturalmente, l’ansia esistenziale di base in un’assunzione di rischi eroica (mediante attività ad alto rischio o mediante consumo di sostanze dannose per la salute ma esaltanti) così come nell’assuefacente ricerca di significato cosmico. Sotto quest’aspetto, il consumismo, l’uso sistematico di beni e sostanze per alleviare il “buco dentro”, è uno dei principali risultati contemporanei di questa dinamica di traduzione dell’ansia esistenziale, come sostengono anche Bauman16 e Turley17. In questa prospettiva teorica, la sete di ricchezza materiale e finanziaria sarebbe una delle principali derivazioni del consumismo, come ugualmente sostengono Kasser, Solomon, Greenberg e Pyszynski, studiando l’alto prezzo del materialismo per l’esistenza umana.
Le imprese/corporazioni, che potrebbero essere concettualizzate come insiemi strutturati di individui, funzionerebbero secondo una logica in cui ogni membro ritiene di dover contribuire, il più possibile, alla crescita e alla redditività dell’impresa, come argomentava Bakan18, nella sua analisi della ricerca patologica di profitto e potere da parte delle corporazioni. Ad un tale livello vengono creati metodi di gestione che arruolano individui, creando entusiasmo per attività generatrici di profitto – a volte fino al punto dell’ossessione, in particolare per colletti bianchi di alto rango (ma sempre più per i colletti blu) come discusso da Boltanki e Chiapello19 nella loro interpretazione del nuovo spirito del capitalismo. Anche qui la causalità di fondo sarebbe esistenziale. Per Boltanki e Chiapello noi partecipiamo alle buffonate della redditività e della crescita perché siamo stati indotti a credere che daranno significato e stabilità alla nostra vita fragile e precaria.
Questa logica di reclutamento sarebbe stata accentuata dalla sete consumistica di ricchezza finanziaria, che dagli anni ’90 ha portato un numero crescente di consumatori a diventare azionisti, giocando sui mercati finanziari per integrare redditi da lavoro stagnanti a causa della feroce concorrenza tra le imprese. Inoltre, stando a questa prospettiva di analisi, di Boltanki e Cappello la paura della morte e della vecchiaia avrebbe portato sempre più persone molto ricche a eleggere funzionari pubblici che, negli ultimi trent’anni, hanno spinto per una crescente liberalizzazione dei flussi finanziari e questo avrebbe portato all’aumento della finanziarizzazione delle pensioni, in particolare nelle aree anglosassone, come segnalava già nel 2002 Blackburn nel suo libro Banking on Death or, Investing in Life: The History and Future of Pensions20, perfino nei paesi dell’Europa orientale. Una ragione per cui i governi sarebbero diventati sempre più sensibili alle voci dei ricchi, a parere di Moreau, nel suo Le gouvernement des riches21, sarebbe, tra le altre cose, perché l’ideologia della crescita guidata dalla paura sarebbe diventata così diffusa che i politici stessi cercano significato esistenziale e significato cosmico attraverso la reputazione e la rielezione, cedendo agli incentivanti argomenti popolari del tipo a cascata, secondo cui la crescita economica, negatrice della morte, potrebbe essere generata solo attraverso l’arricchimento negazionista della morte dei già benestanti.
Riguardo questa dinamica tra paura della morte e creazione di ricchezza, Christian Léonard e Christian Arnspeger, sostengono che esista una duplice causalità che va dal sistema verso la nostra condizione umana e dalla nostra condizione umana verso il sistema22. Entrambe le direzioni causali sarebbero necessarie per una piena comprensione di ciò che riguarda l’economia di mercato capitalista. L’economia esistenziale tiene pienamente conto delle due direzioni della causalità, dal sistema all’umano e viceversa, e pone le domande all’interno dell’idea di base che questa causalità dal sistema all’umano sia guidata dalla risposta del sistema alla paura umana della sua fragilità, della sua sofferenza e della sua morte, che assume tinte e colori molto diversi e si traduce in modelli comportamentali molto diversi, a seconda di dove ci si trovi all’interno del sistema.
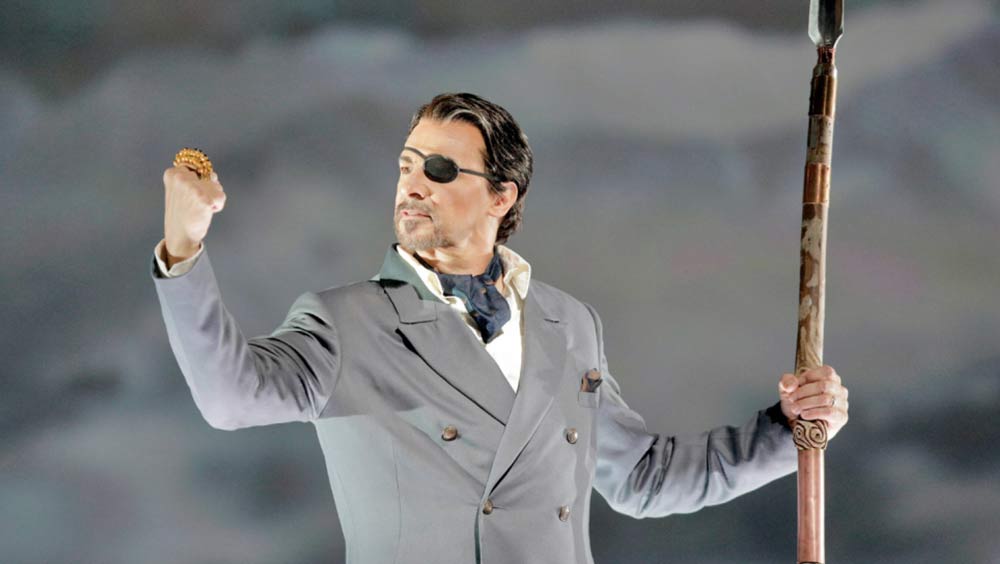
Sistema di prestazioni sanitarie capitalistico
L’assunzione che spinge questa argomentazione è che il quadro qui sopra descritto (di come è o ci sembra un’analisi economico-esistenziale dell’attuale situazione economica e sociale globale) possa avere un’importanza significativa per la nostra comprensione di alcune questioni centrali nella moderna assistenza sanitaria, con tutte le sue declinazioni, da come si nasce a come si muore. In questa discussione, infatti, l’attenzione è concentrata sulla questione della responsabilità personale dei pazienti all’interno di un sistema di prestazioni sanitarie capitalistico. Con l’espressione sistema di prestazioni sanitarie capitalistico, si intende un sistema in cui sia i farmaci che le apparecchiature medicali sono forniti essenzialmente da società private a scopo di lucro con un monitoraggio da parte di uno Stato che ha, ampiamente, interiorizzato la visione capitalista dell’efficienza e della crescita. In linea con le ipotesi dell’economia esistenziale, anche nel contesto della responsabilità individuale nell’assistenza sanitaria, si postula che gli ideali generali di efficienza e crescita, così come la condotta pubblica da parte dei funzionari della politica, la concorrenza tra le imprese e il comportamento consumistico degli individui, siano tutti comportamenti guidati dalla paura esistenziale. Parti di questa immagine sembreranno di fatto semplicistiche. In particolare, se si lasciano fuori dal quadro due attori principali: i singoli medici e le istituzioni sanitarie collettive. Ciò significa, in effetti, che all’interno dell’impianto ristretto di quest’articolo, si assume che i medici e gli ospedali siano semplici ingranaggi e ruote all’interno di un sistema progettato con il consenso dello Stato, al fine di incanalare farmaci e trattamenti medici specifici nei confronti dei pazienti. Tuttavia, si ritiene che, in prima approssimazione, catturi alcune caratteristiche essenziali del dibattito sulla responsabilità individuale nell’assistenza sanitaria.
Un’assunzione di base dell’economia esistenziale, come abbiamo visto, è che ogni singolo agente nell’economia porta le sue ansie esistenziali nelle sue azioni. Nel settore dell’assistenza sanitaria, ciò significa, in particolare, stando alla visione di Léonard e Arnsperger23, che:
a) noi, umani, [i consumatori] mostriamo una tendenza generale a impegnarci in attività che ci procurano assuefazione, stili di vita “insalubri”, attività ad alto rischio, o a procrastinare quando si tratta di affrontare problemi di salute o atteggiamenti eccessivamente prudenti legati all’ipocondria. Questa sarebbe una caratteristica generale che, questi esperti che stiamo passando in rassegna, potrebbero collegare all’assenza di lucidità esistenziale, vale a dire che finché uno non ha imparato a portare la propria condizione umana in altro modo, si tenda a bere, mangiare o fumare troppo, a comportarsi in modo noncurante, anche di fronte al pericolo noto ed evidente, oppure per consumare troppi farmaci. Tuttavia, le conseguenze di queste azioni rimangono sconosciute, o almeno implicite, per molte persone. Nella maggior parte dei casi, le azioni sono condizionate da elementi sociali, culturali, familiari o economici. Di solito non siamo padroni del modo in cui cerchiamo di alleviare il peso della nostra finitezza. Tale comportamento sarebbe in gran parte condizionato24 e il tipo di stigmatizzazione che ne deriva differisce, ampiamente, negli ambienti sociali, anche se la tendenza fondamentale, alla base, di sfuggire alla condizione umana sia la stessa. Questa modalità di ricerca di alleviare il dolore della finitezza sarebbe, stando alla visione di Léonard e Arnsperger, occasionalmente, incoraggiata dalla ricerca, da parte dei medici, di risposte alla loro condizione umana, che li fa cercare alti redditi e alta reputazione, spesso inducendo una domanda aggiuntiva da parte di pazienti già ansiosi. Questo costituirebbe la delicata questione della “domanda indotta dai fornitori” nelle cure mediche.
b) Le imprese (aziende o corporazioni che siano) hanno una tendenza generale a comportarsi in modo spietato nella ricerca del profitto, sia a causa delle aspirazioni esistenziali all’immortalità fittizia nascoste negli ideali di ricchezza e crescita, sia a causa delle pressioni provenienti dalle aspirazioni finanziarie (esse stesse provocate esistenzialmente) degli azionisti e dei pensionati attuali o futuri. Anche la cosiddetta fornitura compassionevole [cutting-edge] di farmaci o di apparecchiature all’avanguardia a popolazioni povere può essere parte del calcolo generale della redditività ed equivale, in questo contesto, alla solita tattica di rendere le persone dipendenti da cose nuove prima di fargliele pagare una volta che sono agganciati. Ciò si verifica, a volte, dopo che i pazienti che sono stati trattati strategicamente, in modo gratuito, hanno fatto pressione sul loro governo per far registrare il nuovo farmaco o macchinario per il rimborso della sicurezza sociale. Inoltre, all’interno delle “ditte mediche” in generale, l’uso di incentivi finanziari per Ricerca & Sviluppo implica che i brillanti ricercatori sono in grado di ottenere una ricchezza sostanziale – vale a dire mezzi sostanziali per coprire il loro terrore esistenziale – affermando che si rifiuterebbero di lavorare per meno. Oltre al risarcimento, anche l’effetto della reputazione gioca un ruolo: per coloro che hanno il capitale umano e culturale per farlo, ottenere il riconoscimento lavorando in una prestigiosa e costosa società di ricerca costituisce anche un modo per contrastare la paura della finitudine. Aneliamo profondamente a questa sete di riconoscimento da estinguere25. Ciò spinge i prezzi di vendita verso l’alto per farmaci e macchinari, quindi anche per le prestazioni mediche più in generale, e, conseguentemente, rende la solidarietà collettiva tanto più costosa. I prezzi elevati sono possibili a causa dell’asimmetria delle informazioni relative ai costi di produzione. La differenza tra questi costi e i prezzi è, a volte, così grande che nessuna giustificazione ragionevole, diversa dalla ricerca del profitto e dagli incentivi monetari, può essere individuata per spiegarlo.
c) I governi hanno una tendenza generale a comportarsi in modo da massimizzare il loro profitto politico per le rielezioni e l’adempimento, immediato, della soddisfazione dell’ego dei funzionari pubblici e dei politici. Nei decenni passati, ciò poteva significare utilizzare ampi e popolari deficit per “far riempire” le paure di tutte le categorie della popolazione con aiuti o donazioni. Tuttavia, con l’avvento della globalizzazione finanziaria (essa stessa guidata dal desiderio di potenti gruppi economici in tutto il pianeta di avere un campo da gioco su cui capitalizzare la propria ricchezza accumulata, in modo da negare la propria mortalità e farsi sentire invincibili ed eterni), la necessità di avere bilanci pubblici strettamente ponderati ha portato numerosi governi e i loro ideologi pubblici ad abbracciare una retorica di flessibilità sistemica unita all’idea della responsabilità individuale26. Tale retorica intende rendere gli individui responsabili del peso che esercitano sulla solidarietà collettiva, piuttosto che rendere la solidarietà collettiva responsabile del modo in cui aiuta gli individui fragili.
Questo complicato insieme di meccanismi – qui semplificato in modo estremo – ha portato all’ondata di “responsabilizzazione” nell’assistenza sanitaria e all’interno dell’area complessiva della salute come costruzione sociale, consentendo alla logica del profitto l’appiglio della retorica del rimanere sani. In tale contesto, tre politiche principali si sono diffuse. In primo luogo, vi è l’aumento del contributo personale del paziente in ogni area di trattamento. In secondo luogo, vi è l’aumento degli integratori fluttuanti, come quando un ospedale applica una tariffa del 200 o del 300 percento (o superiore) per le tariffe delle camere singole. Infine, vi è il fatto, evidente, che sempre più prestazioni mediche, farmaci e materiali medici non vengono più rimborsati, il che implica che il paziente debba pagarli di tasca propria o acquistando un’assicurazione privata.
La politica della responsabilizzazione sta, attualmente, lasciando l’area della responsabilità lineare e guardando, sempre più, verso il targeting delle misure di responsabilità in funzione dei criteri specifici del paziente27. Parallelamente, l’ideologia prevalente si sta spostando nella direzione di un targeting più individualizzato, come documentano Yoder, Resnik, Buetow e Cappelen28. Ovviamente, questa nozione di responsabilizzazione comporta un’aura, a prima vista, di equità poiché colpisce tutti i pazienti allo stesso modo, indipendentemente dal loro reddito, comportamento, o antecedenti. Tuttavia, nel contesto dell’approfondimento della disuguaglianza economica generata da un sistema guidato da un’ansia esistenziale diffusa, l’idea della responsabilità individuale attraverso incentivi finanziari risulta estremamente ingiusta. La ragione è abbastanza semplice. Sta nel fatto che le stesse paure esistenziali di base, che rendono tutti noi o dipendenti (da sostanze) e trascurati o ipocondriaci e ossessivamente attenti, si traducono in situazioni economiche molto diverse a seconda della personale resilienza pro-sistemica alla paura. In altre parole, potremmo tutti condividere la stessa condizione umana fondamentale e nutrire la stessa paura o terrore più o meno inconscio di fragilità, sofferenza e morte, ma all’interno del sistema economico questa condizione condivisa può andare di pari passo con situazioni socioeconomiche molto disparate, a seconda su come le ripercussioni della paura di tutti all’interno del sistema siano distribuite tra tutti gli agenti.
Quegli individui che si trovano nella “parte giusta” e sono, quindi, stati in grado di trasformare la loro angoscia esistenziale in alti stipendi (spintidalla paura della perdita competitiva) e una buona assicurazione (che è il “premio” ricevuto per avere “ fatto bene” sul lato salariale), sono ampiamente protetti dall’impatto diretto delle misure di responsabilità. Loro continuano a essere in grado di pagare per le loro abitudini di negazione della morte, sotto forma di consumo eccessivo di cure sia a causa di troppa cautela sia a causa di troppa poca cautela.
Le vere vittime della retorica della responsabilità sono quelle che sono troppo povere a causa delle dinamiche di disuguaglianza, guidate dal timore del sistema, per essere in grado di sostenere tutti i costi di una maggiore responsabilità. Sono vittime, perché solo loro non sono in grado di sostenere le abitudini sociali di diniego della morte, mentre i pazienti più ricchi, nonché le imprese e il governo siano in grado di farlo. Di fatto, sono tre volte vittime perché, sono costrette a:
a) dover sopportare la loro angoscia di base come tutti gli altri,
b) sono più duramente colpiti dalle ripercussioni dell’angoscia di base di tutti gli altri attraverso il sistema economico
c) finiscono per abbandonare, completamente, molti sottosistemi di assistenza sanitaria.
Pensiamo, ad esempio, al caso di persone povere che, a causa di vincoli troppo rigidi di responsabilità individuale, rinunciano ad andare dal loro dentista perché non sono in grado di pagare gli onorari elevati che, negli anni successivi, daranno loro il diritto di rimborso29. Questa misura, il cui scopo è quello di aumentare la responsabilità del paziente, imprigiona i meno abbienti all’interno di un circolo vizioso in cui si rimandano le cure preventive, il che:
1) aumenta il rischio di futuri problemi di salute dentale e
2) approfondisce la pseudo – responsabilità finanziaria poiché questo rinvio esclude la disposizione futura dall’ambito di applicazione della solidarietà collettiva.
Con l’espressione pseudo-responsabilizzazione30, si intende il tentativo di rendere le persone più responsabili, in senso contabile, piuttosto che attraverso un effettivo aumento della loro autonomia. Naturalmente, i comportamentisti postulano una connessione tra la sanzione finanziaria e il futuro cambiamento nel comportamento. Tuttavia, questo collegamento è raramente confermato nei dati e, inoltre, le basi esistenziali qui esposte rendono molto meno certo questo legame: scoraggiamento, aggressività e persino autodistruzione possono prevalere sulle riforme comportamentali nei soggetti che, a causa della loro povertà o marginalità, si sentono respinti dall’etica della pseudo – responsabilità.
Quindi l’economia esistenziale ci insegna che in un sistema economico popolato da gruppi sociali esistenzialmente ciechi, tutti questi gruppi trasferiscono, continuamente, gli uni sugli altri gli, effetti collaterali delle loro paure esistenziali e questo meccanismo è ciò che genera molti fenomeni collettivi. Un’implicazione diretta è che, contrariamente a ciò che l’attuale ideologia della responsabilità spesso assume, non sono solo i pazienti che vivono nell’angoscia – dal momento che le loro vite sono direttamente toccate dalla fragilità e dalla malattia che richiedono assistenza medica – ma anche, e in egual misura, i fornitori di assistenza sanitaria, i produttori di beni sanitari e i decisori che definiscono le politiche sanitarie.
Il consumo di servizi sanitari è certamente angoscioso – questo risulta spesso abbastanza visibile – ma lo è anche la fornitura di servizi sanitari, la commercializzazione di prodotti sanitari e l’elaborazione di una politica sanitaria. Secondo l’economia esistenziale la paura esistenziale è onnipervadente e, quindi, non c’è motivo per individuare determinate categorie di gruppi sociali o determinate categorie di attività. Pertanto, ideologia neoliberista degli incentivi e delle responsabilità dei pazienti equivale a stigmatizzare una particolare categoria della popolazione per gli effetti fin troppo visibili della sua angoscia esistenziale, mentre trascura l’angoscia di altre categorie che partecipano, ugualmente, all’intero sistema sanitario.
Gli esempi riguardo la questione degli incentivi e della responsabilità abbondano tra i paesi. Come regola generale, mostrano che gli operatori selezionati nel sistema – i pazienti – sono sempre più ritenuti responsabili degli effetti “cattivi” della loro angoscia (essenzialmente, della tendenza a cercare aiuto troppo tardi, dipendenze e altri problemi) mentre alcuni altri operatori – le imprese e il governo – sono in realtà complimentati per gli effetti “buoni” della loro angoscia: maggiore concorrenza, enormi investimenti in Ricerca & Sviluppo in molecole o tecnologie redditizie, violente repressioni sui pazienti che non si mostrano “responsabili”, e via dicendo.
È indubitabile che questo tipo di analisi sia destinato a sembrare piuttosto discutibile per un economista che ragiona in termini di incentivi. Dopo tutto, l’economista direbbe che ciò che conta non sono gli stati interiori della coscienza delle persone né la loro angoscia, ma le implicazioni del loro comportamento esteriore per la gestione del sistema sanitario. Tale posizione, però, potrebbe essere messa in discussione segnalando soltanto che essa oscura le asimmetrie indotte dal sistema tra i gruppi sociali. Essa nasconde il fatto che, data la logica della ricerca di rendita capitalista, alcune paure esistenziali – vale a dire quelle dei gruppi industriali eccessivamente competitivi, dei fornitori di medicinali assetati di reddito e dei politici in carica dell’elaborazione delle politiche eccessivamente tecnocratici, così come quelle paure dei pazienti ansiosi ma ricchi – sono viste come accettabili perché possono essere usate nella logica del mercato capitalista per generare una crescita redditizia, mentre altre paure esistenziali – vale a dire quelle dei pazienti eccessivamente cauti e non timorosi, ed economicamente poveri – sono vituperate perché generano una perdita di opportunità di profitto, e quindi sono viste come una richiesta di “incentivi” e “sanzioni” più duri.
I gruppi sociali più deboli vengono criticati per ciò che sono i “sintomi economici della loro angoscia”, cioè le loro carenze economiche, da gruppi sociali più forti che interpretano le loro ricchezze piuttosto che come risultato della propria angoscia esistenziale, come virtù di mercato o sanità mentale … In effetti, si può dubitare che l’intento sia davvero quello di rendere i pazienti “responsabili” al punto che, effettivamente, diminuiscano le loro spese sanitarie complessive. Dopotutto, da un punto di vista capitalista e produttivista, il paziente è anche un consumatore che deve essere tenuto, come sostiene Ivan Illich nella sua devastante analisi dell’iatrogenesi31, in una posizione di eteronomia nei confronti del settore. Risulta, quindi, legittimo chiedersi se, all’interno di un sistema capitalista che si legittima mediante la regolamentazione statale per perpetuare la sua logica, esista una motivazione politica sufficiente per attuare misure che rendano i pazienti,realmente, più autonomi nel senso sostenuto da Ivan Illich, fornendo loro con ciò che Léonard & Arnsperger32, denominano “lucidità esistenziale”.
L’assistenza sanitaria capitalista ha un modo specifico di distribuire la colpa e i complimenti che creano quelle che consideriamo come asimmetrie ideologicamente determinate ma umanamente inaccettabili. Sono inaccettabili dato che, alla fine della giornata, tutti noi, umani, ci troviamo nella stessa barca, per così dire, condividendo una finitezza e una fragilità che alcuni di noi sono capaci di trasformare in prestazioni di mercato o in durezza politica mentre interpretano la finitezza e la fragilità degli altri come pigrizia, eccessiva indulgenza e irresponsabilità.
Quest’analisi, alquanto problematica, spiega perché il dipendere da una malattia che risulti come una buona ragione. In effetti, il risultato della retorica della responsabilità individuale all’interno di un sistema economico strutturalmente inegualitario e esistenzialmente cieco è che le paure esistenziali di ognuno vengano spinte come una patata bollente sulle schiene dei membri più deboli – quelle le cui opportunità di coprire le loro paure di base sono, innanzitutto, le più basse. Quando questi individui più deboli invocano il sistema sanitario in modo massiccio per alleviare la loro sofferenza durante e dopo una malattia o a causa della vecchiaia, la risposta del sistema è: “Qual è la tua ragione per soffrire? È una buona ragione? Hai fatto tutto ciò che ti abbiamo detto di fare in passato in modo da ridurre al minimo le tue probabilità di essere un onere costoso per il resto di noi? Ti rendi conto a quanta ricchezza dobbiamo rinunciare per aiutarti adesso?”. In effetti, la retorica della responsabilità individuale, che si applica in linea di principio a tutti i pazienti ma in realtà “colpisce” solo quei pazienti che hanno bassi mezzi economici, è parte integrante di un sistema economico in cui il terrore condiviso della morte genera disuguaglianze strutturali.
Questa differenziazione nell’attribuzione di responsabilità, questo spostamento di responsabilità dal forte al debole, può essere considerato veramente sincero? I contribuenti vogliono davvero eliminare tutte le categorie di “irresponsabilità”? Questi tipi di comportamento “discutibile” non sono immagini perfette di rassicurazione per quelle persone che vogliono sentire che il loro modo di alleviare la loro angoscia – attraverso il “successo” – sia quello giusto?
La vista di una persona malata ben potrebbe essere ciò che i “responsabili” necessitano per convincersi che la loro esistenza ha un senso e che loro sono “giusti”. Per fare un esempio da un’altra area della politica sociale, c’è una giustificazione più soddisfacente per il nostro comportamento di persone “attive” rispetto alla persistenza della disoccupazione? Questa sorta di auto-giustificazione esistenziale, ovviamente, si stringe solo fino a quando una persona cosiddetta “responsabile” si ammala – o perde il lavoro e, improvvisamente, le viene chiesto di giustificare la propria sofferenza.

Preferenza per una società che sostena una lucidità esistenziale e una cura condivisa
Come possiamo noi, esseri umani, vivere con la tensione interiore tra il desiderio di immortalità e la conoscenza della mortalità? La risposta, afferma Ernest Becker, sta nella ricerca di una vita cosciente vissuta senza menzogne esistenziali33. In questa prospettiva, gli individui devono sviluppare ciò che Becker chiama “apertura all’esperienza”. È un modo di vivere in cui ancora “giochiamo” nelle finzioni del “sistema dell’eroe” [o sistema degli eroi] della cultura e della vita sociale, ma smettiamo di essere un peso per gli altri – smettiamo di volere che gli altri portino la nostra paura della morte per noi, smettiamo di caricare la nostra ansia sulle spalle di altre persone. Quindi, dal punto di vista esistenziale, lo scopo dell’individuo non è di rinunciare a tutte le “pulsioni” ma, piuttosto, di diventare sempre meno un “carico” per gli altri. Ciò richiede l’apertura ad una forza interiore, ad un’energia creativa diretta, non ad eroismi falsi, che negano la morte, ma alla ricerca di una vita che accetta la morte e, che allo stesso tempo, accetta di non essere libera dalla paura della morte – una vita, in altre parole, in cui c’è una consapevole paura della morte, una lucida coscienza della morte come centro della vita e così, allo stesso tempo, una vita in cui il peso della morte – su se stessi e sugli altri – diventa più leggero, non più pesante, come ha sostenuto Norman Brown34. A questo punto sorge spontanea la domanda: – Il capitalismo è favorevole a tale percorso? La risposta potrebbe essere che non lo sia. Infatti, il capitalismo rende il carico della morte individuale sempre più pesante – e meno consapevole – creando un “sistema di eroi” che si concentra su un modo materialistico di soddisfare la spinta a difendersi attraverso la spinta ad acquistare.
Non sono, naturalmente, ricchezza, consumo, status o riconoscimento ad essere problematici in quanto tali. Ciò che risulta dannoso – e può essere visto solo attraverso la lente dell’economia esistenziale – è il fatto che ricchezza, consumo, status e riconoscimento vengono dirottati, dalle aspirazioni delle persone di negare la morte, verso un infinito che né ricchezza né consumo, né status né riconoscimento, in definitiva, può offrire. Di conseguenza, come ampiamente argomentato da Arnsperger35 nella sua critica al capitalismo, noi uomini occidentali, così come gli economisti che ci modellano, siamo arrivati a confondere beni materiali per beni spirituali, nella convinzione, profondamente radicata, che i primi possano offrire ciò che questi ultimi promettevano: una tregua della finitudine, una dimenticanza della morte, una sensazione di legame e appartenenza e una certezza di esserci presi cura della propria fragile esistenza.
Nel campo della salute, come abbiamo visto, il problema dell’aspirazioni delle persone di negare la morte verso un infinito è particolarmente evidente. L’accesso della maggioranza delle persone “normali” all’assistenza sanitaria, cioè ai mezzi per vivere con la loro fragilità di base e per ricevere aiuto e conforto nella loro inevitabile dipendenza, è limitato e determinato dai desideri immaginari e deliranti di una minoranza di persone “ad alte prestazioni”, che usano la logica del sistema di mercato capitalista per negare la loro fragilità di base e trascurare la loro inevitabile dipendenza, trasformando il loro bisogno di aiuto e di sollievo in una spinta ad acquisire, accumulare, competere e “vincere”. Tali individui, pure costituendo una minoranza, hanno acquisito un’influenza duratura all’interno del clima ideologico generale che si è sviluppato nel corso di diversi secoli nel mondo occidentale e hanno finito per convincersi dell’idea che gli incentivi del mercato capitalista sono il modo migliore per assicurare la ricchezza collettiva, anche se a scapito della sicurezza individuale e della solidarietà interindividuale. Questo, secondo l’economia esistenziale, è la profonda contraddizione della logica economica odierna: noi ci siamo trasformati in una sorta di essere umano del quale il sistema ha bisogno per funzionare ma nel processo abbiamo perso il nostro stesso senso di legame e cura. Da un punto di vista valoriale, il nostro sistema di “assistenza sanitaria” può essere giudicato come un sistema di distribuzione e razionamento dei servizi sanitari limitato dai riflessi, esistenzialmente ciechi, dei ricchi.
La posizione critica al riguardo sostiene che una tale situazione, contraddittoria, pur se politicamente sostenibile all’interno dell’ideologia specifica che prevale attualmente, non è filosoficamente difendibile. Invece di organizzare il razionamento delle pretese esistenziali cieche all’immortalità, non dovremmo, invece, costruire una collettività i cui meccanismi economici aiutino le persone e le collettività a diventare esistenzialmente lucide, cioè cosciente della morte come centro della vita?
In questo contesto valoriale, un elemento centrale sarebbe effettuare un cambiamento fondamentale nel vocabolario. Invece di parlare di “responsabilità individuale”, si dovrebbe parlare di “lucidità esistenziale personale”, cioè della capacità di vedere attraverso le nostre paure esistenziali e il loro impatto sociale. Parlare in termini di lucidità esistenziale condivisa sarebbe un modo completamente diverso di vedere le cose perché, mentre il vocabolario della responsabilità di solito divide una popolazione in coloro che sono responsabili e coloro verso cui sono responsabili, il vocabolario della lucidità esistenziale non è dicotomico: la lucidità di una persona non è un debito nei confronti di un’altra persona. È un debito con sé stessi, per così dire, ed è simmetrico. Diventare esistenzialmente lucidi è tanto un dovere dei ricchi e dei potenti quanto dei poveri e dei deboli. Prevenire il comportamento eccessivo – o sottovoce – con lucidità significa richiedere ad ogni individuo un atteggiamento riflessivo verso il proprio modo di negare fragilità, sofferenza e mortalità. La lucidità esistenziale personale significa che tutti gli agenti nell’economia, simultaneamente e simmetricamente, decostruiscano la loro specifica dipendenza dai meccanismi del capitalismo, in modo da poter aumentare, allo stesso tempo, la generosità e promuovere un minor bisogno di misure inutilmente costose. In altre parole una maggiore lucidità personale comporterebbe36:
una migliore salute di base perché la negazione e la paura consumano energia significativa e creano tensioni e aggressività. Una riduzione degli effetti sistemici del capitalismo che rende le persone malate, dal momento che individui lucidi non si impegnerebbero a pieno ritmo in una vita capitalista con le sue patologie associate.
Questa dinamica verso una maggiore lucidità personale potrebbe essere meglio compresa attraverso la nozione di souci de soi di Michel Foucault37, ovvero la nozione di “cura di sé” intesa nel senso platonico come cura di sé per poter meglio essere in grado di prendersi cura degli altri e attraverso la nozione degli umani come “animali razionali dipendenti” di Alasdair Macintyre38 che possono realizzare le loro vite solo praticando quelle che egli chiama “le virtù della dipendenza riconosciuta”: cioè dignità, misericordia e beneficenza. Ciò implica un atteggiamento esistenziale in cui ognuno di noi inizia accettando di non essere un individuo esistenzialmente separato che può negare il destino che condivide con tutti gli altri. L’accettazione di una dipendenza condivisa sulla base della finitudine condivisa conduce a un diverso tipo di atteggiamento, atteggiamento che non parte dal proprio rifiuto pauroso delle pretese altrui su di lui, ma dal riconoscimento dell’individuo che queste affermazioni degli altri sono radicate nella stessa condizione che condivide con loro. Così, ad esempio, la ricerca medica non dovrebbe più essere considerata, ragionevolmente, un’area di massimizzazione del profitto, ma, invece, come un dominio in cui l’attività orientata al dono sia centrale: il tempo semplicemente non dovrebbe essere denaro in quell’area. Dal punto di vista della lucidità esistenziale, la ricerca medica non dovrebbe essere il luogo in cui gestire e valorizzare il proprio “capitale umano”. L’argomentazione, invocata dalle ditte mediche private, secondo cui i prezzi proibitivi dei loro prodotti sarebbero legati al “bisogno” di profitti per essere ridistribuiti come dividendi ai proprietari del capitale e agli “incentivi” che “devono” creare per i loro brillanti ricercatori, diventa quasi oscena dal punto di vista dell’economia esistenziale, se questi ricercatori devono trovare i rimedi che aiutano persone dipendenti e sofferenti.
In effetti, gli incentivi al capitale umano nella ricerca medica sono del tutto simili a un’operazione di dirottamento in cui soggetti, finanziariamente e intellettualmente ben dotati, organizzano operazioni di estrazione di surplus (spesso finanziate, intenzionalmente, con fondi pubblici nelle nostre democrazie capitaliste socialiste) sfruttando la sofferenza di altri soggetti che aspettano i rimedi e le tecnologie. Poiché, all’interno della logica esistenziale del capitalismo, sono gli stessi soggetti, finanziariamente e intellettualmente ben dotati, che tendono a rifiutarsi di pagare tasse più alte e contributi di sicurezza sociale più elevati (e tendono a spostare il loro capitale in aree meno pesantemente tassate quando possibile), i responsabili delle decisioni politiche, esistenzialmente ansiosi e assetati di potere, tendono a chiudere un occhio su questo rifiuto e a “reprimere”, invece, quei soggetti che rimangono immobili: i pazienti meno fortunati, che in precedenza sono stati definiti le vere vittime dell’attuale sistema sanitario. Ciò fornisce, agli occhi di una certa critica sociale anticapitalista, la migliore motivazione per ritirare, legalmente, la produzione di farmaci e tecnologie mediche dalle mani delle imprese a scopo di lucro e renderla dominio esclusivo delle imprese pubbliche e senza fini di lucro. In effetti, la farsa di dare, strategicamente, in modo “compassionevole”, dei prodotti di prima linea dovrebbe essere sostituita da donazioni, sinceramente compassionevoli, del proprio tempo ed energia nello sforzo di scoprire rimedi e tecnologie che diano aiuto e conforto a coloro che condividono con il ricercatore, l’imprenditore e il politico la stessa fragilità e dipendenza esistenziali.
Tuttavia, anche un tale cambiamento dall’estrazione privata alla gratuità associativa e pubblica non sarebbe di per sé garanzia di successo. Un avanzamento sociale di tale portata richiederebbe un cambiamento fondamentale nell’ideologia generale perché, come la storia ha dimostrato, abbondantemente, le persone all’interno delle “organizzazioni a scopo di lucro”, delle istituzioni e degli enti pubblici possono soccombere alla stessa negazione della morte e alla stessa fantasia di onnipotenza esistenziale che rende il capitale privato un’impresa così rapace. “Rapidità senza fini di lucro”, ad esempio, sotto forma di servizi di bassa qualità, camuffati come costose disposizioni o sotto forma di auto-ingrandimento burocratico dei dirigenti delle “organizzazioni non profit”, non è affatto preferibile alla rapina per fini di lucro.
L’economia esistenziale può venire insieme con l’etica della cura al fine di sostenere una rinnovata “costituzione economica” per le nostre democrazie. La chiave di questo cambiamento è la consapevolezza che la gestione del terrore della morte è alla base del nostro comportamento economico e delle nostre opinioni politiche. Se l’economia esistenziale ci insegna una cosa, è che il futuro dell’assistenza sanitaria sta nel ripensare a ciò che la motivazione umana significa una volta che l’imperativo della lucidità esistenziale ha rimpiazzato il cieco brancolare delle fantasie dell’immortalità. Il filone femminista dell’etica della cura può certamente offrire risorse in questa impresa, sia essa solo scavando più profondamente negli specifici atteggiamenti femminili verso la fragilità, la sofferenza e la morte. Può darsi che, per inevitabili ragioni biologiche, non sempre sufficientemente riconosciute dalle femministe postmoderne, le donne abbiano una più spontanea capacità di lucidità esistenziale perché i loro corpi sono “abitati”, più eloquentemente, dalla lotta tra la morte e la Vita, tra la piccola finitudine e la Grande Infinità. La lucidità femminile mostra, sia ai maschi che alle femmine, che la nostra coscienza è il “luogo” in cui, con strumenti che non sono solo i nostri corpie le nostre menti ma tutto il nostro organismo senziente e orientato ai significati, trasmutiamo l’ansia nella libertà (che accetta l’ansia), le costrizioni della morte nell’apertura (che accetta la morte) della vita, i piccoli momenti finiti dell’esistenza convenzionale nel “senza tempo ora” (che accetta la finitezza).
Le implicazioni per l’economia della salute – e per l’economia in generale – sono di vasta portata e possono persino essere rivoluzionarie. Se si vuole una sorta di autonomia e autolimitazione da parte di tutti gli attori nel campo dell’assistenza sanitaria, senza dover rinunciare, semplicemente, alle meccaniche esistenzialmente cieche della gestione tecnocratica del bilancio, la lucidità esistenziale condivisa è migliore di una nozione parziale di responsabilità individuale. Una certa idea di preoccupazione personale per la propria salute è importante, ma questa preoccupazione non dovrebbe essere formulata in termini di “responsabilità” atomizzata e asimmetrica. Questa breve argomentazione ha, semplicemente, scalfito la superficie ma il progetto dell’economia esistenziale è appena iniziato. Avrebbe, dal punto di vista della critica sociale anticapitalista, un futuro auspicabile e le nostre vite economiche potrebbero diventare il luogo di gratuità, di cura e di compassione che tutti noi umani aneliamo, nonostante il nostro accanito ragionamento basato sull’incentivo.
- Franco Crespi (Crespi d’Adda, 24 maggio 1930 – Perugia, 25 agosto 2022) è stato un sociologo italiano, professore emerito di sociologia all’Università degli Studi di Perugia.
- Franco Crespi. Esistenza-come-realtà. Orthotes Editrice, Nocera Inferiore, SA, 2013
- Esponenti di quest’élite sono, ad esempio, Christian Léonard e Christian Arnsperger. Léonard è un matematico all’Université Paris Nanterre impegnato nel campo della teoria della probabilità e dell’analisi funzionale [settore dell’analisi matematica che si occupa dello studio di spazi di funzioni che affonda le sue radici storiche nello studio delle “trasformate” come la trasformata di Fourier e nello studio delle equazioni differenziali e integrali]. Arnsperger è un economista, professore di sostenibilità e antropologia economica alla Faculty of Geoscience and Environmental Studies (FGSE) dell’Institute for Geography and Sustainability (IGD) in Lausanne, Svizzera. Da anni impegnato nella ricerca nell’interfaccia tra analisi economica, scienze umane e filosofia esistenziale. È un esperto in post-consumismo, in alternative alla post-crescita economica e nella connessione tra transizione ecologica e il cambiamento di mentalità e di stili di vita. Consulente della Alternative Bank Switzerland (ABS) nell’area della finanza sostenibile.
- Per una sintesi della visione dell’economia esistenziale applicata nell’ambito dell’assistenza sanitaria, vedasi il loro paper Christian Léonard, Christian Arnsperger. «You’d better suffer for a good reason: Existential economics and individual responsibility in health care», Revue de philosophie économique 2009/1 (Vol. 10), p. 125-148
- In psicologia, la resilienza è un concetto che indica la capacità di far fronte in maniera positiva a eventi traumatici, di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà, di ricostruirsi restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre, senza alienare la propria identità.
- Christian Léonard, Christian Arnsperger. op. cit. Revue de philosophie économique 2009/1 (Vol. 10), p. 125-148
- Yalom I., 1980, Existential Psychotherapy, New York, Basic Books.
- Duval J. Le mythe du «trou de la Sécu», Paris, Raisons d’agir. Paris, 2007
- Léonard C. Croissance contre santé: quelle responsabilisation du malade? Couleur Livres, Bruxelles, 2006
- Il comportamentismo (o behaviorismo o psicologia comportamentale) è un approccio alla psicologia, sviluppato dallo psicologo John Watson agli inizi del Novecento, basato sull’assunto che il comportamento esplicito dell’individuo è l’unica unità di analisi scientificamente studiabile della psicologia, avvalendosi del metodo stimolo (ambiente) e risposta (comportamento), in quanto direttamente osservabile dallo studioso.
- Ansperger C. Critique de l’existence capitaliste: pour une éthique existentielle de l’économie, Le Cerf. Paris, 2005
- Becker E. The Life and Death of Meaning: An Interdisciplinary Perspective on the Problem of Man, 2nd ed. Free Press, New York, 1971
- – The Denial of Death. Free Press, New York, 1973
- – Escape from Evil. Free Press, New York, 1975
Brown N.O. Life Against Death: The Psychoanalytical Meaning of History. Wesleyan University Press, Middletown, 1958
- La teoria della gestione del terrore ipotizza che, per gestire il potenziale terrore dovuto alla consapevolezza della mortalità, noi, esseri umani, manteniamo la fede in una visione del mondo che dia a noi l’impressione di essere entità dotate di significato all’interno di un mondo duraturo e pieno di senso, piuttosto che meri animali composti di materia e destinati, dopo la morte, all’oblio. Tale teoria è stata sviluppata per spiegare le ragioni fondamentali quali la difesa della propria autostima e il pregiudizio. Essa è fondata su una lunga riflessione in merito alla consapevolezza umana della morte e il suo ruolo nel funzionamento psicologico. Una esposizione articolata della teoria la si trova nell’opera The Handbook of Theories of Social Psychology, Sage Pubns Ltd, 2011, nel capitolo 19, Terror Managenment Theory, a cura di Jeff Greenberg e Jamie Arndt.
- Jonas E., Fritsche I. and Greenberg J., 2005, “Currencies as Cultural Symbols: An Existential Psychological Perspective on Reactions of Germans Toward the Euro”, Journal of Economic Psychology, vol. 26, p. 131
- Christian Léonard e Christian Arnsperger «You’d better suffer for a good reason: Existential economics and individual responsibility in health care», Revue de philosophieéconomique 2009/1 (Vol. 10), p. 125-148
- Bauman Z. Mortality, Immortality, and Other Life Strategies. Stanford University Press, Cambridge, 1992.
- Turley D. “Death, Where Is Thy Sting? Mortality and Consumer Motivation in the Writings of Zygmunt Bauman”, in S. Ratneshwar, D.G. Mick (eds.), Inside Consumption: Consumer Motives, Goals and Desires. Routledge, London, 2005
- Bakan J. The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power. Free Press, London, 2004
- Boltanki L. et Chiapello E. Le nouvel esprit du capitalisme. Gallimard, Paris, 1999
- Blackburn R. Banking on Death or, Investing in Life: The History and Future of Pensions. Verso, London, 2002
- Moreau M. Le gouvernement des riches. La Découverte, Paris, 2004
- Christian Léonard, Christian Arnsperger. Léonard «You’d better suffer for a good reason: Existential economics and individual responsibility in health care», Revue de philosophie économique 2009/1 (Vol. 10), p. 125-148
- Christian Léonard, Christian Arnsperger. Léonard «You’d better suffer for a good reason: Existential economics and individual responsibility in health care», Revue de philosophieéconomique 2009/1 (Vol. 10), p. 125-148
- Condizionato nel senso che le strutture sociali condizionano il comportamento degli individui, come suggerisce Pierre Bourdieu nella sua critica sociale del gusto e del consumo nella Francia del dopoguerra. La distinction: critique sociale du jugement. Minuit, Paris, 1979
- Christian Léonard. La responsabilisation du patient: questions économiques et philosophiques, BIS – Bruxelles Informations Sociales, n 159, 2008
- Arnsperger Christian. L’État social actif comme nouveau paradigme de la justice sociale: l’avènement du solidarisme responsabiliste et l’inversion de la solidarité, dans P. Vielle, P. Pochet et I. Cassiers (éds.), L’État social actif: vers un changement de paradigme, Bruxelles, Peter Lang. 2005
- Yoder S.D., 2002, “Individual Responsibility for Health: Decision Not Discovery”, Hastings Center Report, vol. 32, n°2, p. 22-31.
Wittenberg E., Goldie S.J., Fischhoff B. and Graham J.D., 2003, “Rationing Decisions and Individual Responsibility for Illness: Are All Lives Equal?”, Medical Decision Making, May-June 2003, p. 194-211.
Resnik D.B., 2007, “Responsibility for Health: Personal, Social, and Environmental”, Journal of Medical Ethics, vol. 33, p. 444-445.
Buetow S., 2005, “High Need Patients Receiving Targeted Entitlements: What Responsibilities Do They Have in Primary Health Care?”, Journal of Medical Ethics, n°31, p. 304-306.
Cappelen A.W., Norheim O.F., 2005, “Responsibility in Health Care: A Liberal Egalitarian Approach”, Journal of Medical Ethics, vol. 31, p. 476-480.
- In occasione della conferenza “La santé d’âge en âge” organizzata da Pfizer a Parigi il 23 novembre 2005, Louis Couillard, CEO di Pfizer, lamentava un’”insufficiente responsabilizzazione delle persone riguardo al problema dell’assistenza sanitaria”.
- In Belgio, ad esempio nel settore odontoiatrico, il sistema funziona come segue. Finché sei in contatto con il tuo dentista almeno una volta all’anno, la rimozione preventiva del tartaro viene rimborsata. Se, per qualsiasi ragione, ometti di andare dal dentista per più di un anno, la “sanzione di responsabilità” è che la successiva rimozione del tartaro sarà interamente a tue spese. Ciò rende impossibile per molti poveri, che non hanno i mezzi per pagare un intero check-up, per “risalire”. Pertanto, il fatto di non essere “individualmente responsabili” anche per un breve periodo di tempo può comportare l’espulsione totale dal sistema – un modo conveniente per ridurre i costi, tra le altre cose.
- C. Léonard & C. Arnsperger You’d better suffer for a good reason: existential economics and individual responsibility in health care. Revue de Philospphie économiche. I, Vol. 10. pages 125 à 148, 2009
- Illich I. Limits to Medicine: Medical Nemesis, the Expropriation of Health. Random House, New York, 1976
- Christian Léonard, Christian Arnsperger. Léonard «You’d better suffer for a good reason: Existential economics and individual responsibility in health care», Revue de philosophie économique 2009/1 (Vol. 10), p. 125-148
- E. Becker. Escape from Evil. Free Press, New York, 1975
- Brown N.O. Life Against Death: The Psychoanalytical Meaning of History, Wesleyan University Press, Middletown
- Arnsperger C., Critique de l’existence capitaliste: pour une éthique existentielle de l’économie, Le Cerf. Paris, 2005
- C. Arnsperger. Éthique de l’existence post-capitaliste: pour un militantisme existentiel, Paris, Le Cerf, Paris, 2009
- Foucault M. Histoire de la sexualité, vol. 3, Le souci de soi. Gallimard, Paris, 1984
– Le gouvernement de soi et des autres. Cours au Collège de France (1982-1983), Gallimard, Paris, 2008
- Macintyre A. Rational Dependent Animals: Why Human Beings Need the Virtues. Open Court, Chicago, 1999








