BIO – Medicina Costruzione Sociale nella Post-Modernità – Educational Papers • Anno VIII • Numero 31 • Settembre 2019
I problemi della logica di attribuire gli stati emozionali umani agli animali non umani
Considerare che cani e gatti provino gelosia sembra una convinzione abbastanza stabilita nel senso comune. Sicuramente, potrebbe trattarsi di semplice antropomorfismo ma potremo chiedere agli studiosi quanto ne siano certi. Infatti, tale domanda è stata oggetto dell’attenzione di Paul Thagard1, filosofo e professore di scienze cognitive2. Per collocarci in una prospettiva propizia all’argomentazione potrebbe essere sufficiente prestare attenzione quando in un ambiente domestico esistono due gatti e la persona che fa da padrone accarezza solo uno di loro. Molto probabilmente, il gatto non accarezzato tende ad attaccare quello che ha ricevuto l’attenzione. Per analogia con l’uomo, viene naturale interpretare tale comportamento come gelosia pur se potrebbe ben essere altrettanto plausibile che il gatto che non ha ricevuto le carezze stia semplicemente tentando di affermare il suo dominio o stabilendo una sua territorialità. A quanto pare non ci sono studi sperimentali sui gatti per poter discriminare tra gelosia e ipotesi alternative, ma gli studi3 sui cani sostengono l’affermazione che, in realtà, diventano gelosi.
La logica di attribuire gli stati emozionali umani agli animali non umani pare sia complicata. Ad esempio, in un tale ragionamento non si potrebbe usare l’inferenza deduttiva perché non ci sarebbero regole generali che ci dicano che quando un animale mostra un comportamento specifico, allora sia geloso. Anche la teoria della probabilità risulta, anch’essa, inutile perché non conosciamo la probabilità del comportamento di un animale geloso, il che si rende necessario per calcolare la probabilità che effettivamente lo sia. Invece, si può utilizzare una forma di ragionamento che i filosofi chiamano “inferenze alla migliore spiegazione”. Secondo questo principio, possiamo, legittimamente, dedurre che i gatti o i cani siano gelosi qualora tale ipotesi fornisca la migliore spiegazione di tutte le prove disponibili.
Diversi fattori possono contribuire a determinare la migliore spiegazione4. Innanzitutto, bisogna considerare quanto esauriente possa essere un’ipotesi nella sua spiegazione. Ad esempio, l’ipotesi che il gatto Ciccio sia geloso del gatto Pippo spiegherebbe perché Ciccio attaccherebbe Pippo ogni volta che Loretta, la loro padrona, accarezza Pippo. Secondo, bisognerebbe esaminare se ci siano ipotesi alternative che potrebbero spiegare di più la questione? Ad esempio, forse Ciccio vuole solo essere dominante, anche se questo non spiega perché gli attacchi di Ciccio su Pippo sono molto più comuni quando Pippo attira l’attenzione della sua padrona. Terzo, bisogna valutare anche se l’ipotesi in esame sia più semplice delle ipotesi alternative nel senso che comporta meno supposizioni oppure meno assiomi. Un esempio di un’ipotesi non semplice sarebbe che Ciccio attacca Pippo perché è sotto il controllo di alieni spaziali, il che richiederebbe ulteriori presupposti sull’esistenza e le azioni degli alieni. In quarto luogo, bisogna chiedersi se l’ipotesi può ottenere ulteriore supporto da una spiegazione del perché essa sia vera. Ad esempio, idealmente si possono identificare i meccanismi psicologici e neurali che rendono Ciccio geloso e lo spingono ad attaccare Pippo. Mettendo insieme tutti questi fattori, si presume, si può essere in condizioni di accettare la conclusione che Ciccio sia geloso dovuta la sua coerenza esplicativa complessiva.
Certamente, prima di determinare se cani e gatti provino gelosia, si deve chiarire che cosa si intenda per gelosia. Non esiste una definizione standard ma la ricerca psicologica suggerisce che qualsiasi definizione debba essere sostituita presentando tre aspetti del concetto: esempi standard, caratteristiche tipiche e spiegazioni5. Infatti, ci sono esempi letterari e familiari di gelosia, come nel dramma di Otello di William Shakespeare e nel romanzo “Rebecca” di Daphne du Maurier. Ugualmente, la maggior parte di noi, adulti, può ricordare esempi di gelosia dalla propria esperienza.
Le caratteristiche tipiche della gelosia includono la persona che è gelosa, la persona amata, che è la causa della gelosia, e il rivale, che è l’oggetto della gelosia. Otello era geloso perché pensava che sua moglie Desdemona fosse coinvolta sentimentalmente con il soldato Cassio. La gelosia differisce dall’invidia, che richiede solo due individui. Essere geloso richiede anche un rivale per minacciare la relazione.
Le emozioni tipiche che accompagnano la gelosia includono la paura della perdita, la minaccia alla relazione, la tristezza, la rabbia, l’ansia e l’insicurezza. L’attribuzione della gelosia fornisce spiegazioni sul perché le persone stanno vivendo queste emozioni e sul perché si comportano in modi che vanno dal ritiro all’aggressione, talvolta persino all’omicidio.
La prima e più debole delle prove che gatti e cani provino gelosia risiederebbe nel fatto che la maggior parte dei loro proprietari pensa che, effettivamente, siano gelosi. Uno studio del 2008, interessato ad indagare l’ipotesi della manifestazione di emozioni secondarie in specie non primate, come i gatti e i cani, attraverso le dichiarazioni soggettive dei loro padroni, ha stabilito che l’81% dei proprietari di cani e il 66% dei proprietari di gatti hanno denunciato la manifestazione della gelosia nei loro animali domestici, il che potrebbe essere spiegato supponendo che gli animali domestici siano davvero gelosi6. Un’ipotesi alternativa è che le persone che sono attaccate ai loro animali domestici esagererebbero la complessità mentale degli animali domestici. Stando allo studio di Harris, Doe & Godsell, ad esempio, il 74% delle persone ha riferito che i loro cani, a volte, si sentivano colpevoli. Sperimenti7, presumibilmente accurati, hanno mostrato che l’apparente senso di colpa, come un cane che si mette le zampe in testa, potrebbe essere meglio spiegato dalla sottomissione dovuta alla paura della punizione. Il fatto controverso è che i cani sembrano comportarsi allo stesso modo, indipendentemente dall’aver fatto qualcosa di sbagliato o meno. Molti proprietari religiosi di animali domestici credono che i loro cani e gatti abbiano un’anima, credenza per la quale non ci sono prove.

I cani mostrano comportamenti analoghi a quelli osservati nei bambini sotto i due anni
Un sostegno molto più forte alla teoria della gelosia nei cani proviene da uno studio8 del 2014 condotto dalle psicologhe Christine Harris e Caroline Prouvost all’Università della California, a San Diego. Loro hanno adattato un disegno sperimentale utilizzato per identificare una forma non verbale di gelosia nei bambini di sei mesi. Stando alle inferenze statistiche dello studio, i bambini hanno avuto reazioni più negative quando le loro madri prestavano attenzione a un altro bambino rispetto a quando le madri prestavano attenzione a un libro. Analogamente, quando i cani vedevano i loro proprietari interagire con un cane falso ma realistico, i cani mostravano più aggressività sotto forma di morsi e attacco con le zampe, oltre a più ricerca di attenzione e interruzione dell’interazione. Al contrario, quando i proprietari prestavano attenzione ad una lanterna di Halloween o ad un libro, i cani non mostravano più aggressività e ricerca di attenzione. Uno scettico potrebbe temere che i cani stessero semplicemente reagendo a uno strano oggetto, il cane falso, ma i cani nell’esperimento non sembravano rendersi conto che i cani erano falsi e fiutavano le loro estremità posteriori.
Tuttavia, sarebbe possibile che il comportamento dei cani sia il risultato di “stati emozionali” diversi dalla gelosia, come, ad esempio, dal desiderio di stabilire dominanza sul nuovo cane oppure da un risentimento perché il cane falso starebbe sfidando la sua territorialità. Uno studio9 del 2018 dell’etologo ungherese Judit Abdai e colleghi hanno modificato ancora il disegno dell’esperimento per ridurre le interpretazioni alternative. In questo caso, i cani rivali verso i quali i proprietari avevano mostrato affetto erano reali piuttosto che falsi, escludendo l’ipotesi che l’aggressione dei cani fosse dovuta semplicemente a uno strano oggetto. Inoltre, per evitare che i cani fossero territoriali, gli esperimenti sono stati eseguiti in un luogo non familiare piuttosto che nelle case dei cani. Gli esperimenti confrontavano anche il comportamento dei cani rispetto ai rivali familiari e non familiari, per garantire il controllo delle questioni di dominanza, eliminando un’associazione con il rango. Altre disposizioni sperimentali avrebbero reso poco plausibile il fatto che le risposte dei cani derivassero da protezione, giocosità o noia.
I ricercatori, con le loro disposizioni sperimentali ed inferenze statistiche, conclusero che i cani mostravano comportamenti simili a quelli osservati nei bambini sotto i due anni, precedentemente ritenuti atteggiamenti di gelosia. Tuttavia, resistettero alla tentazione di concludere che i cani partecipanti all’esperimento stessero, effettivamente, vivendo l’emozione della gelosia, preferendo la conclusione, più cauta, che i cani mostravano un comportamento simile ad un nostro modo di agire che noi umani riteniamo sia originato dalla “gelosia”.
Ma per ridurre le incertezze nelle loro conclusioni gli studiosi si chiesero anche quali potevano essere i meccanismi psicologici e neurali che rendevano i cani “gelosi”? Quando investigatori, giurie e giudici cercano di determinare se i criminali accusati siano veramente colpevoli, loro considerano le motivazioni e le prove spiegate dall’ipotesi che l’imputato abbia, effettivamente, commesso i crimini. Per esempio, l’ipotesi che un accusato abbia ucciso una vittima diventa più plausibile se ci sono prove che l’accusato avesse provato rabbia, odio o gelosia nei confronti della vittima. Allo stesso modo, i ricercatori cercano più che semplici prove spiegate da un’ipotesi: cercano anche di spiegare l’ipotesi con meccanismi sottostanti. In questa prospettiva metodologica, Charles Darwin non aveva semplicemente fornito prove che le specie si siano evolute; aveva anche fornito un meccanismo di base per l’evoluzione derivante da variazione, ereditarietà e selezione naturale. Successivamente, la teoria genetica fornì un meccanismo per la variazione e l’ereditarietà, e la genetica fu ulteriormente approfondita dai meccanismi del DNA dalla biologia molecolare.
Allo stesso modo, l’ipotesi che i cani siano gelosi acquisirebbe profondità se potessimo spiegare perché i cani siano gelosi in termini di meccanismi psicologici e neurali. I meccanismi psicologici rilevanti sono, stando agli studiosi, l’attaccamento e la paura della perdita. Ci sono ampie prove che gli animali domestici diventano emotivamente attaccati ai loro proprietari, come si nota nell’angoscia che esibiscono quando i proprietari li lasciano soli, oppure nel comportamento di dolore che talvolta si osserva quando i proprietari muoiono. Quindi, l’attaccamento che gli animali domestici provano per i loro proprietari spiega perché si sentono minacciati dall’attenzione dei loro proprietari ad altri animali. I proprietari di animali segnalano10 che il grado di gelosia che si osserva nei gatti e nei cani varia a seconda di quanto cani e gatti siano affezionati ai loro proprietari. Questa osservazione può anche spiegare perché le persone pensano che i cani siano più gelosi dei gatti, dato che generalmente i cani sono più attaccati ai loro proprietari rispetto ai gatti.
I meccanismi psicologici, oggi, vengono progressivamente interpretati in termini di meccanismi neurali sottostanti. E anche se le scansioni cerebrali, come la risonanza magnetica funzionale (fMRI), vengono utilizzate per identificare le aree cerebrali che interagiscono per produrre stati mentali come le emozioni, alcuni studiosi considerano che sarebbe follia cercare un centro della gelosia nel cervello degli umani e di altri animali, perché le emozioni e altri tipi di cognizione comportano interazioni tra molte aree del cervello, come sostengono Lindquist, Wager, Kober, Bliss-Moreau e Feldman Barrett riassumendo le conclusioni delle loro ricerche su eventuali fondamenti cerebrali delle emozioni11.
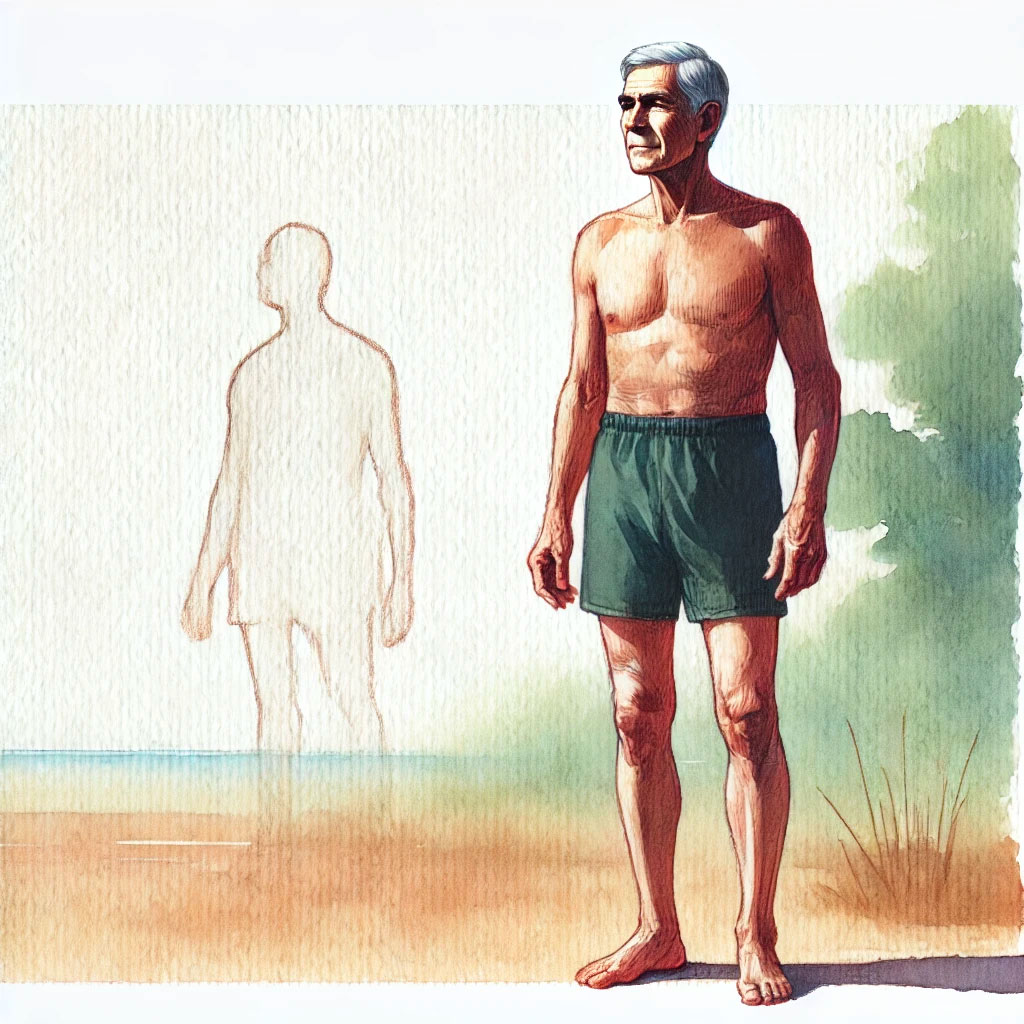
L’attivazione dell’amigdala non determina la gelosia
L’anno scorso, dei ricercatori hanno addestrato dei cani a rimanere fermi nelle macchine di risonanza magnetica [fMRI] allo scopo di identificare le aree cerebrali attive durante i compiti da svolgere. Questo studio di imaging cerebrale, condotto dallo psicologo Peter Cook e colleghi presso il New College of Florida12, ha, a loro avviso, fornito prove circa la gelosia nei cani. L’idea era che, scansionando i cervelli di questi cani, i ricercatori avrebbero verificato che i cani sottoposti a guardare i loro badanti dare una ricompensa alimentare a un cane falso avrebbero mostrato una maggiore attivazione nell’amigdala, rispetto a quando i loro assistenti si limitavano semplicemente a mettere il cibo in un secchio. Avrebbero, anche, documentato la loro ipotesi che i cani precedentemente giudicati più aggressivi avrebbero mostrato più attivazione dell’amigdala rispetto a quelli con temperamenti meno aggressivi. A dir loro, entrambe le previsioni sarebbero state confermate.
Di per sé, questo esperimento non può dimostrare che uno di questi cani scannerizzati sia geloso del cane falso, proprio perché ci sono ipotesi alternative. Il cane potrebbe reagire, semplicemente, per un senso di fastidio, invidia, ostilità o ingiustizia piuttosto che per gelosia. L’attivazione dell’amigdala, come segnala Thagard, non metterebbe in evidenza la gelosia, in quanto sarebbe anche associata ad altre emozioni come ansia, rabbia, paura e persino alcuni sentimenti positivi.
Tuttavia, questo esperimento è pertinente al fatto che i cani siano gelosi dato che indica un meccanismo neurale che può spiegare come i cani si comportano in un modo che noi umani possiamo ritenere “geloso”. Quando un cane vede il suo proprietario essere generoso con un altro cane, esso risponde alla situazione con l’attivazione di neuroni in una parte del cervello associata ad emozioni negative e aggressività. L’attivazione dell’amigdala, in questa prospettiva, conduce, eventualmente, ad azioni aggressive, come il ringhio e il mordere. In ogni caso, sono necessarie molte ulteriori ricerche sia sugli esseri umani che sugli animali domestici che forniscano maggiori dettagli sui meccanismi neurali della gelosia, ma lo studio di Cook viene ritenuto un inizio da alcuni studiosi.
Ma l’elenco di ricerca accennata precedentemente può essere ritenuto sufficiente per dimostrare che i cani siano gelosi? Dov’è “l’onere della prova”13? Infatti, secondo questo principio logico-argomentativo chi vuole dimostrare l’esistenza di un fatto ha l’obbligo di fornire le prove per l’esistenza del fatto stesso. Nelle prove legali all’interno del sistema giudiziario britannico, che viene utilizzato anche in altri paesi come gli Stati Uniti e il Canada, esistono due diversi standard di prova. Nei procedimenti penali, all’accusa è richiesta di dimostrare che l’accusato sia colpevole oltre ogni ragionevole dubbio. Questo criterio viene applicato a causa del giudizio etico secondo cui è peggio condannare un innocente piuttosto che lasciarlo colpire, giustificando la presunzione di innocenza.
Al contrario, lo standard di prova nelle cause civili è solo la preponderanza delle prove. Se una persona fa causa a un altra, il giudizio viene raggiunto in base al fatto se le prove nel complesso supportano la rivendicazione del ricorrente, senza richiedere che il giudizio sia vero oltre un ragionevole dubbio. Allo stesso modo, nelle controversie scientifiche in cui non vi son conseguenze pratiche dirette ad accettare una delle due conclusioni, l’onere della prova è la preponderanza delle prove piuttosto che il ragionevole dubbio, in cui la preponderanza può essere valutata mediante coerenza esplicativa.
Stando alla valutazione di Paul Thagard, l’attuale situazione è, ancora, che sussiste un ragionevole dubbio sul fatto che i cani siano gelosi. È possibile che i loro comportamenti osservati, nella vita ordinaria e negli esperimenti scientifici, derivino da reazioni che non implicano la percezione di rivali come minacce relazionali o la combinazione di emozioni come paura, rabbia e tristezza che si aggiungono alla gelosia. Tuttavia, Thagard ritiene che la preponderanza delle prove, tratte da esperimenti comportamentali, imaging cerebrale e osservazioni dei proprietari, supporti la conclusione che i cani sono, davvero, gelosi.
Ma, la conclusione sulla gelosia dei cani hae problemi legati alla complessità della cognizione animale e al problema della coscienza. L’attribuzione della gelosia ad animali diversi dagli umani può essere contestata sostenendo che gli altri animali non hanno la complessità cognitiva per essere gelosi. Negli umani adulti, la gelosia richiede un giudizio del tipo: la mia relazione con la mia persona amata è minacciata dall’interesse della persona amata per un rivale. Gatti e cani non hanno nemmeno un senso di sé, come dimostra la loro incapacità di riconoscersi negli specchi. Quindi, non hanno nemmeno abbastanza concetto di “io”, per non parlare del senso di una relazione che coinvolge una triade di tre individui: la persona amante, la persona amata e la persona rivale.
Tuttavia, nella prospettiva di una revisione critica e ripensando lo sviluppo delle emozioni non elementari, si può suggerire14 che la gelosia può insorgere molto prima che i bambini inizino a riconoscersi negli specchi intorno all’età di 18 mesi. Stando a questo modello, essere gelosi non richiede di avere un senso pieno di sé ma solo una minima consapevolezza di essere distinti dagli altri e di riconoscersi in qualche tipo di relazione emotiva. Come i neonati, gatti e cani sono capaci di questo tipo di consapevolezza, come è dimostrato dal modo in cui usano e toccano il proprio corpo, ad esempio quando i gatti si leccano per diventare puliti. Gli animali domestici possono non essere in grado di descrivere verbalmente le loro relazioni con i loro proprietari, ma molti comportamenti suggeriscono l’esistenza di un legame “affettuoso”. Una sfida a questo legame, sotto forma di percezione dell’interesse del padrone in un altro animale domestico, è sufficiente a suscitare un’emozione che è, almeno, un’approssimazione della gelosia negli umani.
La conclusione che gli animali domestici provino gelosia non sarebbe da escludersi per problemi di cognizione
Un ragionamento simile giustificherebbe l’attribuzione dell’esperienza cosciente della gelosia negli animali domestici, non solo il comportamento geloso. Quando le persone attribuiscono coscienza a se stesse, la coerenza esplicativa della conclusione sarebbe forte perché ognuno di noi avrebbe una serie di esperienze coscienti tra cui dolore, emozioni, pensieri e autoconsapevolezza. Nonostante le proteste dei comportamentisti e di altri scettici sulla coscienza, non c’é una buona spiegazione alternativa delle nostre esperienze e dei nostri comportamenti di quanto noi siamo realmente consapevoli.
Estendere l’assegnazione della coscienza ad altri individui è più rischioso, perché noi non possiamo sperimentare le esperienze di altre persone. Tuttavia, le somiglianze tra i comportamenti di altri individui e i nostri, e tra i loro processi cerebrali misurabili e il nostro, rendono altamente plausibile che, anche, le altre persone siano coscienti. Questo confronto non risulta solo un argomento debole per analogia. Piuttosto, l’analogia tra le spiegazioni del proprio comportamento e le spiegazioni del comportamento di altre persone è solo una delle componenti che giunge alla conclusione che la migliore spiegazione di ciò che gli altri dicono e fanno sarebbe che, anche, loro sono consapevoli15.
L’analogia si indebolisce quando cerchiamo di estendere la consapevolezza ai bambini, ma sembra che il loro cervello abbia strutture e funzioni emotive molto simili a quelle degli adulti. Ci sono conoscenze simili su altri mammiferi come cani e gatti, ognuno dei quali possiede aree cerebrali come l’amigdala e la corteccia che contribuiscono alle emozioni umane, anche se le aree prefrontali umane sono più grandi. Potrebbero esserci dei dubbi ragionevoli sul fatto che gatti, cani e bambini non siano realmente consapevoli, ma la preponderanza di prove suggerisce che lo sono. Quindi la conclusione che gli animali domestici provano la gelosia non è da escludersi per problemi relativi alla coscienza o alla complessità della cognizione.
Gli esperimenti sopra menzionati riguardano solo la questione se i cani siano gelosi, lasciando aperto se anche i gatti lo siano. Coerentemente con le loro dimensioni corporee maggiori, i cani hanno cervelli con circa il doppio dei neuroni dei gatti16 . Tuttavia, l’organizzazione cerebrale dei gatti è la stessa di quella dei cani e di altri mammiferi, quindi la struttura del cervello non ci dovrebbe fare aspettare alcuna differenza rispetto alle emozioni.
D’altra parte, attraverso i circa 20.000 anni in cui i cani hanno sviluppato rapporti con gli umani, hanno acquisito abilità cognitive ed emotive che sembra non si trovino nei gatti. I cani sono, generalmente, più attenti e attaccati ai loro proprietari rispetto ai gatti, quindi è possibile che siano più inclini alla gelosia. Inoltre, sia per i cani che per i gatti possono esserci differenze tra le razze rispetto ai gradi di attaccamento e aggressività connessi alla gelosia. Queste differenze, insieme alla mancanza di qualsiasi esperimento comportamentale e neurale che supporti l’esistenza della gelosia nei gatti, suggerisce maggiore cautela nell’identificare la gelosia nei gatti rispetto a quanto attualmente sia logico per i cani.
Cosa dire riguardo Ciccio e Pippo? Diciamo che Ciccio è un birmano, razza ben nota per il suo affetto da cane per le persone. Al contrario, Pippo è un British shorthair [britannico a pelo corto], razza molto più conosciuta per il distacco che per l’affetto fisico. Forse questo è il motivo per cui Ciccio è molto più aggressivo nel reagire contro l’affetto a Pippo che viceversa. Nessuno dei due sembra particolarmente infastidito quando uno sconosciuto è affettuoso con l’altro, presumibilmente perché per loro lo sconosciuto è molto meno importante del loro padrone. In contrasto con la cosiddetta crescente evidenza scientifica che i cani siano gelosi, possiamo solo dedurre che Ciccio sia probabilmente geloso.
Anche se si presume comunemente che la gelosia sia unica per gli umani, in parte, come accennato, a causa delle complesse cognizioni spesso coinvolte in questa emozione, tuttavia, da una prospettiva funzionale, ci si può aspettare che un’emozione evolutasi per proteggere i legami sociali dagli “intrusi” possa esistere in altre specie sociali, in particolare, in una cognitivamente sofisticata, come quella dei cani.
In ogni modo, nell’ambito della ricerca riguardo la gelosia nell’animale umano sembra prevalga il rifiuto della posizione secondo la quale la gelosia è principalmente, una creazione della cultura e si preferisce concludere che la gelosia sia una risposta di angoscia innata che viene poi modificata dall’apprendimento, cioè dalla cultura. Ma quest’argomentazione, però, è stata condotta per il piacere di lasciarci affascinare con il filo logico del filosofo cognitivista Paul Thagard piuttosto che con lo scopo di condurci ad una scelta sulla possibilità, o meno, della gelosia in altre specie animali sociali, come quelle dei nostri cani e gatti domestici.
- Paul Thagard. The Brain and the Meaning of Life. Princeton University Press, 2010 / Paul Thagard. Il cervello e il senso della vita. Mondadori Education, 2014. Paul Thagard. Treatise on Mind and Society (Brain-Mind: From Neurons to Consciousness and Creativity, Mind-Society: From Brains to Social Sciences and Professions, Natural Philosophy: From Social Brains to Knowledge, Reality, Morality, and Beauty). Oxford University Press,
- Le scienze cognitive – essendo interdisciplinari – comprendono diverse discipline tra cui psicologia, informatica, intelligenza artificiale, neuroscienze, linguistica, antropologia, etologia e filosofia della mente.
- Christine R. Harris and Caroline Prouvost. Jealousy in Dogs. PLoS One, 9(7): e94597, 2014
- Paul Thagard. Explanatory coherence. In “Behavioural and Brain Sciences”, Vol. 12, Issue 3, pp. 435-467, Sept. 1989
- Blouw P, Solodkin E, Thagard P, Eliasmith C. Concepts as Semantic Pointers: A Framework and Computational Model. In “Cognitive Sciences”, 40 (5):1128-62, Jul. 2016
- Paul H. Harris, Christine Doe & Emma Godsell. Secondary emotions in non-primate species? Behavioural reports and subjective claims by animal owners. In “Cognition and Emotion”, Vol. 22, Issue 1, 2008
- Horowitz A. Disambiguating the “guilty look”: salient prompts to familiar dog behaviour. In “Behavioural Processes”, 81(3):447-52, Jul. 2009
- Harris CR, Prouvost C. Jealousy in Dogs. In “PLoS ONE”, 9(7): e94597. July 2014
- Abdai J, Baño Terencio C, Pérez Fraga P, Miklósi Á. Investigating jealous behaviour in dogs. In “Scientific Reports”, 8(1):8911, Jun 2018
- Eugene W. Mathes, Donna J. Deuger. Jealousy, a creation of human culture? In “Psychological Reports”, Vol. 51, Issue 2, pp: 351-354, October 1982
- Kristen A. Lindquist, Tor D. Wager, Hedy Kober, Eliza Bliss-Moreau & Lisa Feldman Barrett. The brain basis of emotion: A meta-analytic review. In “Behavioural and Brain Sciences”, Vol. 35, Issue 3, pp. 121-143, June 2012
- Peter Cook, Ashley Prichard, Mark Spivak & Gregory S. Berns. Jealousy in dogs? Evidence from brain imaging. In “Animal Sentience”, 22(1), 2018
- L’onere della prova è un principio logico-argomentativo in base al quale chi vuole dimostrare l’esistenza di un fatto ha l’obbligo di fornire le prove per l’esistenza del fatto stesso.
- Riccardo Draghi-Lorenz, Vasudevi Reddy & Alan Costall. Rethinking the Developmental of “Nonbasic” Emotions: A Critical Review of Existing Theories. In “Developmental Review”, Vol. 21, Issue 3, pp: 263-304, Sept. 2001
- Paul Thagard. Treatise on Mind and Society (Brain-Mind: From Neurons to Consciousness and Creativity, Mind-Society: From Brains to Social Sciences and Professions, Natural Philosophy: From Social Brains to Knowledge, Reality, Morality, and Beauty). Oxford University Press, 2019
- Jardim-Messeder D, Lambert K, Noctor S, Pestana FM, de Castro Leal ME, Bertelsen MF, Alagaili AN, Mohammad OB, Manger PR, Herculano-Houzel S. Dogs Have the Most Neurons, Though Not the Largest Brain: Trade-Off between Body Mass and Number of Neurons in the Cerebral Cortex of Large Carnivoran Species. In “Front Neuroanatomy”, 11:118. Dec. 12 2017 2








