“Noi siamo viandanti sul confine tra l’aldiquà e l’aldilà”
A pensarci bene, il malato oncologico – non necessariamente sinonimo di malato terminale – costituisce una sorta di enfatizzazione della condizione di malato cronico; e un richiamo al fatto che la malattia cronica più emblematica e diffusa è la nostra natura mortale. Mi sembra pertanto utile prendere le mosse da alcune riflessioni sul significato della malattia cronica, a partire dalla sconsolante osservazione che i medici vengono formati per affrontare l’acuzie e possibilmente “risolvere” il problema attuale ma non sono educati a misurarsi con qualcosa che “sta lì e non si decide”. Si finisce per intervenire risolutamente solo quando il malato cronico si scompensa; dunque, in un certo senso nelle fasi in cui si comporta da malato acuto.
Questo scarto, che ha radici appunto nella formazione, ha dei corollari significativi: come il notevole ritardo nella formulazione di un Piano Nazionale della Cronicità, varato intorno al 2000 nel mondo occidentale e soltanto nel 2016 nel nostro Paese. L’imponente sviluppo tecnologico dell’ultimo mezzo secolo, accanto a indubbi miglioramenti della qualità di vita, ha condotto a un titanismo nutrito di hybris, da cui si è imposta una visione eroica della medicina.
Quanto più umanistico e realistico suona il celebre aforisma attribuito al chirurgo francese Ambroise Paré (1510-1590) a proposito dell’attività del medico: “Guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours” [Guarire a volte, alleviare spesso, consolare sempre]. L’aforisma è probabilmente apocrifo: c’è chi lo attribuisce a Louis Pasteur o addirittura a Ippocrate; ma quel che qui si vuole sottolineare è che nelle attività di cura l’ascolto è di capitale importanza. Nel fronteggiare una malattia cronica grave si verifica un processo simile a un lutto di difficile elaborazione, anche perché la visione eroica di cui si parlava permea tutti i protagonisti della vicenda, compresi i parenti del malato. Il risultato è che il medico, oscillando tra sentimenti di onnipotenza e di impotenza, finisce per sentirsi frustrato, mentre il paziente sviluppa paura e rabbia: entrambi sono insoddisfatti, perché vorrebbero approdare a risultati risolutivi anziché accettare il fatto che molti casi possono essere curati ma non guariti.
A questo proposito la definizione di salute coniata nel 1948 dall’O.M.S. (“stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia”) mostra un eccesso di idealizzazione; tanto che lo stesso organismo, nel 1998, l’ha parzialmente rivista, auspicando “uno stato dinamico di completo benessere fisico, mentale, sociale e spirituale, non mera assenza di malattia”.
Dalla patologia alla Clinica
L’aumento dell’aspettativa di vita, col conseguente incremento di malattie croniche, richiederebbe un ulteriore sforzo di realismo, ponendo l’accento sulla capacità di adattamento ai cambiamenti legati all’invecchiamento e alla gestione delle inevitabili condizioni di cronicità ad esso collegate. Nella cronicità è più che mai necessario usare la lente della Clinica anziché quella della Patologia.
Già un secolo fa Giacinto Viola distingueva le scienze dell’universale, tra cui annoverava la Patologia, disciplina astratta deputata alla catalogazione e alla descrizione della media delle situazioni occorse; e le scienze dell’individuale, tra cui primeggia la Clinica, disciplina idiografica sin dal suo etimo: klínē significa letto e indica che la pratica clinica si esercita al capezzale del singolo individuo. Il transito dalla Patologia alla Clinica consente di passare da una medicina centrata sulla malattia a una medicina centrata sul malato: il che ha particolare valore nell’approccio al malato cronico, se è vero che negli stati acuti occorre valutare la malattia in quel malato, laddove nella cronicità il focus riguarda il malato con quella malattia. La terapia allora non si avvarrà soltanto di strumenti chimico-farmacologici o fisici, bensì dovrà mettere al centro la relazione e l’ascolto attivo.
“Per riportare il soggetto – il soggetto umano che soffre, si avvilisce, lotta – al centro del quadro, dobbiamo approfondire la storia di un caso sino a farne una vera storia, un racconto: solo allora avremo un “chi” oltre a un “che cosa”, avremo una persona reale […] in relazione alla malattia” (Sacks, 1985: 12).
Comunicare con il paziente – non semplicemente al paziente – è già un aspetto della cura: questo e altri principi fanno parte della Carta di Firenze, redatta nel 2005 da un gruppo di esperti del settore medico-sanitario per proporre le basi di un rapporto non paternalistico tra medico e paziente; quest’ultimo ha diritto alla piena informazione sulla diagnosi e sulle possibili terapie e alla libertà di scelta terapeutica.
La relazione si traduce così in una alleanza terapeutica atta a favorire una adeguata compliance. Quest’ultima, da alcuni studiosi opportunamente ribattezzata concordance, è direttamente proporzionale alla percezione, da parte del paziente, di ricevere una attenzione e degli interventi individuali, non standardizzati.
La medicina narrativa
Si realizzano in tal modo i principi fondanti della Medicina Narrativa, disciplina codificata negli anni ’90 del secolo scorso alla Columbia University da Rita Charon, medico internista e studiosa di letteratura. Si tratta di una modalità di relazione che pone particolare enfasi sulla storia della malattia così come viene vissuta dal paziente e sul suo contesto.
Gli studi della dottoressa Charon sono focalizzati sulla ricerca di nuove vie per migliorare la capacità dei medici di comprendere ciò che il paziente dice loro e di comunicare a loro volta. La Medicina Narrativa consente di spostare l’attenzione dal corpo fisico (körper) al corpo vissuto (leib) [1]. Frutto di una conoscenza multidisciplinare, è “un progetto di medicina centrata sul paziente” (Masini, 2005) e uno strumento di verifica del vissuto del medico. “Narrare l’esperienza di malattia è una strategia che può aiutare il paziente a rimettere insieme i suoi pezzi, le parti di quel sé che la malattia ha spesso prepotentemente frammentato” (Malvi, 2011).
La lingua inglese dispone di tre differenti termini per indicare la malattia: disease, che rappresenta unicamente un fatto statistico, ovvero una deviazione dalla norma biologica; illness, che si riferisce all’esperienza dell’esser malato; sickness, ovvero l’aspetto sociale della malattia. La terza e soprattutto la seconda accezione sono importanti per il nostro discorso. Su questi principi, da alcuni anni assistiamo allo sviluppo di una Oncologia Narrativa. Come ho detto all’inizio di questo scritto, “oncologico” può essere letto come amplificazione e specificazione di “cronico”. È pur vero che il malato oncologico evoca, in primis nel malato stesso ma anche nel medico, un vissuto catastrofico. È accertato, ad esempio, che la cancerofobia collettiva è responsabile di molte diagnosi tardive. Non ogni condizione tumorale conduce alla morte; tuttavia la chiama costantemente in causa.
Divario tra tecnologia e arte medica
In questi casi si tocca con mano [2] il divario tra medicina scientifico-tecnologica e arte medica. Ad esempio, dare ai pazienti soltanto informazioni cognitive non è sufficiente: occorre discutere il significato che si nasconde dietro ai dati. Inoltre ascoltare è importante quanto parlare: a questo proposito è stato dimostrato che il medico che abbia acquisito competenze sulla comunicazione si rivela più capace di empatia nei confronti del paziente. “Il medico è […] un essere umano transeunte insieme a un altro essere umano transeunte” (Jaspers, 1986: 108), capace di condividere col malato la precarietà della condizione umana. In nessuna situazione più di quella oncologica il lavoro del medico dovrebbe indirizzarsi verso il benessere del paziente, più che verso la sua mera sopravvivenza: in questi casi combattere a oltranza malattia e morte, avendo come unico obiettivo prolungare la vita purché sia, produce danni.
Il pensiero palliativista, in un certo senso, è un’occasione per rivedere l’atteggiamento del medico in generale, non soltanto al cospetto del malato oncologico. Cooperare affinché il paziente viva una vita degna momento per momento è obiettivo più nobile che prolungare i giorni.
Nel 2010, al Massachusetts General Hospital è stato effettuato uno studio su 151 pazienti affetti da carcinoma polmonare al quarto stadio. Metà dei soggetti ricevette, oltre ai farmaci convenzionali, cure palliative. Il risultato deve spingerci a riflettere: le cure palliative, infatti, produssero una precoce interruzione della chemioterapia (in una fase nella quale ormai l’indice terapeutico era basso), minor dolore e soprattutto – dato sconcertante alla luce dei nostri presuntuosi pregiudizi – un prolungamento della vita del 25% rispetto a chi non le ricevette. “La morale che se ne può trarre è quasi zen: si vive più a lungo quado si smette di cercare di vivere più a lungo” (Gawande, 2014: 170).
La morte di Ivan Il’ič
La mia conclusione è che tutti, come medici, siamo chiamati a imparare dal pensiero palliativista che il nostro lavoro dovrebbe indirizzarsi verso il benessere del paziente, non solo verso la mera sopravvivenza. Uno dei romanzi più istruttivi a tal proposito è certamente La morte di Ivan Il’ič, in cui Tolstoj descrive l’irrompere improvviso di una malattia inguaribile, dunque della morte, nella vita di un giudice, il quarantacinquenne Ivan Il’ič. La maggiore sofferenza del protagonista, più ancora dell’umiliante degrado prodotto dalla malattia, riguarda il senso di solitudine esistenziale nella quale si vede sprofondare. “Il più gran tormento di Ivan Il’ič era la menzogna: quella menzogna in cui tutti, chissà perché, s’accordavano, secondo la quale lui, anziché avviato alla morte, era semplicemente malato, e non aveva da far altro che star fermo e curarsi, e allora si sarebbe ottenuto un risultato eccellente” (Tolstoj, 1886). L’unico conforto proviene dai gesti naturalmente appropriati del mužik Gherasim, un ragazzo di origini contadine, che non teme la morte e comprende le sue esigenze e i suoi bisogni. “Gherasim faceva tutto con leggerezza, di buona voglia, semplicemente, e con una bontà che commoveva Ivan Il’ič” (Tolstoj, ibidem).
Questi riferimenti letterari, densi di spunti di riflessioni, confermano l’assunto della Medicina Narrativa che la formazione del medico dovrebbe nutrirsi anche di letteratura e di arte. Quando Ferenczi [3] scrive che “solo l’amore guarisce”, dice con un po’ di enfasi ciò che era chiaro già nell’antica Grecia. Secondo Platone, difatti, arte medica e musica sono entrambe “scienze dei moti d’amore” (erotikou epistemai). La mitologia greca ci insegna anche che la vita a tutti i costi non è sempre preferibile alla morte, come illustra il caso del maestro di Asclepio, il centauro Chirone il quale, colpito accidentalmente da una freccia scagliata dall’amico Eracle, ne ricava una ferita così dolorosa da indurlo a scambiare la sua immortalità con la mortalità di Prometeo. Questi era stato “degradato” da Zeus al rango di mortale, non solo e non tanto per aver elargito agli uomini (nei testi greci, riferendosi agli uomini, li si definisce brotoi, “i mortali”) il fuoco, quanto per aver donato loro l’oblio dell’ora della morte. “Spensi all’uomo la vista della morte”, dice Prometeo; al che la Corifea gli chiede: “Che farmaco trovasti a questo male?” Risponde Prometeo: “Seminai la speranza che non vede” (Eschilo, 460 a. C.).
Dal palliativismo alla cura
Tornando alla necessità di integrare il sapere medico con la sapienza che proviene dall’esperienza palliativista, penso che la Medicina Integrata dovrebbe avvalersi di questa esperienza, tra le altre che costituiscono il suo costrutto teorico e clinico-terapeutico. Bisogna cercare una misura che tenga conto dei dati scientifici e delle soggettività in campo, lavorando su sé stessi per gestire al meglio le cronicità. Significa coniugare cure (curare) e care (prendersi cura), iatriké (arte della cura) e therapeìa (servizio). Il pensiero palliativista è una teoria filosofica che sostiene una pratica medica messa in atto con una sensibilità psicologica, a sé e all’altro.
Concludo questo articolo con due resoconti tratti dalle mie esperienze cliniche. Il primo caso riguarda un paziente di area medica, il secondo una donna che ho seguito in psicoterapia.
Caso clinico 1
F. è un uomo di quasi 89 anni che seguo da decenni ma che raramente viene a farsi visitare. Mi telefona nel gennaio 2021 per uno stato febbrile che non recede dopo una settimana di terapie omeopatiche e convenzionali. Per questo motivo chiedo degli esami ematochimici. Per motivi personali, sui quali sorvolo, non mi dà riscontri per un paio di settimane, dopo le quali la moglie mi telefona dicendo che è ricoverato in un importante ospedale romano, dove gli hanno riscontrato una prostatite, una polmonite ma soprattutto una leucemia mieloide acuta. Non essendo proponibile, data l’età, nessuna terapia su base eziologica, lo indirizzano a un buon hospice, da dove però la moglie insiste per farlo dimettere, identificando l’hospice – sulla base di pregiudizi collettivi – come un luogo di morte.
A questo punto, pur dovendo ammettere di aver gettato la spugna, anche in seguito a un approfondito confronto con un ematologo di grande esperienza che mi conferma un orizzonte clinico di irreversibilità, vengo sollecitato dalla moglie a cercare soluzioni non convenzionali. Vado a domicilio del paziente e svolgo un colloquio preliminare e chiarificatore con la moglie, informandola sulla gravità della malattia e scoprendola in preda a un meccanismo di difesa basato sulla negazione. Al tempo stesso la metto a parte dell’esito delle mie ricerche – nel frattempo ho studiato la (poca) letteratura non convenzionale a riguardo – e troviamo un accordo che la aiuti a superare le sue diffidenze.
Inizio dunque a prescrivere, oltre a medicinali omeopatici classici, l’organoterapico Medulla ossis suis e complessi ispirati alla ricerca della Medicina Fisiologica di Regolazione [4]. Controllando quindicinalmente l’evoluzione dell’emocromo, rimango sbalordito nel constatare il progressivo avvicinarsi dei parametri a valori che non certificano certo una guarigione ma un approssimarsi a una condizione che posso definire in un certo senso di cronicizzazione.
I sanitari che lo seguono – ho convinto la moglie ad attivare un hospice domiciliare –, a partire dal medico di base, mi ripetono la stessa frase: “Non conosco l’Omeopatia ma questi risultati sono incredibili”. Come è naturale, cresce in proporzione la fiducia del paziente e della moglie – sono una coppia simbiotica senza figli – e procedo, ove possibile, a un lento scalaggio dei molti farmaci prescritti, oltre che alla controversa rimozione del catetere. Il paziente si alza dal letto e ritrova una buona autonomia fisica e di pensiero (è un importante musicista), esce per qualche passeggiata, va al ristorante, riprende con moderazione a fumare la pipa e soprattutto il suo lavoro di ricerca musicale.
Sintetizzo e concludo, riferendo che questa situazione si è protratta per oltre un anno, dunque ben al di là della prognosi “ufficiale”, iniziando a deteriorarsi nell’estate del 2022 per la presumibile ripresa di una attività mieloproliferativa. Il paziente muore nel novembre dello stesso anno, non prima di aver festeggiato, nel maggio 2022, i suoi 90 anni. Questa storia rientra nell’ambito dei cosiddetti case report, dunque non ha valore di ricerca. Tuttavia deve spingerci a ribadire l’importanza della Clinica come approccio al singolo caso e a valutare sempre, ove possibile, un intervento integrato. Inoltre la presa in carico del paziente e della sua famiglia dal punto di vista della qualità della vita può configurare questo caso come un esempio, sebbene empirico non avendo una formazione palliativista, di applicazione dei principi della Medicina Palliativa.[5]
Caso clinico 2
Il secondo caso, tratto come si è detto dal mio lavoro di psicoanalista, riguarda una donna di 47 anni che ho seguito dall’aprile del 2000 al marzo del 2002, giorno del suo quarantanovesimo compleanno: centocinquanta sedute al ritmo di due sedute settimanali, con brevi interruzioni dovute ad altrettanti ricoveri ospedalieri. Nella primavera del 1998, pochi mesi prima della diagnosi, L. aveva sognato che “dalla mammella destra schizzava fuori un alieno”. Nell’agosto del 1998, dopo un misconoscimento da parte di più medici [6], le era stato diagnosticato un carcinoma mammario destro. Tre mesi di chemioterapia preparano l’intervento di mastectomia radicale, che viene effettuata nel mese di novembre. All’operazione segue una radioterapia, allo scopo di venire a capo di alcune metastasi cutanee. Ad intervalli sempre più brevi ha dovuto far ricorso alla chemioterapia, che è rimasta una costante anche nel corso del lavoro analitico.
Al momento del nostro primo incontro, il 10 aprile [7] del 2000, un’ecografia ha da poco rivelato metastasi epatiche puntiformi, mentre una sua descrizione dello stato della mammella sinistra mi allarma circa la possibilità di una comparsa del carcinoma anche in quella sede. Il 17 maggio, dopo otto incontri, L. sospende le sedute per riprenderle il 12 giugno. Le è stata asportata anche la mammella sinistra che, come sospettavo, era stata invasa dal carcinoma.
Il primo sogno che mi porta rivela quanto le intuizioni dell’inconscio possano precedere le acquisizioni della coscienza: “Sono in camera di Priscilla (la figlia, n. d. A.) e prendo in mano un vaso di coccio […] vedo della materia nera e molliccia sotto il bordo del vaso. Penso: sono dei vermi. E lo sono. Allora mi sposto velocemente verso la cucina col vaso in mano e lungo il corridoio cadono in terra dei vermi che si moltiplicano in grande quantità […]”. È immediata la sua associazione tra i vermi, con la loro capacità moltiplicatoria, e le metastasi.
Nella seduta del 3 luglio 2000, dunque in analisi da poche settimane e a quaranta giorni dalla seconda mastectomia, registro da parte sua una preoccupazione che nel tempo, come vedremo, si rivelerà purtroppo profetica: la preoccupazione di sviluppare metastasi cerebrali. Il primo trimestre del 2002 è anche l’ultimo del nostro lavoro analitico formale. A gennaio trova in casa un referto del Policlinico, risalente a qualche tempo prima, in cui si parla esplicitamente di metastasi ossee, epatiche e cutanee. Il 21 marzo, giorno del suo quarantanovesimo compleanno, uscendo dallo studio, subisce un piccolo tamponamento. Come spesso accade – in omaggio, potremmo dire, alla teoria delle catastrofi [8] – un piccolo accadimento posto in coda a un cumulo di eventi fa precipitare la situazione.
L. viene colta da vertigini crescenti e una RMN rivela metastasi cerebrali puntiformi. Quella del 21 marzo 2002 sarà la nostra ultima seduta. Tuttavia il nostro rapporto non si interrompe del tutto. Tra un ricovero e l’altro, L. mi aggiorna telefonicamente sulla sua situazione. Insieme ad un certo allentamento della presa dell’ego, legato alla consapevolezza del poter non esserci da un momento all’altro, è come se ella percepisse il miracolo dell’esserci: pur nell’impossibilità di continuare un rapporto analitico formale, permane una ricerca di senso. Ha in animo di scrivere, sotto forma di dialoghi e lettere alla figlia, “Memorie di un’ex paziente oncologica”. Non farà in tempo a mettere in atto il suo proposito; ma prima di morire mi dice: “Io spero che lei possa scrivere la mia storia, perché io non ne ho la forza”. Terrò fede alla sua richiesta, producendo un saggio sul suo caso a suggello della mia formazione analitica.
“Signore, dà a ciascuno la sua morte,
la morte che da quella vita viene,
in cui ebbe amore, anima, angoscia.
Perché noi siamo solo guscio e foglia.
La grande morte che ciascuno ha in sé
È il frutto intorno a cui tutto si svolge”
(Rainer Maria Rilke- Il libro d’ore, 1905)
__________NOTE__________
- Dobbiamo la cogente distinzione tra körper e leib a Edmund Husserl (1859-1938), filosofo e matematico austriaco naturalizzato tedesco, fondatore della fenomenologia.
- A proposito di mano, non è fuori luogo mettere in evidenza la sapienza della lingua tedesca, nella quale cura si dice behandlung, termine che contiene, come si vede, un chiaro cenno alla mano che indaga e che guarisce. Voglio ricordare en passant la scelta di Samuel Hahnemann, futuro padre dell’Omeopatia, di concludere la sua formazione pre-universitaria, nel 1775, pronunciando una dissertazione finale “sulla meravigliosa conformazione della mano dell’uomo”.
- Sándor Ferenczi (1873-1933) è stato uno psichiatra ungherese, tra i pionieri della psicoanalisi nel suo Paese.
- La PRM, una evoluzione dell’Omeopatia sviluppatasi negli ultimi decenni, utilizza a seconda dei casi ormoni, neurotrasmettitori e citochine low dose, allo scopo di riequilibrare i sistemi regolatori dell’organismo (nervoso, immunitario, endocrino).
- Desidero ringraziare qui la dottoressa Irene Rosafio, medico palliativista, per avere ampliato il mio orizzonte di medico, attraverso il suggerimento di testi e soprattutto mettendomi a parte del suo prezioso lavoro in hospice.
- In precedenza ho fatto cenno alla cancerofobia collettiva come causa di diagnosi tardive.
- Coincidenza curiosa, il 10 aprile è il giorno della nascita di Samuel Hahnemann.
- La teoria delle catastrofi, elaborata dal matematico René Thom (1923-2002) negli anni ’50-‘60, costituisce un originale tentativo di applicare la matematica ai fenomeni naturali; tra i fenomeni naturali rientrano anche attività specificamente umane.
Bibliografia
Bongiorno, A. – Malizia, S.: Comunicare la diagnosi grave. Il medico, il paziente e la sua famiglia, Carocci, Roma 2002.
Campione, F.: Per l’Altro. Tempismo assistenziale, modalità di coinvolgimento e accoglienza del dolore nelle cure palliative, Asmepa Edizioni, Bentivoglio (BO) 2014.
Curi, U.: Le parole della cura. medicina e filosofia, Raffaello Cortina Editore, Milano 2017.
De Torrebruna, R. – Turinese, L.: Hahnemann. Vita del padre dell’omeopatia. Sonata in cinque movimenti, Edizioni Efesto, Roma 2020.
Maciocco, G.: Il medico che ti salva la vita, www.saluteinternazionale.info, 27/11/2017.
Pellegrino, F.: La comunicazione in medicina, Mediserve, Milano 2004.
Polvani, S.: Cura alle stelle. Manuale di salute narrativa, Emmebi Edizioni, Firenze 2016.
Rinnenburger, D.: La cronicità. Come prendersene cura, come viverla, Il Pensiero Scientifico Editore, Roma 2019.
Sacks, O. (1985): L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello, Adelphi, Milano 1986.
Tatarelli, R. – De Pisa, E. – Girardi, P.: Curare con il paziente. Metodologia del rapporto medico-paziente, FrancoAngeli, Roma 1998.
Turinese, L.: Modelli psicosomatici. Un approccio categoriale alla clinica, Elsevier-Masson, Milano 2009.






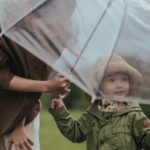
0 commenti