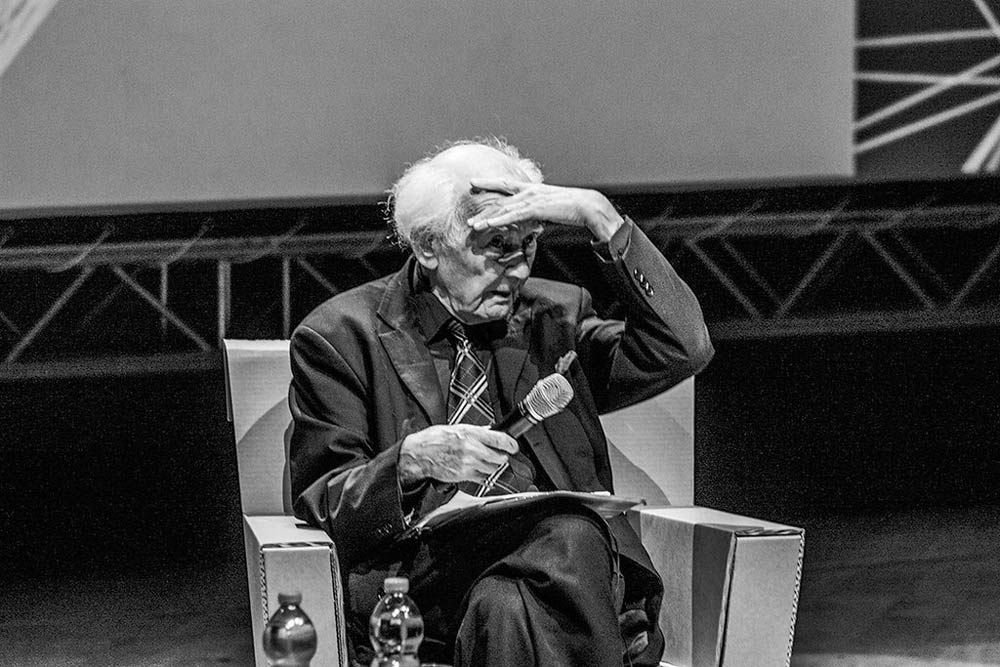Zygmant Bauman (1925-2017), è stato un fervido intellettuale, ebreo polacco poi emigrato in Inghilterra, versatile e intuitivo, paladino dell’importanza della sociologia nella comprensione della modernità come il contesto implicito di ciò che a partire da essa sono divenuta la politica, i costumi, l’arte, la letteratura.
La modernità è ciò che ha reso possibile l’Olocausto: la sua razionalità ed il primato della tecnica, dietro il mito della neutralità e del disincanto, rendono sempre possibile il riaffiorare del male. La celebre definizione di Bauman, della modernità come liquida, rende al tempo stesso misura di come debba modificarsi e fluidificarsi la nostra intelligenza delle cose, ma anche di come la velocità idolatrata dalla vita moderna corrisponda ad un intenso oblio di ciò che conta e ad una mancanza di resistenza verso la banalità di un flusso che consuma tutto nell’indifferenza. Ogni trauma può venir risucchiato in un’abitudine desensibilizzante.
In un mondo liquido anche il male diviene liquido, camuffandosi persino sotto un’apparenza di bontà ed amore, ma facendosi strada nella presunta assenza o addirittura impossibilità di un’alternativa.
Modernità liquida
Nella prefazione ad una nuova edizione (2011) del testo Modernità liquida (del 2000), Bauman considera la liquidità una sorta di interregno, un luogo dall’esito indefinibile del proteico e rapido ma inconcludente continuo cambiar forma della modernità. Si è ancora indefinitamente moderni e postmoderni al tempo stesso, senza un punto di svolta. “È stato il carattere informe del liquido che filtrava/colava/fluiva a produrre i tentativi di raffreddare/condensare/modellare”. Ma nessun tentativo ha avuto effetti significativi. “La flessibilità è subentrata alla solidità come stato ideale delle cose e delle relazioni.”
“La modernità nel suo insieme si distingue dalle epoche precedenti per la modernizzazione compulsiva/ossessiva: e modernizzare significa liquefare, fondere, estrarre”. La modernizzazione non è più “un percorso con una meta predefinita, un movimento destinato ad esaurirsi una volta finito il lavoro”, ma un incessante cambiamento senza più senso.
“Siamo tutti irrefrenabilmente a caccia di novità.” In un mondo che peraltro reitera in forme sempre nuove ingiustizie e diseguaglianze. Nel trionfo del consumatore ideale arretra ogni altro più solido diritto. La libertà non è mai raggiunta, ma la spinta alla libertà crea necessariamente divisioni. Le ineguaglianze sociali farebbero arrossire di vergogna gli inventori del progetto moderno.
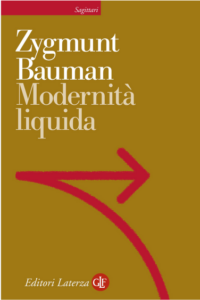 Il potere, inteso come capacità di fare, si sta emancipando dalla politica, intesa come capacità di decidere che cosa fare.
Il potere, inteso come capacità di fare, si sta emancipando dalla politica, intesa come capacità di decidere che cosa fare.
Migliorare la vita viene inteso come poter consumare di più. Ma il nostro consumo – come scrive Tim Jackson (in Prosperità senza crescita, 2009) citato da Bauman – «è insostenibile dal punto di vista ecologico, problematico da quello sociale e instabile da quello economico»
Il sentimento dominante è l’incertezza. “L’incertezza è il risultato combinato del sentimento di ignoranza (impossibilità di sapere ciò che accadrà) e di impotenza (impossibilità di evitare che accada) e di una paura sfuggente e diffusa, definita in modo vago e difficile da localizzare: una paura che fluttua alla disperata ricerca di un punto fermo”.
Un’altra conseguenza della globalizzazione come liquidità è il métissage e l’ibridazione culturale, che dovrebbe ridefinire le identità nazionali ma viene sempre più vissuta come una minaccia, generando pulsioni reazionarie di respingimento e di marginalizzazione di migranti e profughi.
Nella conclusione della Prefazione Bauman sembra auspicare che nuove forme di comunitarismo rimodulino la ricerca della felicità, dove le decisioni non siano prese solo in nome del profitto. La sostenibilità ambientale dipende forse da “una comunicazione intra-comunitaria all’insegna dell’onestà e della sincerità, del biasimo e del riconoscimento, del rispetto degli altri e degli spazi comuni e di altri espedienti a zero consumo di energia e zero produzione di rifiuti come di risposte umane assolutamente plausibili e quasi istintive alle sfide dell’esistenza”.
Imparare a camminare sulle sabbie mobili
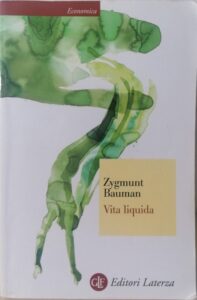 I missili intelligenti apprendono mentre si spostano. La formazione e l’apprendimento devono oggi, scrive Bauman in un piccolo saggio intitolato Vita liquida (2008), ragionare non più in termini di missili balistici, dove il bersaglio è predeterminato e calcolabile, ma in funzione di missili intelligenti, che non hanno obiettivi stabiliti ma scelgono i loro bersagli in volo, adattandosi di volta in volta. “Nell’ambiente liquido – moderno la formazione e l’apprendimento, perché siano utili, devono essere continui, anzi permanenti, cioè protrarsi per tutta la vita.”
I missili intelligenti apprendono mentre si spostano. La formazione e l’apprendimento devono oggi, scrive Bauman in un piccolo saggio intitolato Vita liquida (2008), ragionare non più in termini di missili balistici, dove il bersaglio è predeterminato e calcolabile, ma in funzione di missili intelligenti, che non hanno obiettivi stabiliti ma scelgono i loro bersagli in volo, adattandosi di volta in volta. “Nell’ambiente liquido – moderno la formazione e l’apprendimento, perché siano utili, devono essere continui, anzi permanenti, cioè protrarsi per tutta la vita.”
Nella società dei consumatori – scrive Bauman ne Le sfide all’istruzione nella modernità liquida (2011) – il tempo non è né ciclico né lineare: “È al contrario pointillist, “puntinista”, frantumato in una moltitudine di pezzetti distinti, ciascuno ridotto a un punto che si avvicina sempre più alla sua idealizzazione geometrica di non – dimensionalità.” Ogni punto contiene infinite possibilità ed un potenziale infinito di espansione.
Per il consumatore avido di nuove esperienze, l’importante è saper scartare e sostituire. C’è d’altronde un surplus di informazioni, che finisce per relegarle tutte in una sorta di rumore di sottofondo.
Nessun oggetto appare finalmente degno di preferenza, tutto viene percepito con un atteggiamento un po’ blasè e malinconico. “In un mondo del genere, si è pertanto costretti a prendere la vita un pezzo alla volta, come viene, aspettandosi che ogni pezzetto sia diverso dai precedenti e richieda conoscenze e competenze differenti.”
“L’arte del navigare in superficie ha vinto l’arte del comprendere”.
 I giovani devono peraltro essere educati ad un mondo che non è più come prima teatro di solide conquiste, ma incerto ed infermo come le sabbie mobili. “Nulla li ha preparati all’arrivo di un mondo nuovo, duro, inospitale e per nulla invitante: il mondo della retrocessione dei gradi, della svalutazione dei meriti acquisiti, delle porte aperte e poi chiuse, della volatilità dei posti di lavoro e della testardaggine dei disoccupati, della fugacità delle prospettive e della persistenza delle sconfitte; il nuovo mondo di progetti falliti sul nascere, di speranze vanificate e di opportunità che spiccano per la propria assenza.”
I giovani devono peraltro essere educati ad un mondo che non è più come prima teatro di solide conquiste, ma incerto ed infermo come le sabbie mobili. “Nulla li ha preparati all’arrivo di un mondo nuovo, duro, inospitale e per nulla invitante: il mondo della retrocessione dei gradi, della svalutazione dei meriti acquisiti, delle porte aperte e poi chiuse, della volatilità dei posti di lavoro e della testardaggine dei disoccupati, della fugacità delle prospettive e della persistenza delle sconfitte; il nuovo mondo di progetti falliti sul nascere, di speranze vanificate e di opportunità che spiccano per la propria assenza.”
Molti laureati oggi finiscono per avere obiettivi alti, ma pochi mezzi ed occupazioni precarie. L’istruzione non è più garanzia di ascesa sociale. Ma l’istruzione rimane tuttavia un catalizzatore di cambiamento.
Farmaci e malattie
Un altro effetto perverso della liquidità è stato quello di trasformare la condizione di malattia – che è un disagio, un malessere ed un malanno – ad una patologia che presuppone l’azione e l’intervento medico. “Il fatto di star male è definito dalla circostanza di esser soggetto a, avere i requisiti per ed esigere un intervento di tipo medico”.
In questo contesto le società farmaceutiche, più ancora che creare farmaci per curare disturbi, promuovono disturbi che si adattano ai loro farmaci. Ciò secondo la pratica commerciale ormai universale, che tende ad indurre dei bisogni fittizi ed a creare la domanda che occorre al suo profitto.
L’ingegnosità delle ditte farmaceutiche si adatta alla nostra società di consumatori, sostituendo come obiettivo il fitness a quello di salute. “Mentre la percezione dello stato di salute non ha soltanto un limite minimo, ma anche un limite massimo – il cui raggiungimento ci permette di rilassarci –, la qualità di benessere [fitness] che è subentrata a sostituirla o a spingerla in secondo piano fra le preoccupazioni contemporanee non ha limiti”. “Per quanto possiate stare bene, potreste sempre stare meglio”.
“Fastidi che la maggior parte di noi è abituata a tollerare regolarmente, quasi quotidianamente (come il bruciore di stomaco, il gonfiore premestruale o – addirittura – la comune mancanza di autostima che si manifesta come timidezza), sono stati recentemente classificati come disturbi… tali da richiedere l’intervento urgente di un medico”. A infinite delusioni degli acquirenti corrispondono comunque infiniti guadagni dei promotori di nuovi farmaci.
La società dei consumatori non ha un’etica e crea diseguaglianze. Se il benessere diviene un privilegio per ricchi, i livelli essenziali di salute non sono garantiti ai più poveri.
L’Etica dell’Ospitalità
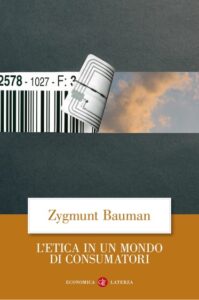 L’etica è ospitalità: in un altro suo breve saggio intitolato L’etica in un mondo di consumatori (2008), Bauman cita Derrida che dà risalto ad uno scritto poco noto di Kant del 1784: Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico. Se il nostro pianeta è sferico – riflette Kant – ogni movimento di allontanamento è a sua volta un movimento di avvicinamento, come se la Natura stessa nelle nostre relazioni nel mondo ci spingesse ad un’unica cittadinanza mondiale come orizzonte ultimo della nostra storia universale.
L’etica è ospitalità: in un altro suo breve saggio intitolato L’etica in un mondo di consumatori (2008), Bauman cita Derrida che dà risalto ad uno scritto poco noto di Kant del 1784: Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico. Se il nostro pianeta è sferico – riflette Kant – ogni movimento di allontanamento è a sua volta un movimento di avvicinamento, come se la Natura stessa nelle nostre relazioni nel mondo ci spingesse ad un’unica cittadinanza mondiale come orizzonte ultimo della nostra storia universale.
La modernità, se non può non essere liquida, dovrebbe poter essere solidale.
Fonte immagini: MEET Digital Culture Centre